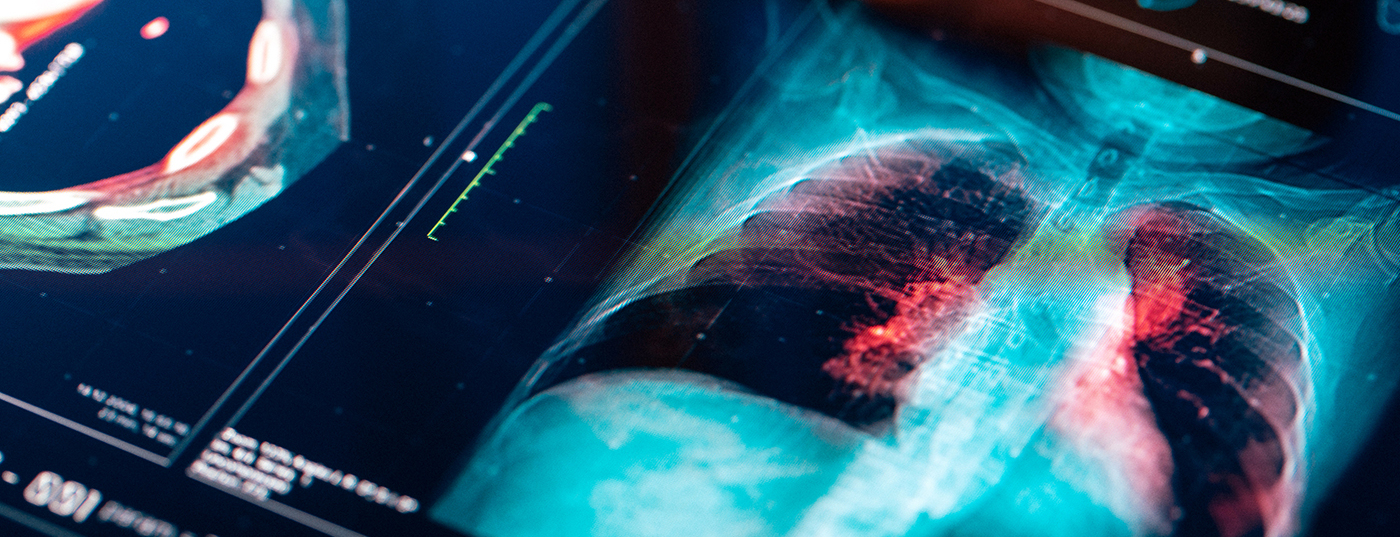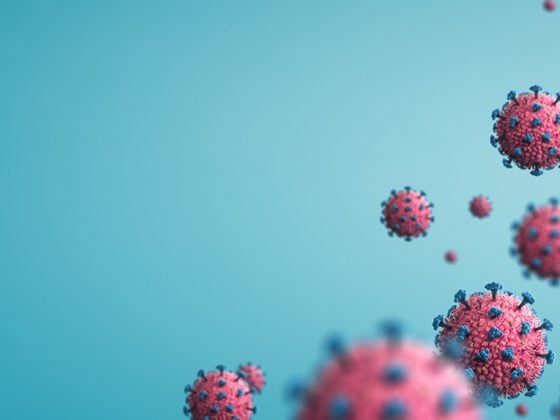Presso l’Ospedale Universitario di Tubinga, uno studio preclinico guidato dal Dr. Clemens Hinterleitner e dal Prof. Dr. Lars Zender, Direttore Medico di Oncologia Medica e Pneumologia, ha portato a risultati estremamente promettenti. Il gruppo di ricerca è stato in grado di sviluppare una nuova metodologia che permette di prevedere meglio le probabilità di successo delle immunoterapie per il cancro al polmone. Il nuovo studio dal titolo originale “Platelet PD-L1 reflects collective intratumoral PD-L1 expression and predicts immunotherapy response in non-small cell lung cancer” (Il PD-L1 piastrinico riflette l’espressione collettiva di PD-L1 intratumorale e predice la risposta all’immunoterapia nel carcinoma polmonare non a piccole cellule) è stato pubblicato di recente sulla rinomata rivista scientifica “Nature Communications”.
Con 1,8 milioni di decessi all’anno, il cancro al polmone è uno dei tumori più comuni e più letali al mondo. Solo in Germania, circa 45.000 persone sono morte a causa della malattia nel 2019. Grazie a terapie oncologiche innovative, come le cosiddette immunoterapie “basate sugli inibitori del checkpoint”, le opzioni di trattamento per i tumori polmonari sono migliorate negli ultimi anni. Questi trattamenti si basano sul blocco di alcune vie di segnalazione all’interno del nostro sistema immunitario, provocando così una reazione di difesa contro le cellule tumorali. Questi checkpoint si basano sui cosiddetti recettori e molecole di superficie, come PD-1 o PD-L1. Attraverso l’inibizione specifica di queste molecole mediata da anticorpi, il sistema immunitario riconosce il tumore come nemico e lo attacca. Grazie a questo concetto terapeutico, è possibile ottenere un contenimento del tumore in circa il 20 percento di tutti i pazienti con tumore al polmone.
“Nonostante questo successo, non esiste ancora un metodo facile da usare per prevedere quali pazienti risponderanno all’immunoterapia”, spiega il dottor Clemens Hinterleitner. Non tutte le persone colpite rispondono ugualmente bene alla terapia, possono verificarsi effetti collaterali indesiderati e l’immunoterapia è estremamente costosa. Lo sviluppo del nuovo processo è ancora più gratificante. “Abbiamo scoperto che le piastrine, cioè le cellule del sangue che entrano in contatto con la cellula tumorale, assumono la molecola PD-L1. Il nostro studio è riuscito a dimostrare che la quantità di piastrine caricate con PD-L1 è un ottimo indicatore del fatto che l’immunoterapia con anticorpi bloccanti PD-1 o PD-L1 nel tumore polmonare sia promettente o meno”, afferma il dottor Hinterleitner.
La presenza di PD-L1 sulla cellula tumorale è uno dei prerequisiti di base per il successo dell’immunoterapia con anticorpi bloccanti PD-1 o PD-L1. Prima di prendere in considerazione l’immunoterapia, viene effettuato un prelievo di sangue dai pazienti con un tumore al polmone. In laboratorio, si determina poi se ci sono sufficienti molecole PD-L1 sulla superficie delle piastrine del sangue, per poter valutare meglio se l’immunoterapia del cancro è promettente in questo caso.
“Le piastrine circolano nel nostro flusso sanguigno migliaia di volte al giorno e inevitabilmente entrano in contatto con le cellule tumorali eventualmente presenti. Assumendo la molecola PD-L1, sono particolarmente adatti come biomarcatore in grado di prevedere la risposta di una terapia con inibitori del checkpoint in modo estremamente valido”, aggiunge il Prof. Dr. Lars Zender. Anche se esistono già dei metodi per prevedere la risposta all’immunoterapia, come la cosiddetta colorazione immunoistochimica. In questo caso, viene prelevata una biopsia del tumore e viene eseguita la colorazione delle strutture cellulari o tissutali con coloranti accoppiati ad anticorpi. Una proprietà molto specifica del tessuto innesca quindi una reazione antigene-anticorpo. “Il problema degli studi sul materiale bioptico, tuttavia, è che i tumori sono molto eterogenei e che una singola biopsia non riflette adeguatamente la totalità del tumore. Rispetto alle procedure immunoistochimiche esistenti, la metodologia con le piastrine ha una prevedibilità molto migliore”, spiega il Prof. Zender.
Con il Cluster di Eccellenza iFIT, l’unico cluster oncologico di eccellenza in Germania, e la nomina di Tubinga come nuovo sito del Centro Nazionale per le Malattie Tumorali (NCT), sono disponibili le condizioni ottimali per approfondire questi promettenti risultati e validarli in uno studio multicentrico.
Pubblicazione originale:
DOI: 10.1038/s41467-021-27303-7
La pubblicazione è disponibile al seguente link: https://www.nature.com/articles/s41467-021-27303-7