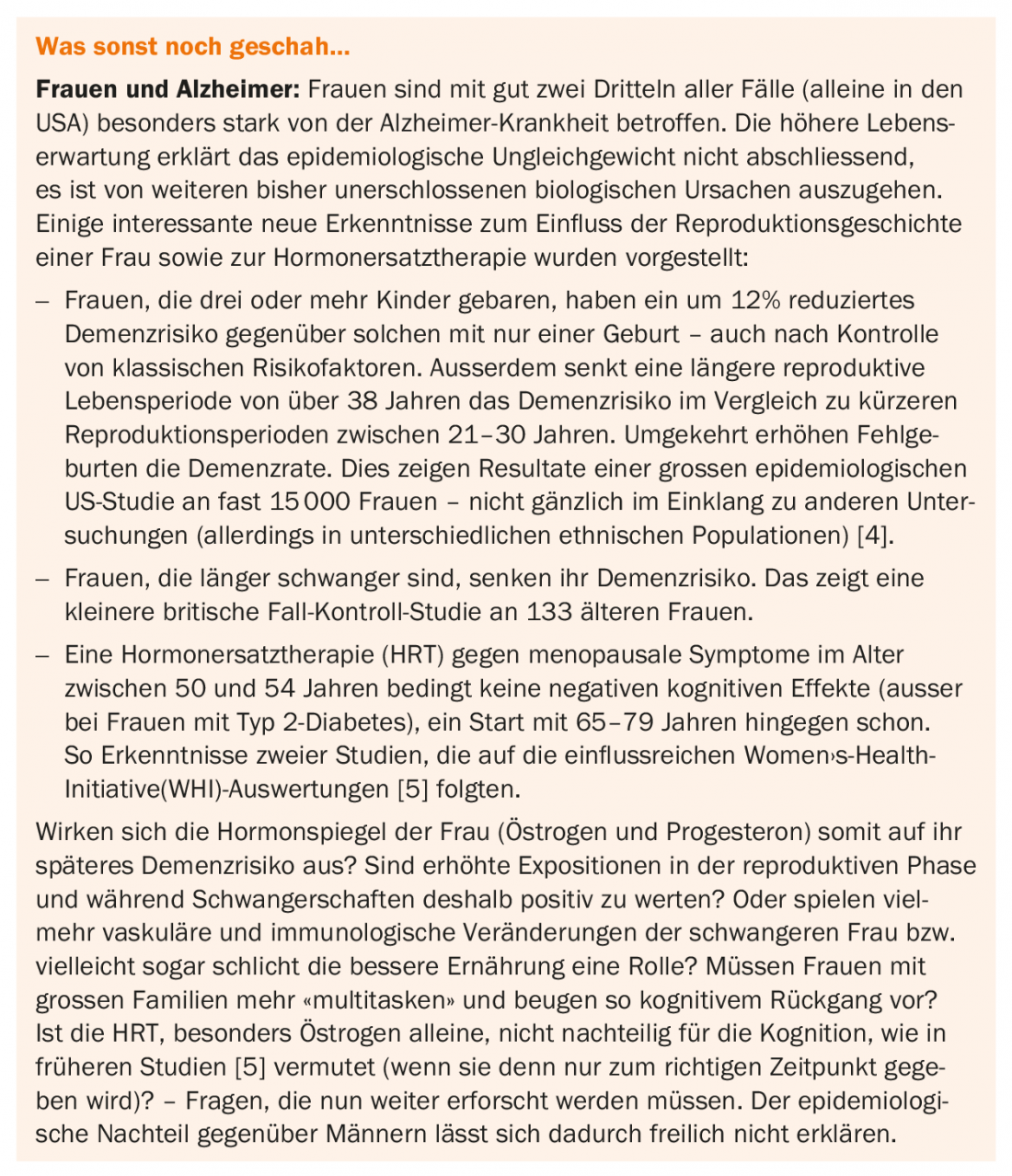Sono state fatte molte ricerche nel campo della malattia di Alzheimer. Tuttavia, ad oggi, nessun candidato farmaco ha tradotto in modo convincente la lotta contro la beta-amiloide in benefici cognitivi in tutte le fasi di studio. E il nuovo principio attivo BAN2401?
Dalle vaccinazioni, cioè le immunizzazioni attive e passive con anticorpi, allo sviluppo di vari inibitori della secretasi – il costante fallimento di numerosi approcci terapeutici basati sull’ipotesi amiloide condiziona un’elevata tolleranza alla frustrazione non solo dei medici e dei pazienti, ma anche delle aziende farmaceutiche attive nel campo della malattia di Alzheimer. Non sorprende quindi che alcuni importanti attori stiano già voltando le spalle al fastidioso “figliastro” delle malattie della civiltà e interrompendo le loro attività di ricerca in questo settore. Gli esperti si chiedono anche se la teoria tradizionale della patogenesi dell’Alzheimer, vecchia di oltre 20 anni, che gode comunque di un enorme sostegno nel mondo scientifico, sia davvero così accurata come si è ipotizzato a lungo. Negli ultimi anni, la ricerca sull’Alzheimer ha affrontato sempre più domande critiche [1,2]: la deposizione di amiloide e la neurodegenerazione sono forse due fenomeni indipendenti e non correlati, quindi in futuro l’attenzione dovrà essere sempre più rivolta alla patologia tau? Il primo è un fenomeno prevalentemente anagrafico? È per questo che la malattia può essere rallentata così tanto nonostante l’intervento sulla cascata amiloide postulata? Oppure gli oligomeri solubili, cioè le forme meno aggregate delle proteine beta-amiloidi, giocano il ruolo decisivo invece dei depositi più grandi (placche)? Il trattamento negli studi terapeutici è stato iniziato forse troppo tardi o troppo tardi? la popolazione target è stata scelta in modo errato? Oppure potrebbe semplicemente non funzionare perché era troppo poco (o erroneamente) selettivo, sia nell’area delle secretasi o anche delle varie forme di aggregazione amiloide, come gli oligomeri o le fibrille più grandi?
Domande su domande. Una cosa è certa: ci sono persone prive di sintomi con depositi di amiloide (osservati, ad esempio, nelle autopsie) e, al contrario, pazienti affetti da Alzheimer con solo alcuni di questi depositi. In età avanzata, si manifestano sia in persone non dementi che in persone dementi, in alcuni casi anche nella stessa misura. Tra l’altro, i progressi della diagnostica per immagini lo hanno reso evidente. Non è possibile stabilire una chiara correlazione lineare tra i depositi e il deterioramento cognitivo. Inoltre, non tutta l’amiloide è uguale: si presenta come monomero, ma può anche assemblarsi in oligomeri e infine in fibrille o placche. I processi potrebbero essere coinvolti nel decorso della malattia in misura variabile, e alcuni potrebbero anche avere un effetto protettivo. A causa delle nuove scoperte, la ricerca si sta attualmente concentrando sugli oligomeri e sui polifenoli. con gli intermedi delle fibrille e delle placche amiloidi più grandi. Sono considerati particolarmente tossici (ipotesi dell’oligomero), mentre le placche stesse sono viste da alcuni autori come ‘tamponi’ protettivi contro gli oligomeri tossici, nel senso di serbatoi ampiamente innocui.
Un altro concorrente rischia di fallire
Tuttavia, BAN2401, un nuovo candidato anticorpo che si lega selettivamente agli intermediari tossici delle fibrille amiloidi e li elimina, ossia le protofibrille beta-amiloidi solubili, non poteva aspettarsi alcun apprezzamento anticipato. Troppe cose sono andate storte nel campo della ricerca sui farmaci per l’Alzheimer negli ultimi anni. E infatti, a dicembre 2017, il produttore annuncia anche un fallimento dell’endpoint primario del suo studio randomizzato e controllato di fase II dopo dodici mesi per BAN2401. Tuttavia, lo studio è rimasto in cieco fino all’analisi finale dopo 18 mesi, e al congresso c’erano ancora uno o due segnali positivi da segnalare dagli endpoint secondari (sebbene lo studio non fosse alimentato per la prova definitiva dell’efficacia dei risultati cognitivi). Il campione era composto da 856 pazienti con MCI dovuto a malattia di Alzheimer o demenza di Alzheimer lieve e patologia amiloide (161 pazienti avevano ricevuto la dose massima):
- Le riduzioni delle placche amiloidi sono state dose-dipendenti e significative.
- Entro 18 mesi, l’anticorpo nella dose più alta ha ridotto l’accumulo di amiloide nel cervello da 74,5 a 5,5 (nella PET standardizzata sulla scala centiloide con 100 punti per i “pazienti tipici di AD” e 0 per i “pazienti probabilmente amiloidi-negativi”). L’81% di tutti i pazienti precedentemente positivi all’amiloide sono stati considerati negativi all’amiloide dopo 18 mesi (p<0,0001).
- Il declino cognitivo clinico nel nuovo endpoint sviluppato internamente ADCOMS (Alzheimer’s Disease Composite Score) è rallentato in modo dipendente dalla dose.
- Anche se il criterio richiesto per il successo dopo dodici mesi, cioè almeno l’80% di probabilità di un rallentamento del declino cognitivo (ADCOMS) di almeno il 25% rispetto al placebo, non è stato raggiunto (endpoint primario): Già dopo sei e dodici mesi, la dose più alta ha mostrato un declino cognitivo significativamente rallentato rispetto al placebo (p<0,05), che persisteva fino alla fine del periodo di studio dopo 18 mesi (rallentata del 30% alla dose più alta, p=0,034). Quest’ultima si applica anche alla sottoscala cognitiva dell’Alzheimer’s Disease Assessment Scale (ADAS-Cog; dose-dipendente, rallentata del 47% alla dose più alta, p=0,017) e al CDR-SB (Clinical Dementia Rating Sum of Boxes; dose-dipendente, rallentata del 26% alla dose più alta).
- Il profilo di sicurezza è stato accettabile, per quanto riguarda le anomalie di imaging (ARIA) associate all’amiloide (edema alla dose più alta: 9,9%, che ha portato al ritiro dallo studio per questi pazienti) e gli effetti collaterali dell’infusione stessa. Gli eventi avversi gravi non sono stati riscontrati con maggiore frequenza rispetto al placebo, anche alla dose più alta.
Resta da vedere se questi segnali positivi sono sufficienti per spingere il produttore ad andare avanti con lo sviluppo. Lo studio è stato visto in modo critico anche al congresso. Dopo molte battute d’arresto, tuttavia, questo è almeno il secondo studio clinico e il primo grande studio sull’Alzheimer che può combinare la lotta contro la beta-amiloide (clearance) con effetti cognitivi positivi. Vale quindi la pena di perseguire l’approccio amiloide? Sarà uno dei diversi percorsi terapeutici all’interno dei trattamenti combinati in futuro? Si vedrà. Anche un altro candidato in questo campo, l’aducanumab – co-sviluppato dallo spin-off dell’UZH “Neurimmune” – ha mostrato risultati iniziali promettenti [3]; i risultati di due grandi studi di follow-up sono attesi nel 2020.
Fonte: Conferenza internazionale dell’Associazione Alzheimer (AAIC), 22-26 luglio 2018, Chicago.
Letteratura:
- Verma M, Vats A, Taneja V: Specie tossiche nei disturbi amiloidi: oligomeri o fibrille mature. Ann Indian Acad Neurol 2015 Apr-Giu; 18(2): 138-145.
- Kametani F, Hasegawa M: Riconsiderazione dell’ipotesi amiloide e dell’ipotesi Tau nella malattia di Alzheimer. Front Neurosci 2018; 12: 25.
- Sevigny J, et al: L’anticorpo aducanumab riduce le placche Aβ nella malattia di Alzheimer. Natura 2016 Sep 1; 537(7618): 50-56.
- Jang H, et al: Effetti differenziali delle gravidanze completate e incomplete sul rischio di malattia di Alzheimer. Neurologia 2018 Jul 18. DOI: 10.1212/WNL.00000000006000 [Epub ahead of print].
- Shumaker SA, et al: Estrogeni più progestinici e l’incidenza di demenza e lieve deterioramento cognitivo nelle donne in postmenopausa: il Women’s Health Initiative Memory Study: uno studio randomizzato controllato. JAMA 2003 28 maggio; 289(20): 2651-2662.
InFo NEUROLOGY & PSYCHIATRY 2018; 16(5): pubblicato il 15 agosto 2018 (in anticipo sulla stampa).