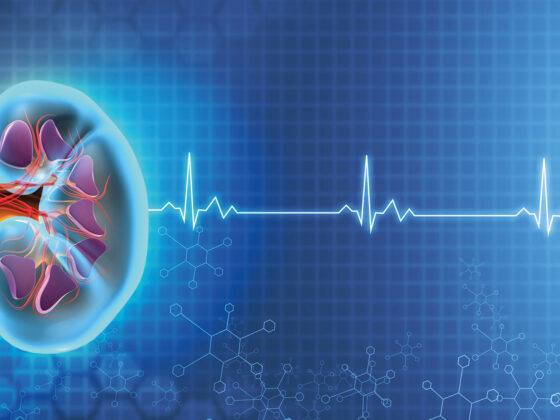Il DGN di quest’anno si è concentrato sulle malattie neurodegenerative, dato che in quest’area si sono registrati molti sviluppi. All’orizzonte si profilano approcci terapeutici promettenti e la ricerca biologica molecolare ha fornito importanti approfondimenti sui pato-meccanismi, consentendo di sviluppare opzioni diagnostiche più precise e precoci e approcci terapeutici mirati. Ma c’era anche molto da scoprire oltre a questo.
(rosso) La nuova linea guida sulla malattia di Parkinson è qui [1]. Tuttavia, è stato declassato da S3 a S2k. Lo sfondo di tutto ciò era la considerazione più ampia di diversi aspetti dell’assistenza. Tuttavia, la rivalutazione dei farmaci e l’assistenza nella scelta dei preparati in determinate situazioni sono rimaste al livello S3. Poiché sta diventando sempre più chiaro che la malattia di Parkinson idiopatica ha spesso una causa genetica, gli autori hanno deciso di riferirsi ad essa semplicemente come malattia di Parkinson in futuro. Per quanto riguarda la diagnostica, in futuro dovrebbero essere utilizzati i criteri MDS 2015 invece della “Parkinson’s UK Brain Bank”, grazie alla loro migliore sensibilità e specificità. Nel corso successivo, si aggiunge la valutazione delle fluttuazioni motorie e della discinesia per aumentare l’affidabilità della diagnosi. Se si sospetta una fase prodromica della malattia di Parkinson, si raccomanda di utilizzare criteri prodromici definiti (ad esempio, un test olfattivo), di utilizzare la risonanza magnetica cranica (RM) nella diagnosi precoce e di eseguire un esame polisonnografico nel laboratorio del sonno per i disturbi del comportamento del sonno REM specifici della malattia di Parkinson. Se si sospetta clinicamente, è necessario eseguire una risonanza magnetica cranica. La gestione del trattamento deve essere precoce, adeguata all’età e personalizzata. Vengono fornite raccomandazioni dettagliate per l’uso combinato differenziato delle sostanze adatte, ma viene lasciato anche un ampio margine di manovra. Pertanto, la priorità degli inibitori MAO-B, degli inibitori COMT o degli agonisti della dopamina per le fluttuazioni sotto levodopa non è possibile in base alla situazione dello studio. Si raccomanda di offrire gli inibitori MAO-B per ridurre i tempi morti. Tuttavia, sono possibili anche gli inibitori della COMT e gli agonisti della dopamina (ad eccezione dell’Ergolina-DA). Possono essere utilizzate anche iniezioni di apomorfina o apomorfina sublinguale. Alle raccomandazioni è stata aggiunta anche la levodopa solubile ad azione rapida. Inoltre, sono elencate anche le sostanze non più raccomandate. Sono stati inclusi anche nuovi capitoli sulla terapia con pompe, sul delirio e sul trattamento dei disturbi autonomici.
Fisiopatologia della malattia di Parkinson
La malattia di Parkinson (PD) deriva dalla morte dei neuroni produttori di dopamina nella substantia nigra ed è caratterizzata da un accumulo anomalo della proteina alfa-sinucleina. Il segno distintivo neuropatologico della PD è l’accumulo e l’aggregazione anormale della proteina alfa-sinucleina (α-Syn) sotto forma di corpi di Lewy e neuriti di Lewy. È noto che l’aggregazione patologica di α-Syn è una caratteristica comune a diverse malattie neurodegenerative – tra cui la PD, la demenza a corpi di Lewy (DLB) e l’atrofia sistemica multipla (MSA), definite collettivamente sinucleinopatie. Uno studio ha ora analizzato quali aspetti biochimici interferiscono con i disturbi conformazionali dell’alfa-sinucleina da una prospettiva di fisica nucleare [2].
Le proprietà strutturali della proteina alfa-sinucleina legata all’ubiquitina e alla dopamina sono state determinate utilizzando metodi di struttura elettronica basati sulla densità e sulla funzione d’onda, per valutare la capacità dei campi di forza ab initio. Utilizzando la Dinamica Molecolare (MD) e le simulazioni Monte Carlo, sono state analizzate le disfunzioni dei sistemi proteasomale e lisosomiale nella fisiopatologia della malattia di Parkinson. È stato scoperto che l’alfa-sinucleina, una proteina legata all’ubiquitina, si accumula nei neuroni e che questo accumulo compromette la funzione cellulare. Le variazioni locali dell’angolo di torsione phi e psi dell’alfa-sinucleina indicano che le perturbazioni nella sintesi proteica e le deformazioni nell’anfipatico N-terminale, nell’idrofobico centrale e in una regione altamente acida e ricca di proline di questa proteina possono interrompere il percorso biosintetico e metabolico della dopamina. La deplezione di dopamina e i problemi sinaptici possono essere innescati da disturbi conformazionali dell’alfa-sinucleina.
Diagnosi precoce dell’Alzheimer
Le nuove terapie mirate al trattamento causale della malattia di Alzheimer (AD) sottolineano sempre più l’importanza dei metodi di diagnosi precoce. L’esame neuropsicologico, che è facilmente disponibile, poco oneroso e conveniente, continua ad essere centrale. L’approccio “Testing the Limits (TtL)” si è rivelato particolarmente adatto, in quanto consente di registrare direttamente la ridotta riserva cognitiva nell’AD in una fase molto precoce. Con una sensibilità del 93% e una specificità dell’80%, il paradigma TtL, un test di memoria visiva che abbiamo utilizzato finora, distingue già in modo molto affidabile tra i sospetti di demenza, i depressi e gli anziani sani. Tuttavia, si può ipotizzare che la selettività possa essere ulteriormente aumentata variando la risoluzione e la luminosità delle immagini. Per indagare su questo aspetto, è stata sviluppata una versione del test che permetteva per la prima volta una variazione sistematica della luminanza e del contrasto [3]. La procedura consisteva in un pre-test e due post-test e utilizzava come stimoli immagini in bianco e nero simili a fumetti presentate su un PC. Ogni subtest comprendeva un’unità di apprendimento e una di riconoscimento, che contenevano 60 immagini distrattive oltre ai 20 modelli di apprendimento. Il tempo di presentazione per ciascuno dei modelli di apprendimento era di 15 secondi, senza limiti di tempo per il riconoscimento. Il numero di errori di riconoscimento nel post-test 1 e nel post-test 2 è stato utilizzato come misura della plasticità cognitiva. Nella fase di codifica dei tre subtest, le immagini sono state presentate nella forma originale ottimamente luminosa e contornata. Secondo i dati finora disponibili, i soggetti di controllo, con errori mediani di 24,5, 21,5 e 24,5 errori, mostrano prestazioni di riconoscimento migliori, in linea con le aspettative, rispetto ai pazienti con AD, che hanno commesso una mediana di 29, 28 e 24 errori nelle tre unità di prova. È interessante notare che la riduzione della luminanza nella fase di riconoscimento sembra migliorare le prestazioni cognitive dei pazienti con AD.
Valutare l’atrofia ipotalamica nella SLA
L’imaging dettagliato dell’ipotalamo è di grande interesse per caratterizzare meglio il danno tissutale correlato alla malattia e le anomalie nella neurodegenerazione. Studi precedenti hanno dimostrato che il volume totale dell’ipotalamo è significativamente ridotto nei pazienti con SLA rispetto ai soggetti di controllo. Tuttavia, la demarcazione manuale o semiautomatica dell’ipotalamo richiede molto lavoro e dipende molto dall’operatore. L’obiettivo di uno studio è stato quindi quello di automatizzare la segmentazione dell’ipotalamo e del volume intracranico (ICV) dalle immagini MR pesate in T1, al fine di ridurre la variabilità umana e migliorare la robustezza dei risultati [4]. È stata studiata la questione se la segmentazione dell’ipotalamo utilizzando una rete neurale convoluzionale (CNN) possa essere utilizzata per un’analisi imparziale dei cambiamenti di volume dell’ipotalamo nella SLA. 120 set di dati MPRAGE della testa intera pesati in T1 (78 SLA e 42 controlli sani), con delimitazioni manuali appropriate dell’ipotalamo, erano disponibili e sono stati utilizzati per l’addestramento e la validazione dell’approccio automatizzato basato su CNN con architettura U-net. Non sono state riscontrate differenze significative nei volumi ipotalamici calcolati tra la previsione e la verità di base (prima della normalizzazione ICV) né nel gruppo SLA né nei controlli. Dopo la normalizzazione ICV, sono state trovate differenze significative nel volume ipotalamico tra la SLA e i controlli. Di conseguenza, questo potrebbe essere un metodo veloce e imparziale per quantificare l’ipotalamo, basato sull’applicazione della CNN come tecnica basata sull’intelligenza artificiale.
Prurito neuropatico nella SM
I danni ai nervi periferici o le lesioni centrali possono causare prurito e dolore neuropatico. Circa la metà dei pazienti con sclerosi multipla (SM) soffre di dolore neuropatico. Tuttavia, si sa poco sulla prevalenza, sulle caratteristiche e sulle cause del prurito nella SM. Lo scopo del presente studio è stato quello di indagare la prevalenza del prurito cronico nella SM [5]. È stata analizzata anche la misura in cui il dolore neuropatico e il prurito sono correlati. Sono stati reclutati in totale 99 pazienti con SM. Il 34% delle persone colpite ha riferito di aver avuto prurito nelle ultime sei settimane. Il prurito medio nelle ultime 24 ore è stato di 2,6 ± 3,1 (su una scala di valutazione numerica da 0 a 10). I pazienti con prurito presentavano dolore neuropatico più frequentemente dei pazienti senza prurito. Le qualità del prurito sono state descritte più frequentemente come “superficialmente localizzate” (65%) e “formicolio” (65%). Si è scoperto che il prurito cronico è molto più frequente nella SM di quanto si pensasse fino a poco tempo fa. I pazienti con SM che soffrono di prurito spesso presentano anche dolore neuropatico. La localizzazione e le caratteristiche del prurito sono simili a quelle dei pazienti PNP. Pertanto, gli autori ritengono possibile una genesi neuropatica periferica.
Prima manifestazione di epilessia in età avanzata
La causa delle crisi epilettiche di prima insorgenza negli anziani (LOFES) è spesso ritenuta una leucoencefalopatia microangiopatica in assenza di lesioni corticali, anche se i meccanismi fisiopatologici sottostanti rimangono sconosciuti. L’intento di uno studio era quello di determinare l’importanza dell’esatto contenuto volumetrico e della localizzazione delle iperintensità della materia bianca (WMH) come correlazione radiologicamente misurabile della leucoencefalopatia microangiopatica sul LOFES [6]. Inoltre, è stata analizzata in modo più dettagliato l’influenza dell’atrofia cerebrale globale e regionale.
Nell’ambito di uno studio retrospettivo caso-controllo, sono stati esaminati 50 pazienti LOFES di almeno 60 anni, nonché pazienti di controllo con un attacco ischemico transitorio (gruppo TIA) e pazienti di controllo senza precedenti malattie cerebrovascolari (pazienti di controllo, gruppo PC). Oltre all’assenza di lesioni corticali, la presenza di risonanza magnetica strutturale era un criterio di inclusione obbligatorio. Rispetto a entrambi i gruppi di controllo, i pazienti LOFES hanno mostrato un aumento del volume di WMH nel compartimento juxtacorticale e un modello di distribuzione di WMH spostato verso la zona juxtacorticale. Inoltre, l’analisi del percorso ha mostrato che di tutte le variabili di influenza analizzate, solo la ponderazione juxtacorticale dei WMH era un predittore di LOFES. Nei pazienti LOFES, l’analisi VBM ha rivelato un’atrofia corticale regionale significativa su entrambi i lati nel giro pre e postcentrale, nella sezione anteriore del giro paraippocampale su entrambi i lati, nella sezione posteriore del giro del cingolo, nella corteccia fronto-orbitale destra e cerebellare su entrambi i lati rispetto al gruppo di controllo combinato. I risultati indicano un ruolo chiave di un modello di distribuzione WMH enfatizzato a livello juxtacortico e dell’atrofia corticale regionale, soprattutto nel lobo frontale, nel giro paraippocampale e nel giro del cingolo, che sono considerati parte di una rete epilettogena e sottolineano la moderna comprensione dell’epilessia come modello di malattia con un disturbo a livello di rete.
Successo terapeutico con la PML
Infezione virale opportunistica rara ma grave del cervello, la leucoencefalopatia multifocale progressiva (PML) porta alla morte in molti casi. La malattia è causata dal poliomavirus umano 2 (HPyV-2) e colpisce in particolare i pazienti con una difesa immunitaria cellulare significativamente compromessa. In particolare, nei pazienti con una malattia emato-oncologica sottostante, il tasso di mortalità per la PML è quasi del 90%. L’uso di cellule T allogeniche virus-specifiche rappresenta una terapia sperimentale nuova e di successo in assenza di opzioni terapeutiche attualmente approvate. Se i pazienti hanno le proprie cellule T HPyV-2-specifiche nel sangue, l’anticorpo anti-PD-1 pembrolizumab può essere utilizzato anche per trattare la PML, se non ci sono controindicazioni. L’analisi del metaboloma dovrebbe essere utilizzata per identificare biomarcatori prognostici nel liquor e nel siero dei pazienti affetti da PML il più presto possibile nella fase pre-terapeutica, che possono essere utilizzati per prevedere la risposta al trattamento con cellule T allogeniche virus-specifiche o pembrolizumab [7].
Dal 2020, i pazienti affetti da PML sono stati trattati con cellule T allogeniche, HLA-match, specifiche per il virus, provenienti da donatori non correlati o imparentati, sulla base di studi di trattamento individualizzati. Nel corso dell’attuale studio, i campioni di siero e di liquido cerebrospinale di 11 pazienti che hanno risposto alla terapia e di 5 non rispondenti sono stati sottoposti a un’analisi diretta del metaboloma mediante spettrometria di massa. Inoltre, sono stati analizzati i campioni di due pazienti che avevano tratto buoni benefici dalla terapia con pembrolizumab. I grafici PLS-DA con convalida incrociata hanno mostrato una chiara separazione tra i gruppi dei rispondenti e dei non rispondenti. Ci sono state concentrazioni significativamente più alte di 35 metaboliti nel gruppo dei responder al trattamento, mentre 25 metaboliti erano significativamente più bassi in questo gruppo. In questo contesto, la prolina betaina è stata identificata come un potenziale biomarcatore sierico. L’analisi del metaboloma del liquido cerebrospinale prima dell’inizio della terapia ha mostrato un aumento significativo dei livelli di acido docosaesaenoico (DHA) e di ipoxantina nei pazienti che non hanno risposto alla terapia. L’applicazione di cellule T allogeniche virus-specifiche ha portato a promettenti successi terapeutici nella PML. Il metabolita legato alla betaina, la prolina betaina, è stato identificato come un potenziale biomarcatore sierico per prevedere la risposta al trattamento.
Cefalea indotta dal freddo
Esistono diversi approcci alla fisiopatologia delle cefalee primarie. Dal punto di vista clinico, esistono molte sovrapposizioni tra l’emicrania e la cefalea indotta dal freddo (HICS), ad esempio l’aumento della frequenza dell’HICS nei pazienti emicranici o la lateralizzazione dell’HICS al lato della cefalea emicranica. Ad oggi, tuttavia, non esistono dati che confrontino la fisiopatologia delle due entità. L’obiettivo primario di uno studio era quello di indagare il ruolo della molecola CGRP nell’innescare l’HICS nei pazienti con emicrania cronica [8]. È stato condotto uno studio su 17 soggetti con emicrania cronica prima e quattro settimane dopo l’inizio del trattamento con erenumab. Al momento dell’esame, è stata indotta una HICS nei soggetti del test con 200 ml di acqua ghiacciata secondo un protocollo standardizzato, durante il quale sono stati registrati i parametri vitali e l’imaging sonografico Doppler dell’arteria cerebrale media su entrambi i lati nella finestra acustica temporale. Dal punto di vista clinico, si è verificata una riduzione della prevalenza di HICS. I sintomi autonomici concomitanti del trigemino non erano più rilevabili dopo l’applicazione di erenumab. Un’analisi di sottogruppo ha rivelato una diminuzione ancora maggiore della prevalenza della risposta clinica dell’emicrania a erenumab. La sonografia Doppler ha mostrato una diminuzione del flusso sanguigno cerebrale sotto forma di una diminuzione della velocità media del flusso e un aumento dell’indice di resistenza quando si sono confrontate le due misurazioni. Si deve quindi postulare una connessione fisiopatologica tra emicrania e HICS.
Congresso: 96° Congresso della Società Tedesca di Neurologia (DGN)
Letteratura:
- Höglinger GU, Trenkwalder C: Nuova linea guida S2k sulla malattia di Parkinson. Sessione Argomenti caldi l’11 novembre 2023. 96° Congresso DGN 2023, Berlino/virtuale, 8-11 novembre 2023.
- Brandet JM: Fisiopatologia della malattia di Parkinson: indagine sulla proteina alfa-sinucleina legata all’ubiquitina, sulla dopamina e sulle disfunzioni dei sistemi proteasomiale e lisosomiale, utilizzando i metodi della fisica nucleare teorica. Abstract 42. 96° Congresso DGN 2023, Berlino/virtuale, 8-11 novembre 2023.
- Uttner I, et al: Influenza della luminanza e del contrasto sul riconoscimento delle immagini: Valutazione di un test di memoria di nuova concezione, orientato al potenziale di apprendimento, per la diagnosi precoce della demenza di Alzheimer. Abstract 65. 96° Congresso DGN 2023, Berlino/virtuale, 8-11 novembre 2023.
- Vernikouskaya I, et al: Segmentazione assistita da rete neurale convoluzionale dell’ipotalamo dalla risonanza magnetica per valutare l’atrofia ipotalamica nella sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Abstract 79. 96° Congresso DGN 2023, Berlino/virtuale, 8-11 novembre 2023.
- Steeken L, et al: Prurito neuropatico nella sclerosi multipla? Abstract 272. 96° Congresso DGN 2023, Berlino/virtuale, 8-11 novembre 2023.
- Nasca A, et al: Prima crisi epilettica nell’anziano e leucoencefalopatia microangiopatica: sul ruolo chiave delle lesioni midollari juxtacorticali e dell’atrofia corticale regionale. Abstract 131. 96° Congresso DGN 2023, Berlino/virtuale, 8-11 novembre 2023.
- Möhn N, et al: Analisi del metaboloma nel liquido cerebrospinale e nel siero di pazienti con leucoencefalopatia multifocale progressiva trattati con cellule T allogeniche virus-specifiche. Abstract 244. 96° Congresso DGN 2023, Berlino/virtuale, 8-11 novembre 2023.
- Sorge J, et al: Il ruolo del CGRP nella cefalea indotta dal freddo. Abstract 644. 96° Congresso DGN 2023, Berlino/virtuale, 8-11 novembre 2023.
InFo NEUROLOGIA & PSICHIATRIA 2023; 21(6): 20-22 (pubblicato il 2.12.23, prima della stampa)