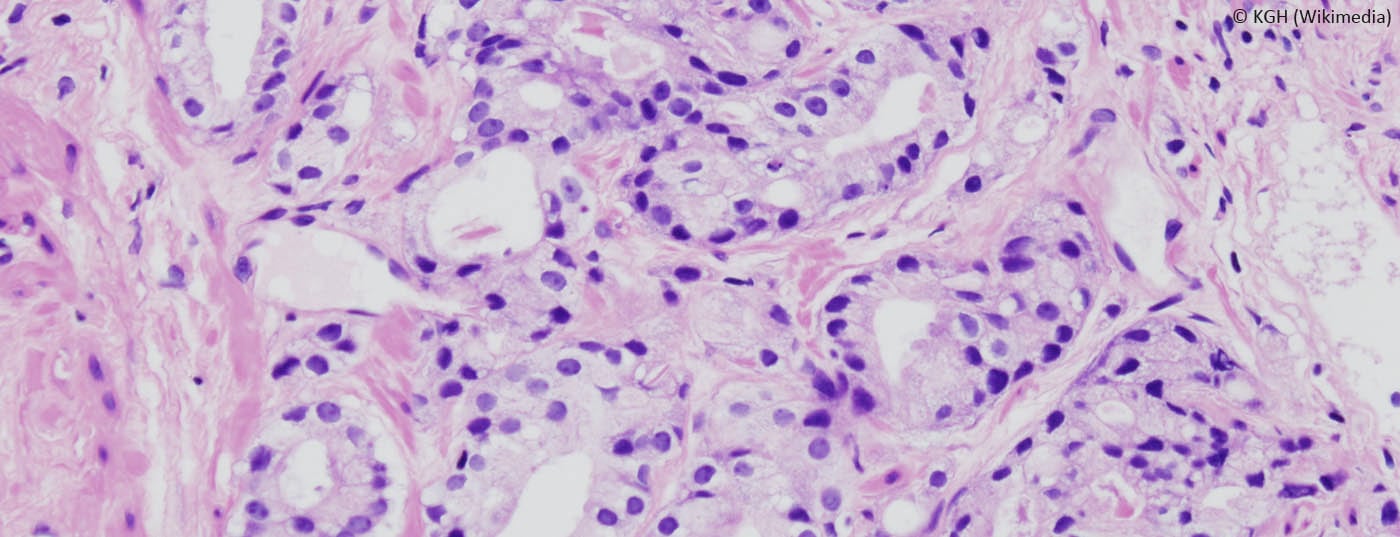Abbiamo riportato in precedenza l’effetto di riduzione del rischio delle statine nella prevenzione del cancro al fegato. Ora uno studio retrospettivo mostra risultati sorprendenti nel campo del carcinoma prostatico: se i farmaci ipocolesterolemizzanti vengono utilizzati in parallelo alla deprivazione di androgeni, la sopravvivenza libera da progressione viene prolungata di circa dieci mesi. Quali sono i meccanismi alla base di questo?
Il team di ricerca statunitense guidato da Lauren C. Harshman, MD, Boston, ha studiato l’effetto delle statine sulle linee cellulari del tumore alla prostata e sulla sopravvivenza libera da progressione di 926 pazienti con cancro alla prostata metastatico ormono-sensibile, ricorrente o di nuova diagnosi, mediante analisi in vitro e dati retrospettivi.
Vivere più a lungo senza progressione
All’inizio della deprivazione androgenica, dei 926 pazienti della coorte retrospettiva, 283, ovvero il 31%, stavano assumendo statine. Dopo un follow-up mediano di 5,8 anni, un totale di 644 pazienti ha avuto una progressione. Il tempo mediano alla progressione della malattia è stato di 20,3 mesi. Il tempo senza progressione era significativamente più lungo negli uomini che assumevano statine (27,5 mesi rispetto a 17,4 mesi nei non utilizzatori, p<0,001). Il rischio di progressione è stato ridotto del 17% (HR 0,83; 95% CI 0,69-0,99; p=0,04).
L’associazione è rimasta significativa anche dopo aver preso in considerazione importanti fattori prognostici, ed è stata ugualmente vera per i pazienti con o senza una storia di malattia. senza metastasi (riduzione del rischio: 21% per i tumori M0, 16% per i tumori M1).
I risultati in vitro forniscono una possibile spiegazione
I ricercatori vedono una ragione della prolungata sopravvivenza libera da progressione nella proteina di trasporto SLCO2B1. Questo assicura l’introduzione del deidroepiandrosterone solfato (DHEAS), un precursore del testosterone, nella cellula tumorale. Anche le statine utilizzano questa proteina per entrare nelle cellule, quindi si può ipotizzare che il tumore possa assumere meno precursori del testosterone quando si assumono statine. Al contrario, questo ha probabilmente un effetto inibitorio sulla progressione. In uno studio precedente, gli autori erano già riusciti a dimostrare che le varianti genetiche di SLCO2B1 erano correlate all’intervallo di progressione.
L’analisi in vitro del presente studio ha anche rivelato che le statine bloccano effettivamente l’assorbimento di DHEAS legandosi in modo competitivo a SLCO2B1. Questo riduce ulteriormente la riserva di androgeni intratumorale e ritarda la progressione.
Oltre all’effetto descritto, le statine hanno numerose altre proprietà anticancro, secondo gli autori, che potrebbero essere responsabili anche dell’effetto sul cancro al fegato, per esempio. Tra le altre cose, questo include la promozione dell’apoptosi. Inoltre, la riduzione del colesterolo è di per sé benefica, in quanto è un precursore di vari ormoni sessuali – tra cui il deidroepiandrosterone, che viene metabolizzato nel fegato in DHEAS.
Gli studi prospettici hanno richiesto
I risultati sono interessanti, soprattutto perché collegano in modo produttivo un’analisi in vitro con dati retrospettivi. Inoltre, le statine sono ampiamente disponibili e il loro profilo di sicurezza è noto e dimostrato, rendendole interessanti come potenziali farmaci antitumorali complementari. Infine, un numero relativamente elevato di pazienti con cancro alla prostata soffre di disturbi del lipometabolismo. Sono stati avviati anche diversi studi prospettici sull’uso delle statine nella terapia del cancro.
L’influenza delle statine è probabilmente rilevante solo in condizioni di deprivazione di androgeni. I pazienti senza deprivazione di androgeni hanno molti più androgeni nel sangue, motivo per cui l’effetto è probabilmente meno significativo in questo caso.
Fonte: Harshman LC, et al: Uso di statine al momento dell’inizio della terapia di deprivazione androgenica e tempo alla progressione nei pazienti con cancro alla prostata sensibile agli ormoni. JAMA Oncol 2015; 1(4): 495-504. doi:10.1001/jamaoncol.2015.0829.
InFo ONCOLOGIA & EMATOLOGIA 2016; 4(1): 5