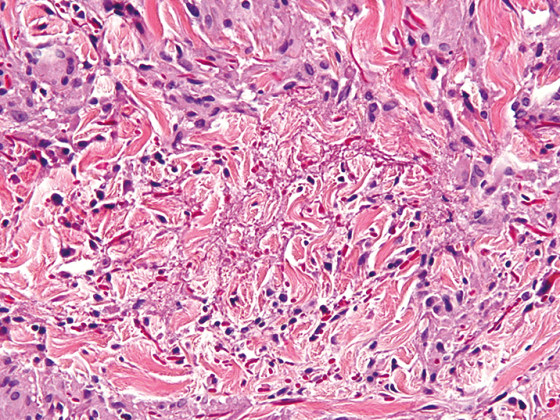Nel vasto campo dell’otorinolaringoiatria, verranno evidenziati alcuni sintomi particolarmente comuni nella pratica, in vista degli sviluppi attuali e delle nuove scoperte. Sotto l’influenza della ricerca attuale, ci sono continui cambiamenti nelle raccomandazioni terapeutiche per determinate indicazioni e ci sono anche numerosi progressi nella diagnostica.
Molti aspetti della vita medica quotidiana sono attualmente ancora dominati dalla pandemia della corona, ma la ricerca non è ferma e ci sono notizie interessanti da riferire da vari campi. Una panoramica delle linee guida otorinolaringoiatriche costantemente aggiornate è disponibile sul sito www.orl-hno.ch/ueber-uns/guidelines.html. Nella pratica quotidiana, i pazienti non si presentano con una diagnosi, ma riferiscono i loro sintomi. Nello spirito della medicina traslazionale, il Dr. med. Ralph Litschel, dell’ambulatorio di otorinolaringoiatria di Roter Platz, San Gallo, ha presentato le attuali scoperte sui sintomi comuni da una prospettiva teorica e pratica [1].
Angina streptococcica: gli antibiotici non sono sempre necessari
“Negli Stati Uniti, l’80% dei casi di angina streptococcica viene trattato con antibiotici, in Svizzera circa il 40%”, afferma il Dr. Litschel [1]. Secondo un articolo pubblicato nel 2019, l’angina streptococcica ha solitamente un decorso benigno e si risolve spontaneamente entro una settimana, anche senza antibiotici [2]. Un tampone della gola è consigliato per un punteggio McIsaac ≥3 (test rapido per gli streptococchi di gruppo A). Se il risultato è negativo, non è necessario un trattamento antibiotico; se il test rapido è positivo, gli antibiotici possono essere utilizzati con un ritardo, cioè se i sintomi peggiorano o non migliorano entro 72 ore. I pazienti devono essere informati che gli antibiotici alleviano poco il disagio o accorciano la durata dei sintomi rispetto agli analgesici e che le complicanze sono rare. Gli antibiotici non necessari distruggono la normale flora batterica e contribuiscono in modo significativo alla diffusione di batteri resistenti. Per alleviare i sintomi, sono consigliabili rimedi casalinghi di provata efficacia (ad esempio, tè ai fiori di tiglio o alla salvia, e riposo a letto in caso di febbre), mentre per ridurre il dolore si possono usare ibuprofene o paracetamolo. Inoltre, tra le misure consigliate ci sono gli anestetici locali topici, se necessario disinfettanti, sotto forma di pastiglie, soluzione per gargarismi o spray per la gola. Se la condizione peggiora, i pazienti devono tornare dal medico. Si consiglia un attento follow-up nei pazienti molto malati o nei bambini piccoli (<3-5 anni) o nelle persone molto anziane o debilitate, nonché in caso di anamnesi familiare positiva per febbre reumatica.
Gli antibiotici non sono indicati nemmeno per alleviare gli ascessi peritonsillari o la febbre reumatica, secondo la maggior parte delle linee guida internazionali. “Al giorno d’oggi, non c’è quasi più febbre reumatica in Svizzera”, ha detto il relatore [1].
Reflusso laringofaringeo vs. GERD
Sintomi come la sensazione di globus, la necessità di schiarirsi la gola, la tosse, la raucedine o una sensazione di bruciore alla gola possono essere indicativi di un reflusso laringofaringeo. Secondo il dottor Litschel [1], questa forma di reflusso interessa principalmente l’area della laringe posteriore, con un marcato gonfiore della membrana mucosa. Mentre il reflusso gastroesofageo (GERD) si verifica principalmente in posizione sdraiata e di sera o di notte, il reflusso laringofaringeo si manifesta durante il giorno. Il trattamento consigliato consiste in una terapia con PPI ad alto dosaggio per almeno due mesi. Un reperto ecografico classico è l’ingrossamento dei linfonodi e, in alcuni casi, cisti laterali o mediane del collo.
Cosa fare in caso di ostruzione nasale o epistassi?
Nell’area del naso e dei seni paranasali, l’ostruzione della respirazione nasale è uno dei sintomi più comuni. Spesso c’è una deviazione del setto nasale, sotto forma di uno sperone che è chiaramente visibile nella tomografia computerizzata, e spesso c’è anche un’iperplasia della conca nasale. Un’altra possibile causa è la rinite allergica, ma questo argomento non viene trattato qui. La terapia per la respirazione nasale limitata consiste principalmente in spray nasali a base di glucocorticoidi, risciacqui nasali salini, se necessario, e pomate nasali idratanti se la mucosa nasale è molto secca. Se queste misure non portano sollievo, esiste anche la possibilità di un trattamento chirurgico, spiega il dottor Litschel [1].
Le emergenze otorinolaringoiatriche più comuni comprendono la fuoriuscita spontanea di sangue da una o entrambe le narici o la mescolanza di secrezioni nasali con il sangue. Ci sono molte possibili ragioni per l’epistassi”, sottolinea il relatore, “anche se spesso non è possibile determinarle in modo definitivo [1]. Nel 90% dei casi di epistassi, sono interessate le aree anteriori, di solito coinvolgendo il locus Kiesselbachi. “Si trova all’ingresso nasale, dove c’è una rete di vasi linfatici in cui può verificarsi facilmente un’emorragia, soprattutto se il naso è un po’ secco”, spiega il dottor Litschel. Solo alcune emorragie si verificano più indietro, nell’area dell’arteria sfenopalatina o di uno dei suoi rami. Le misure immediate per l’epistassi includono una posizione seduta eretta, la testa deve essere leggermente piegata in avanti e le narici devono essere compresse per almeno cinque minuti. Molti pazienti appoggiano automaticamente la testa sulla nuca, ma questo è sbagliato perché la deglutizione di sangue può provocare rantoli o vomito, spiega il relatore. Inoltre, si consiglia di applicare un impacco freddo sul collo. Se necessario, può essere richiesta l’elettrocoagulazione.
Nessuna diagnosi radiografica nella rinosinusite non complicata
Secondo la Società Svizzera di Oto-Rino-Laringologia, Otorinolaringoiatria e Chirurgia Maxillo-Facciale (SGORL), la rinosinusite acuta è una diagnosi clinica ed è definita da almeno due dei seguenti sintomi che si verificano in modo acuto e durano fino a 12 settimane: secrezione nasale purulenta, ostruzione nasale, dolore facciale e/o perdita dell’olfatto. Per la conferma viene eseguita un’endoscopia nasale. Se si sospetta una complicazione della rinosinusite o un’altra diagnosi di fondo, si raccomanda una TAC o una tomografia computerizzata a fascio conico.
Il “Documento di posizione europeo sulla rinosinusite e i polipi nasali” (EPOS) 2020 è molto completo e tratta in dettaglio diversi aspetti (panoramica 1) [3]. La rinosinusite cronica è quando i sintomi durano più di 12 settimane. “Ci sono ottime prove che l’intervento chirurgico ha una probabilità di successo dell’89%”, ha detto il relatore citando il documento EPOS [1,3]. Prima di eseguire una procedura chirurgica, è necessario eseguire un esame di imaging. Negli ultimi anni sono stati compiuti notevoli progressi in questo settore. La TC a fascio conico è associata a circa il 40% in meno di esposizione alle radiazioni rispetto alla tomografia computerizzata convenzionale e lo spessore della fetta è inferiore a 0,3 mm [4]. Il dottor Litschel offre personalmente la TAC a fascio conico nel suo studio. Utilizzando la “modalità a dose lunga”, la dose di radiazioni poteva essere ulteriormente ridotta, eppure in questa modalità si poteva ancora riconoscere molto. Anche la rinosinusite cronica con polipi viene solitamente trattata con un intervento chirurgico, se non c’è risposta alla terapia farmacologica.

Anche la sinusite dentaria non deve essere dimenticata. Nel campo degli ascessi dentogeni, si registra un aumento del numero di casi, riferisce il dottor Litschel, facendo riferimento al documento di posizione EPOS 2020 [3]. Le opzioni di trattamento includono la riabilitazione dentale e la chirurgia sinusale per il drenaggio.
Acufene e perdita dell’udito
Verso la fine della sua presentazione, il dottor Litschel parla dei sintomi nell’area degli organi uditivi e vestibolari (riquadro) [1]. Un test dell’udito dovrebbe essere effettuato per gli acufeni di recente insorgenza, ma una risonanza magnetica non è necessaria, spiega il relatore. “La diagnostica per immagini non è utile per l’acufene non pulsatile”, come si legge nelle Linee guida di Smarter Medicine [1,5]. Non esiste un trattamento standard per l’acufene nella medicina ortodossa. Ci sono prove che l’ipnosi o gli apparecchi acustici sono utili in alcuni casi, ma i dati sono incoerenti. A volte il trattamento psicoterapeutico può essere d’aiuto.
In caso di perdita dell’udito, la terapia deve essere iniziata entro 1 settimana. Il relatore ha riferito di un caso in cui la terapia con prednisone 100 mg per 7 giorni è stata efficace. Un test dell’udito dopo 3 settimane ha mostrato un chiaro miglioramento della perdita uditiva.
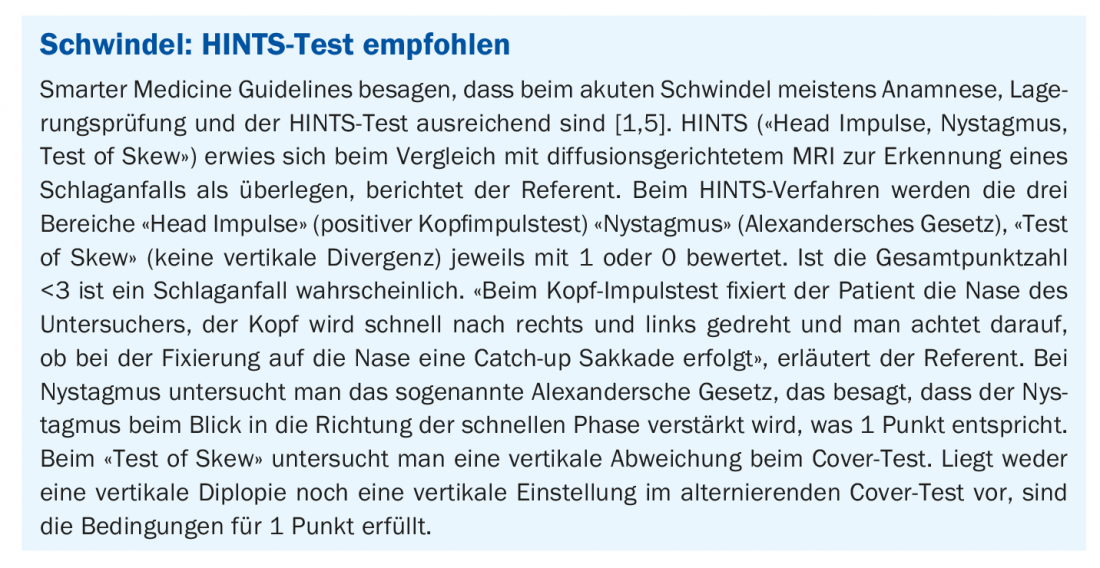
La presbiacusia si riferisce a un deterioramento dell’udito legato all’età, causato da processi degenerativi, che si verifica soprattutto alle alte frequenze. Ai pazienti affetti dovrebbe essere consigliato un apparecchio acustico. I dispositivi moderni sono dotati di soppressione del rumore (ad esempio, del vento), di tecnologia microfonica direzionale, di soppressione del feedback e di programmi di comfort (ad esempio, il piacere della musica). In Svizzera, l’AI o l’AVS (a partire dall’età di 64 o 65 anni rispettivamente) forniscono un sussidio per l’acquisto di un apparecchio acustico, se esiste un’indicazione adeguata.
I problemi di udito nell’infanzia sono spesso causati dall’iperplasia adenoidea. Il trattamento è inizialmente conservativo (palloncino Otovent), con l’utilizzo di uno spray nasale di glucocorticoidi, se necessario. Se i sintomi persistono per più di 3 mesi, si raccomanda la terapia chirurgica (adenotomia, paracentesi, tubo timpanostomico).
Congresso: Giornate di formazione FomF GP San Gallo
Letteratura:
- Litschel R: Malattie otorinolaringoiatriche comuni nella pratica. Ralph Litschel, MD, FomF, Giornate di formazione avanzata per medici di base, 12.03.2021
- Hofmann Y, et al: Trattamento dell’angina streptococcica, Swiss Med Forum 2019; 19(29).
- Fokkens WJ et al: Documento di posizione europeo sulla rinosinusite e i polipi nasali 2020. Rhinology 2020; 58(Suppl S29): 1-464.
- Al Abduwani J, et al.: Studi cone beam CT dei seni paranasali rispetto agli studi multidetettore standard e multidetettore a bassa dose. Am J Otolaryngol 2016; 37(1): 59-64.
- Linee guida per una medicina più intelligente, www.smartermedicine.ch/de/top-5-listen/orl-hals-und-gesichtschirurgie.html, (ultimo accesso 27.04.2021).
HAUSARZT PRAXIS 2021; 16(7): 40-41 (pubblicato il 28.6.21, prima della stampa).