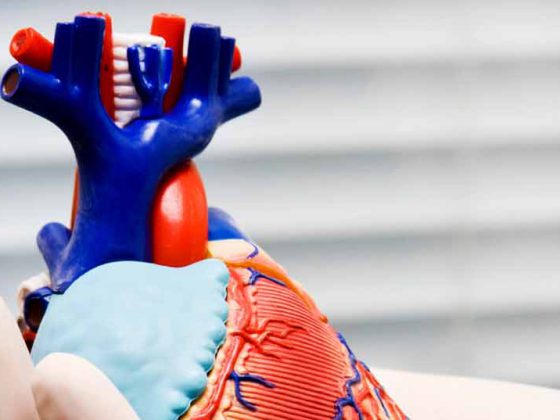Quando un paziente si presenta per la prima volta con una fibrillazione atriale (FA) nello studio del medico di famiglia, oltre alla documentazione dell’ECG e all’esame clinico, si deve fare una ricerca attiva di possibili fattori scatenanti secondari, come l’ipertiroidismo. C’è poi la questione del rischio di tromboembolia, la complicanza più temuta della VCF. Questo rischio viene valutato secondo il noto punteggio CHADS2 e, secondo le ultime linee guida, secondo il punteggio CHA2DS2-VASc [1]. Nella situazione acuta, il controllo della frequenza deve essere avviato anche nella VCF tachicardica. I beta-bloccanti e i calcio antagonisti, eventualmente in combinazione con la digossina, si sono dimostrati efficaci in questo caso. In seguito, si raccomanda una valutazione cardiologica, compresa l’ecocardiografia, per cercare e caratterizzare le malattie cardiache strutturali. Questo è essenziale per poter effettuare la scelta corretta del farmaco in caso di successivo controllo del ritmo con i farmaci.
Se il controllo della frequenza non ha successo, cioè se il paziente è ancora sintomatico o rimane tachicardico, il controllo del ritmo farmacologico con un farmaco antiaritmico specifico di classe Ic (flecainide, propafenone) o di classe III (amiodarone, sotalolo, dronedarone) deve essere eseguito in stretta collaborazione con un cardiologo e, se necessario, con un ritmologo, a seconda della cardiopatia, delle malattie concomitanti e tenendo conto delle possibili interazioni e controindicazioni.
Se il controllo medico del ritmo nei pazienti sintomatici non porta alla liberazione dei sintomi o a effetti collaterali intollerabili, si deve prendere in considerazione la terapia interventistica della VCF mediante ablazione con catetere. Secondo le più recenti linee guida europee, l’ablazione primaria con catetere senza un precedente controllo medico del ritmo (ablazione di prima linea) può essere presa in considerazione se il paziente sintomatico desidera fortemente una terapia non farmacologica (scelta del paziente) [1]. Questo cambiamento nelle linee guida è nato dalle segnalazioni che la terapia con catetere nelle fasi iniziali della malattia ha esiti più favorevoli, tra cui un minor numero di reinterventi [2]. Sembra favorire il successo dell’ablazione con catetere quando non c’è o c’è solo un cambiamento strutturale limitato negli atri e l’ablazione limitata all’isolamento della vena polmonare è sufficiente.
A questo proposito, va menzionato in particolare l’interessante articolo di David Altmann, MD, e del Prof. Peter Ammann, MD, in questo numero di CARDIOVASC. Gli autori descrivono in dettaglio l’importanza dei fattori scatenanti e dei cambiamenti del substrato, in particolare la fibrosi atriale, che ha una grande importanza per la strategia di ablazione (cioè l’estensione dell’ablazione necessaria con linee di ablazione aggiuntive). Purtroppo, il tipo di VCF – parossistica o persistente – e altri parametri surrogati, come le dimensioni atriali, sono talvolta di modesta importanza nella scelta della corretta strategia di ablazione. Spesso, l’entità dell’alterazione strutturale e funzionale degli atri diventa evidente solo durante l’esame invasivo. Sarebbe quindi molto auspicabile poter descrivere i cambiamenti negli atri – cioè l’entità della fibrosi atriale sinistra – prima della terapia interventistica della fibrillazione atriale, per poter pianificare un’ablazione su misura, come è già stato descritto in letteratura [3]. Speriamo che la descrizione pre-interventistica del substrato – preferibilmente utilizzando la risonanza magnetica cardiaca – permetta in futuro un’ablazione paziente-specifica con risultati ancora migliori, a beneficio dei nostri pazienti con VCF.
Se sono già presenti cambiamenti strutturali negli atri e i pazienti soffrono di fibrillazione atriale persistente e di lunga durata, la chirurgia offre un metodo promettente. A questo proposito, i due importanti contributi clinici del PD Dr med Alberto Weber sono molto interessanti e informativi.
Le auguro una lettura emozionante.
PD Dr. med. Hildegard Tanner