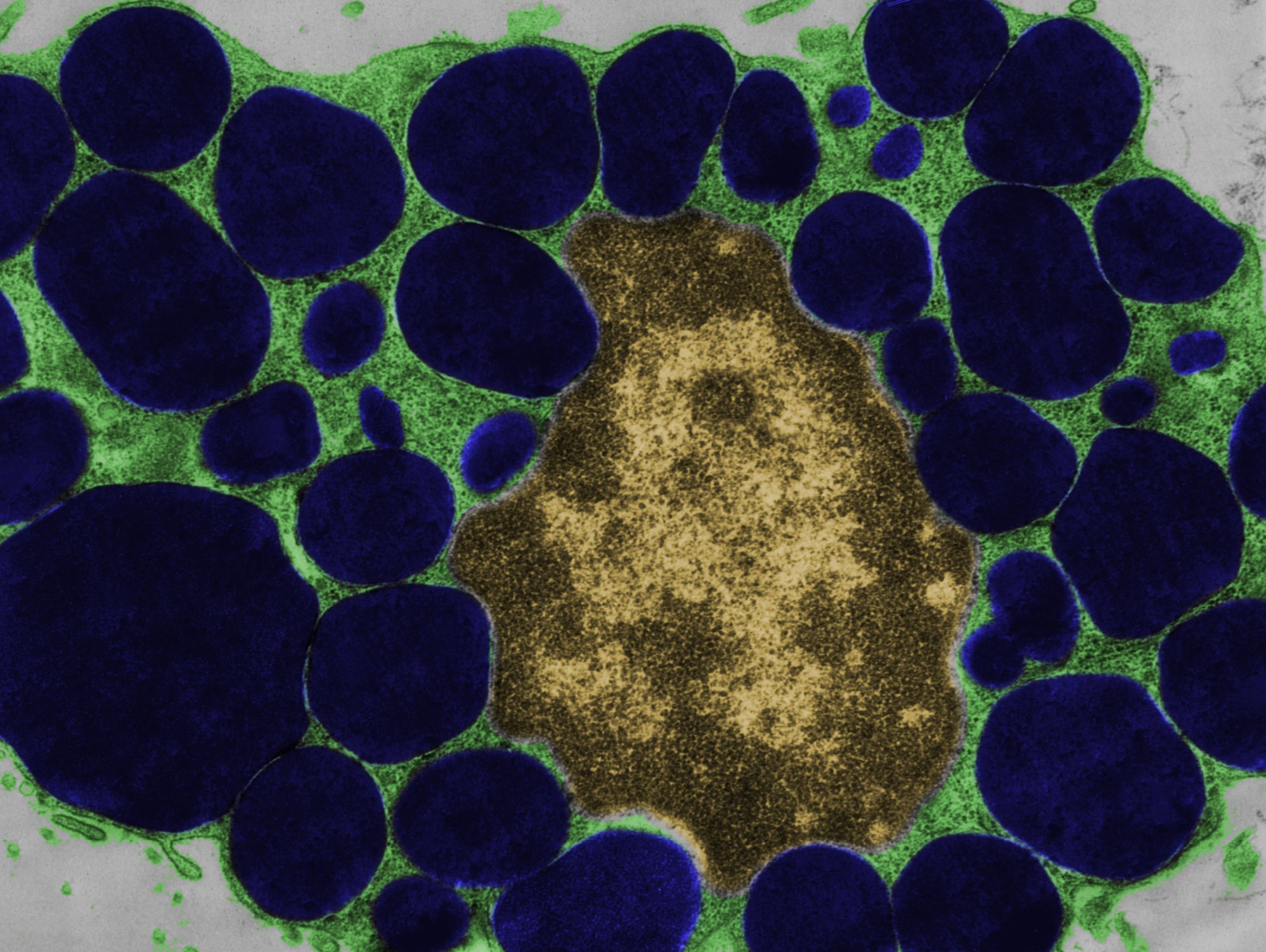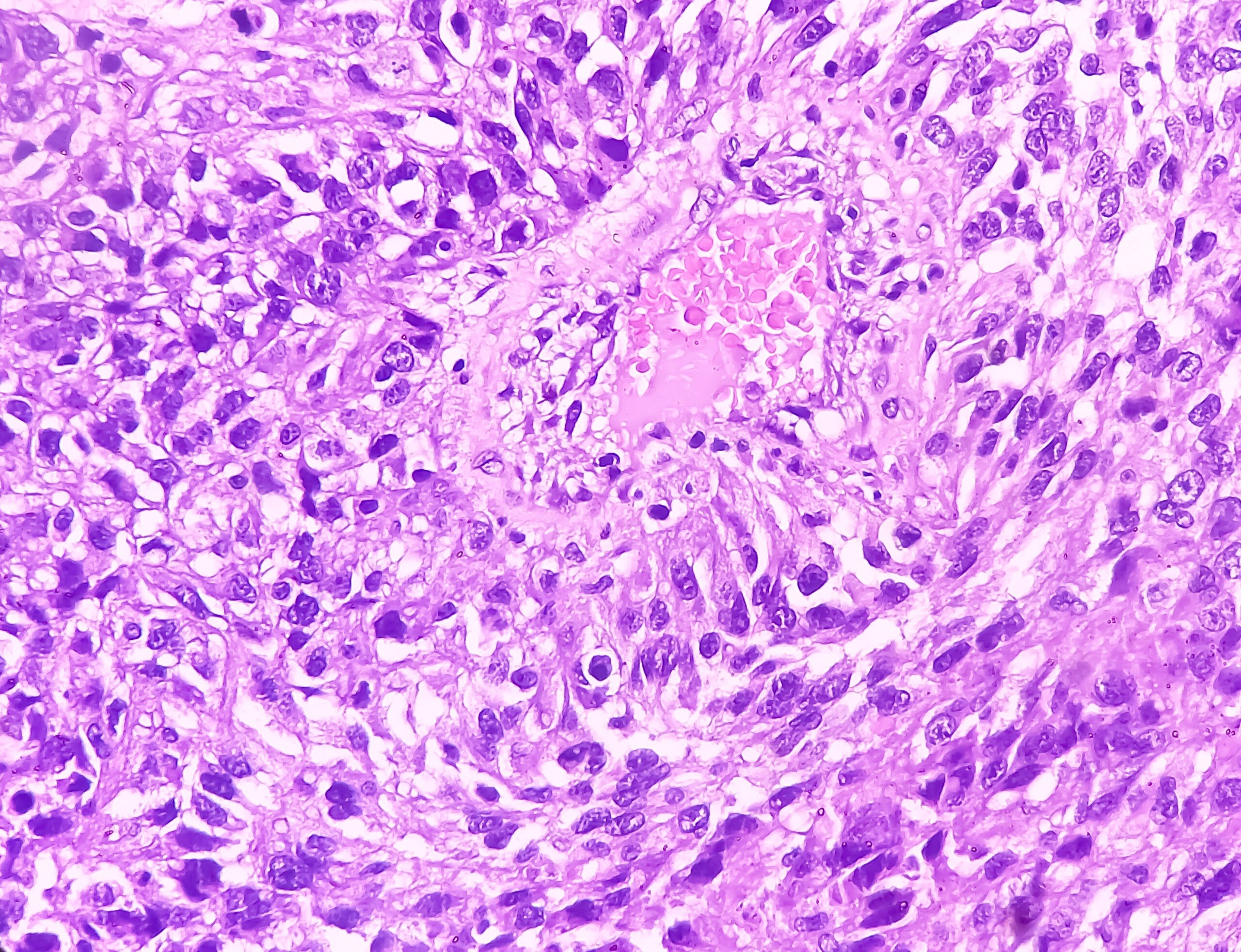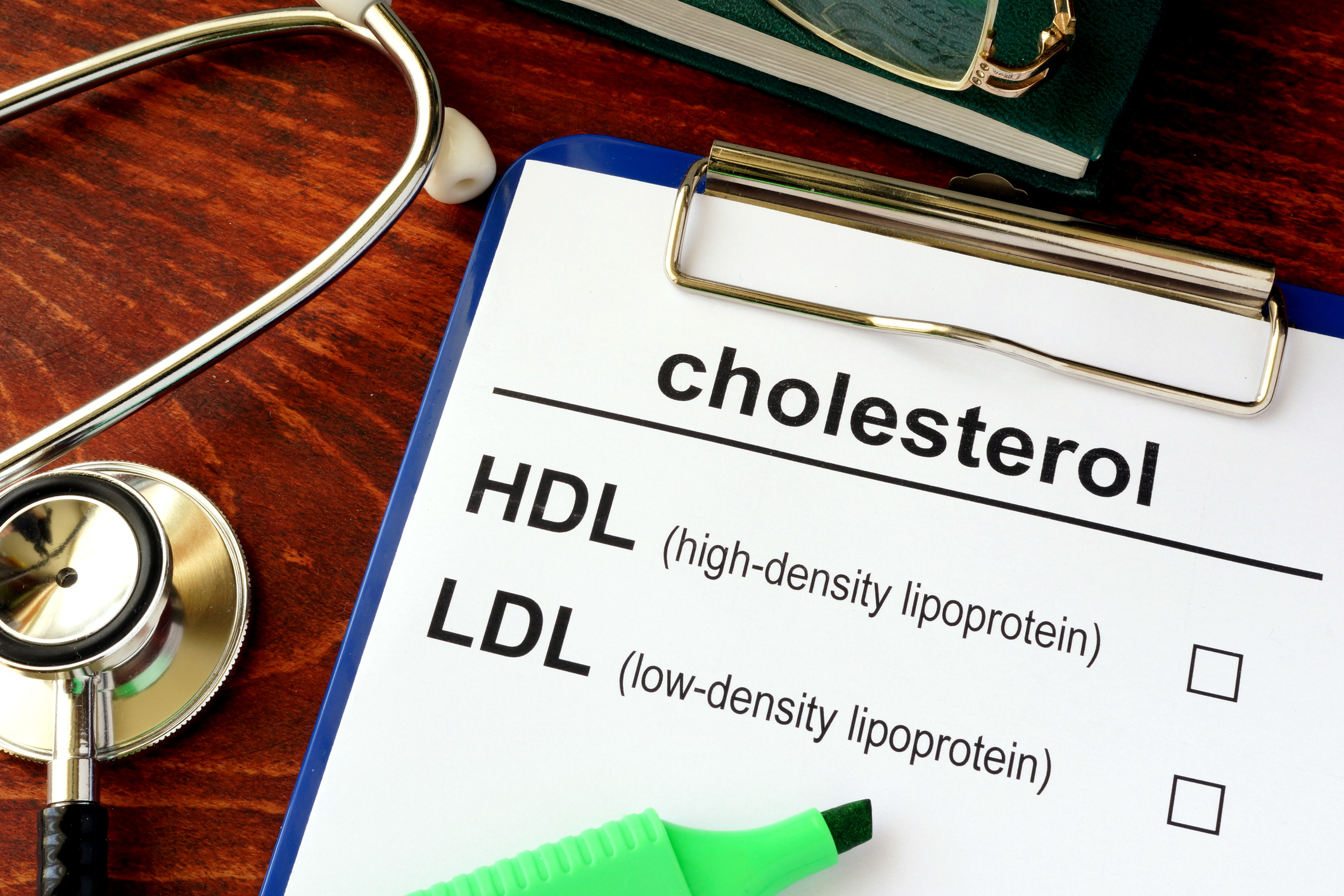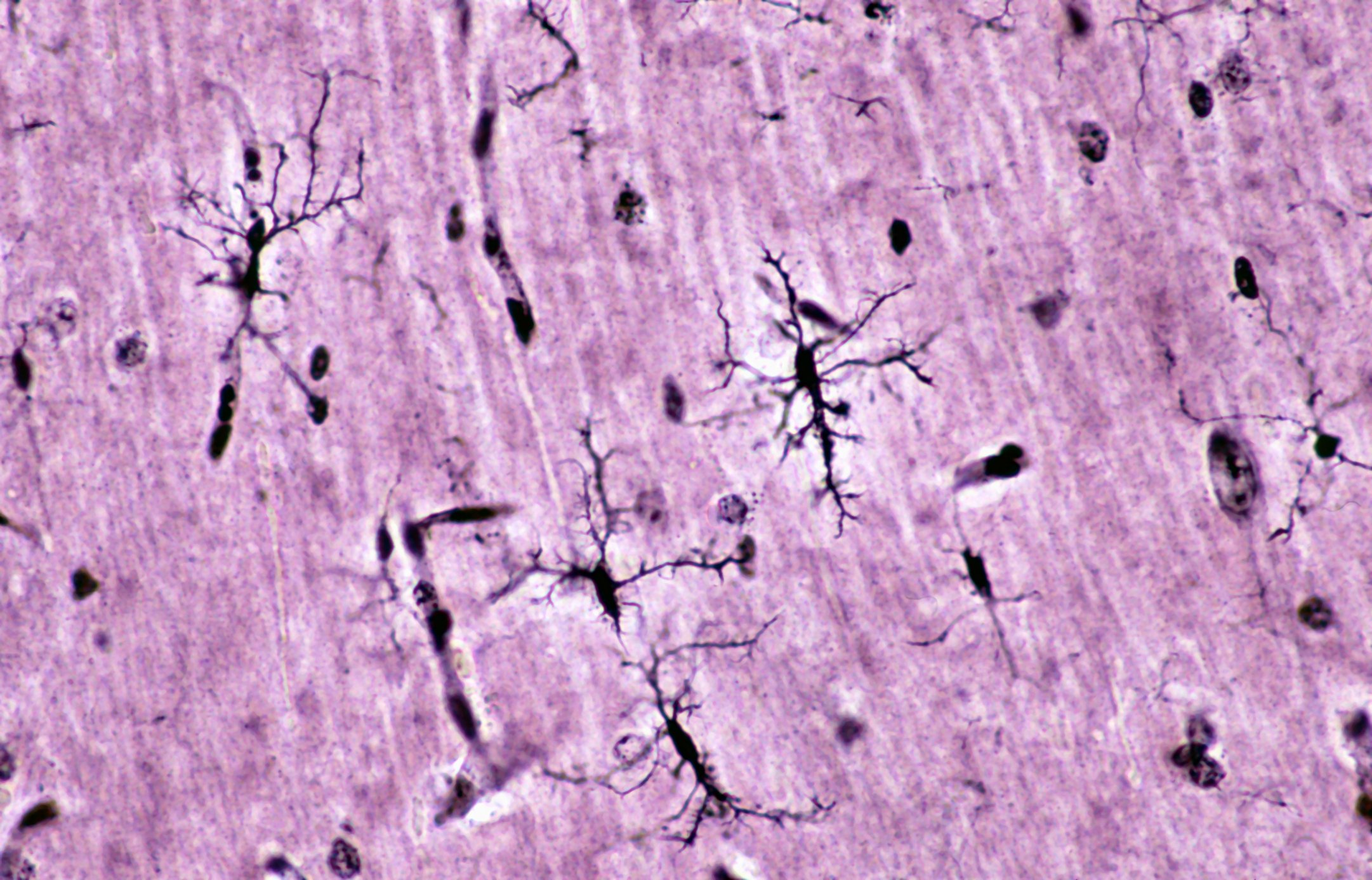Una valutazione ambulatoriale precoce prima dell’intervento è utile. Ciò consente un’adeguata valutazione del rischio e la pianificazione dell’intero processo perioperatorio può essere regolata in vista di un’esecuzione regolare dell’intervento. Tuttavia, gli esami preoperatori non necessari dovrebbero essere evitati, secondo le raccomandazioni di varie società professionali che seguono la campagna “medicina più intelligente”. Cosa significa questo in termini concreti?
La Società Svizzera di Anestesiologia e Rianimazione, sulla base delle linee guida postulate dalla “medicina più intelligente” (riquadro) , propone di evitare esami inutili prima dell’intervento chirurgico nei pazienti senza gravi condizioni preesistenti e di effettuare chiarimenti preliminari basati su criteri in misura limitata in caso di rischi legati al paziente [1,2].
|
La campagna Choosing Wisely è in corso in Svizzera da diversi anni e mira a definire una diagnosi e una terapia ottimali per il singolo paziente. L’associazione di supporto alla medicina intelligente è stata fondata nel 2017 con la partecipazione della Società Svizzera di Medicina Generale e Interna (SGAIM) e dell’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM). L’associazione fa parte di “Choosing wisely International” [1]. Originariamente, l’iniziativa “Choosing wisely” è stata lanciata negli Stati Uniti nel 2011. L’obiettivo era quello di promuovere una discussione aperta tra medici, pazienti e pubblico sul tema dell’uso eccessivo della medicina. |
Chiarire e trattare l’anemia prima dell’intervento.
L’anemia deve essere chiarita e trattata prima dell’intervento [2]. Il 30-50% dei pazienti soffre di anemia prima di un intervento chirurgico importante. L’anemia preoperatoria è associata a una maggiore necessità di trasfusioni di sangue, a complicazioni postoperatorie e a esiti peggiori dopo l’intervento. Le linee guida internazionali raccomandano la somministrazione di ferro per via endovenosa per correggere l’anemia nei pazienti prima dell’intervento chirurgico [3]. La linea guida OMS 2021 sulla “Gestione del sangue del paziente” (PBM) descrive la diagnosi e il trattamento dell’anemia (in particolare l’anemia da carenza di ferro), la minimizzazione della perdita di sangue e l’evitamento di trasfusioni di sangue non necessarie come i tre pilastri della PBM [4]. Le linee guida del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) del Regno Unito suggeriscono di offrire ai pazienti con anemia da carenza di ferro un’integrazione orale di ferro prima e dopo l’intervento chirurgico. L’infusione di ferro per via endovenosa deve essere presa in considerazione nei pazienti con scarsa tolleranza al ferro orale, carenza funzionale di ferro e quando l’intervallo tra la diagnosi di anemia da carenza di ferro e l’intervento chirurgico è troppo breve per essere efficace con l’integrazione di ferro per via orale [2,5]. Anche la Società Europea dei Cardiologi (ESC) ha incluso la PBM nelle sue 2022 raccomandazioni per la gestione perioperatoria dei pazienti con malattie cardiovascolari sottoposti a chirurgia non cardiaca [6].
Pazienti che assumono farmaci antiaggreganti o anticoagulanti: A cosa fare attenzione?
Per i pazienti che assumono farmaci antiaggreganti, l’ESC suggerisce, tra l’altro, il seguente [6,7]:
- Se è indicata l’interruzione degli antagonisti P2Y12, si suggerisce un intervallo preoperatorio di 3-5 giorni per il ticagrelor, di 5 giorni per il clopidogrel e di 7 giorni per il prasugrel (grado di raccomandazione 1B).
- Per gli interventi ad alto rischio di sanguinamento (tab. 1) , l’ASA deve essere somministrato almeno due volte al giorno. essere interrotto 7 giorni prima (raccomandazione di grado 1C)
- I farmaci antiaggreganti devono essere ripresi entro 48 ore dalla procedura, se la gestione interdisciplinare del sanguinamento lo consente (grado di raccomandazione 1C).
- Per i pazienti in terapia con anticoagulanti orali (NOAK), l’ESC raccomanda il seguente approccio [6,7]:
- Se è indicato un intervento chirurgico urgente, le NOAK devono essere interrotte immediatamente (grado di raccomandazione 1C).
- Per gli interventi con rischio di sanguinamento intermedio e superiore (Tab. 1) , l’interruzione e il riavvio dei NOAK devono seguire la strategia illustrata nella Figura 1, che tiene conto del rischio di sanguinamento, della funzione renale e del rispettivo preparato NOAK (grado di raccomandazione 1B).
- Per le procedure minori e per quelle che non comportano un aumento del rischio di sanguinamento, il rispettivo NOAK deve essere continuato/non interrotto (grado di raccomandazione 1B).
- L’eparina molecolare o non frazionata deve essere presa in considerazione per il bridging nei pazienti ad alto rischio di sanguinamento e nei pazienti con valvola cardiaca meccanica (grado di raccomandazione 1B).
- Se il rischio di emorragia è basso, i pazienti che assumono NOAK dovrebbero essere operati al livello trough (12-24 ore dopo l’ultima dose) (grado di raccomandazione 1C).
Misure profilattiche contro l’ipotermia perioperatoria
La temperatura corporea interna è un parametro vitale [8]. L’ipotermia perioperatoria è un fenomeno derivante dalla soppressione della termoregolazione centrale nel contesto dell’anestesia e dall’esposizione prolungata di ampie parti del corpo a temperature fredde in sala operatoria [9]. L’ipotermia perioperatoria può provocare gravi complicazioni, come infezioni della ferita, ritardata guarigione della ferita, disturbi della coagulazione e aumento associato del rischio di emorragie ed eventi cardiovascolari [8,9]. La linea guida S3 “Evitare l’ipotermia perioperatoria”, pubblicata nel 2019, raccomanda che la temperatura corporea dei pazienti ambulatoriali venga misurata anche dall’unità organizzativa preparatoria (ad esempio, il reparto, l’ambulatorio o l’area di degenza) prima dell’induzione dell’anestesia, al fine di prevenire l’ipotermia attraverso misure profilattiche [8]. Il riscaldamento precoce e proattivo, soprattutto attraverso i sistemi di riscaldamento della superficie corporea, può mantenere l’omeostasi dell’organismo e quindi contribuire a ridurre la morbilità e la mortalità postoperatoria [9].
Quali interventi devono essere messi in discussione?
La Società Svizzera di Anestesiologia e Rianimazione elenca i seguenti interventi come possibilmente evitabili (“top 5 list”) [9]:
L’indicazione all’intervento chirurgico nei casi in cui si prevede un’alta morbilità/mortalità perioperatoria e una malattia terminale deve essere discussa in anticipo con tutte le persone coinvolte nel trattamento, compreso il paziente. Nel processo, è possibile concordare insieme un obiettivo terapeutico realisticamente raggiungibile, nel senso del “processo decisionale condiviso”. È anche importante che i limiti del trattamento, come la terapia intensiva limitata, siano chiaramente definiti e che vengano mostrate alternative che si concentrino sul benessere e sulla dignità del paziente. Il rischio di un aumento della morbilità e della mortalità post-operatoria aumenta con l’età, generalmente a partire da >70 anni, e aumenta anche con la riduzione della capacità funzionale (“fragilità”).
Evitare la trasfusione di sangue se l’emoglobina è ≥70 g/L – questo vale per i pazienti senza malattie sistemiche rilevanti in cui l’emorragia è controllata. Le trasfusioni devono essere effettuate tenendo conto delle comorbidità e dei parametri clinici, come la valutazione dell’emodinamica e della coagulazione, nell’ambito della gestione del sangue del paziente (PBM). I pazienti con anemia devono essere ottimizzati prima dell’intervento, quando possibile, e le misure di risparmio di sangue possono essere utilizzate generosamente negli interventi in cui si prevede una maggiore perdita di sangue (tab. 1).

Anche la diagnostica di routine preoperatoria (laboratorio, ECG, radiografia del torace) deve essere evitata nei pazienti senza malattie sistemiche rilevanti. La diagnostica preoperatoria di routine fa poco per identificare i pazienti a maggior rischio di complicazioni perioperatorie. I risultati patologici di laboratorio, dell’ECG o della radiografia del torace sono rari in questa situazione e non comportano cambiamenti nella gestione perioperatoria, soprattutto nelle procedure senza aumento del rischio. Il fattore decisivo per una valutazione del rischio è sempre un’anamnesi precisa e un esame clinico con la registrazione delle prestazioni fisiche. Tuttavia, nel caso di un’anamnesi vistosa o di prestazioni limitate, sono ovviamente indicati ulteriori esami mirati. Questo vale soprattutto per gli interventi ad alto rischio, dove sono necessari alcuni esami preoperatori per garantire un’adeguata assistenza perioperatoria.
Congresso: Congresso d’autunno della SGAIM
Letteratura:
- Gaspoz J-M: “Smarter Medicine” – concentrarsi sull’appropriatezza delle misure mediche”. Swiss Med Forum 2021; 21(5152): 867-868.
- “Chiarimenti preoperatori nella pratica – Scegliere con saggezza”, Roland Fischer, MD, Congresso autunnale SGAIM, 23.09.2022
- Richards T, et al: Ferro intravenoso preoperatorio per l’anemia nella chirurgia addominale maggiore aperta elettiva: l’RCT PREVENTT. Health Technol Assess 2021; 25(11):1-58.
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): L’urgente necessità di implementare la gestione del sangue dei pazienti: policy brief. 2021, https://apps.who.int/iris/handle/10665/346655, (ultimo accesso 12.10.2022).
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE): Trasfusione di sangue, linea guida NICE, 2015, www.nice.org.uk/guidance/ng24, (ultimo accesso 12.10.2022).
- Halvorsen S, et al: Linee guida ESC 2022 sulla valutazione e la gestione cardiovascolare dei pazienti sottoposti a chirurgia non cardiaca. Eur Heart J 2022 Aug 26:ehac270. doi: 10.1093/eurheartj/ehac270.
- Gruppo di lavoro interdisciplinare per l’emoterapia clinica, www.iakh.de/zeitschrift/neue-ESC-leitlinien.html, (ultimo accesso 12.10.2022).
- Linea guida S3 “Evitare l’ipotermia perioperatoria”, aggiornamento 2019. Versione definitiva al 15 maggio 2019, www.awmf.org, (ultimo accesso 12 ottobre 2022).
- “Top 5 Anestesia”, www.smartermedicine.ch/de/top-5-listen/anaesthesiologie-und-reanimation, (ultimo accesso 12.10.2022)
- Steffel J, et al: 2021 Guida pratica della European Heart Rhythm Association sull’uso degli anticoagulanti orali non antagonisti della vitamina k nei pazienti con fibrillazione atriale. Europace 2021; 23: 1612-1676.
PRATICA GP 2022; 17(10): 51-53