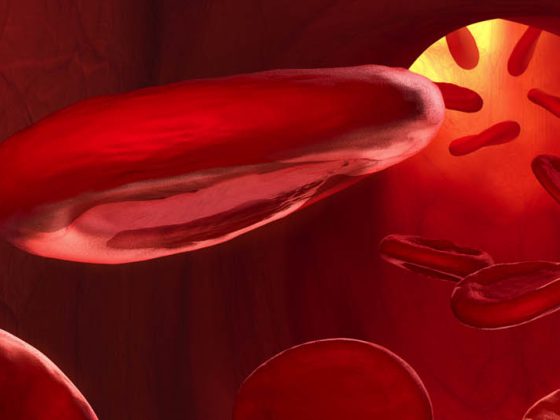Il cervello nella sclerosi multipla mostra cambiamenti strutturali e funzionali all’inizio del decorso della malattia, anche prima che si manifestino i deficit cognitivi. La migliore correlazione con lo stato cognitivo è attualmente considerata l’atrofia cerebrale. Tuttavia, i disturbi cognitivi sono nel complesso il risultato di un complesso disturbo di rete e non possono essere ricondotti alla disfunzione di singole aree cerebrali. Il rafforzamento della riserva cognitiva attraverso l’allenamento fisico e cognitivo dovrebbe essere un obiettivo preventivo e terapeutico.
Insieme alla stanchezza e ai disturbi affettivi, i deficit nelle prestazioni cognitive sono tra i sintomi chiave della sclerosi multipla (SM), che possono avere un forte impatto negativo sulla qualità di vita delle persone colpite, ma anche influenzare in modo decisivo l’aderenza alla terapia. I tassi di prevalenza sono indicati dal 43% [1] al 60% [2], a seconda degli studi. Quindi, circa un paziente con SM su due soffre di una perdita di prestazioni cognitive. I deficit possono manifestarsi all’inizio del decorso della malattia e possono anche manifestarsi come sintomi iniziali. Sono in gran parte indipendenti dal grado di disabilità e sono descritti anche in pazienti con un decorso benigno [3]. A differenza dei processi di demenza, la progressione dei deficit cognitivi nella SM è considerata moderata. Lo sviluppo maggiore si osserva nei primi cinque anni [4], per cui la diagnosi neuropsicologica più precoce possibile dei cosiddetti deficit di base, tenendo conto dei possibili fattori covarianti, è di grande rilevanza clinica.
Deficit cognitivi di base
Non tutte le aree cognitive sono ugualmente compromesse nella SM, quindi raramente si verifica un declino cognitivo generalizzato. Il fatto che alcuni sotto-aspetti cognitivi siano colpiti più di altri ha portato alla definizione di “deficit cognitivo di base” [5]. Questo include funzioni come la flessibilità mentale, la memoria a breve termine verbale e visuo-spaziale e la velocità di elaborazione delle informazioni. Le disfunzioni cognitive possono avere un forte impatto negativo sulla qualità di vita delle persone colpite, indipendentemente dalla gravità dei sintomi fisici. Diversi studi dimostrano che i pazienti con deficit cognitivo hanno meno probabilità di essere occupati, hanno bisogno di maggiore supporto per affrontare la vita quotidiana e sono meno coinvolti socialmente rispetto ai pazienti senza deficit cognitivo [6]. Inoltre, è stato dimostrato che la velocità di elaborazione delle informazioni nei pazienti con SM di nuova diagnosi era predittiva del loro stato occupazionale dopo sette anni [7]. Ciò significa che la registrazione delle prestazioni cognitive fin dall’inizio – oltre all’importanza personale per le persone colpite, che non deve essere sottovalutata – può avere anche un’importanza economica significativa per la salute.
Disturbi cognitivi e imaging
Sebbene la risonanza magnetica convenzionale (RM) sia molto importante per diagnosticare la SM e documentarne il decorso, non è una correlazione adeguata per la disfunzione cognitiva. Pertanto, non sorprende che gli studi iniziali che correlavano principalmente il carico di lesioni T2 e le ipointensità T1 con le prestazioni cognitive siano stati deludenti [8–10]. Solo il focus sul carico di lesioni regionali ha prodotto correlazioni interessanti con specifiche prestazioni cognitive parziali [11,12].
Attualmente, la migliore correlazione con le prestazioni cognitive è l’atrofia cerebrale, sia focale che globale. Pertanto, è necessario impegnarsi per integrare il test di atrofia nella pratica clinica di routine, insieme agli strumenti di screening cognitivo. In questo caso, tuttavia, il problema principale si presenta nella post-elaborazione dei dati raccolti con metodi di analisi specializzati come SIENAX, un software che non viene quasi mai utilizzato nel campo della pratica privata, ad esempio. In alternativa, la dimensione del terzo ventricolo non solo mostra un’ottima relazione con la cognizione [13,14], ma ha anche un valore predittivo [15].
La misurazione del terzo ventricolo è uno sforzo ragionevole per documentare l’evoluzione dell’atrofia nei controlli annuali e garantisce un buon rapporto costi-benefici.
Oltre all’atrofia cerebrale, esiste un altro parametro della risonanza magnetica con un buon valore correlativo e predittivo per quanto riguarda la cognizione nella SM. Questo è il rapporto di trasferimento della magnetizzazione (MTR). Con questo metodo, i cambiamenti microstrutturali nella materia bianca di aspetto normale (NAWM) possono essere caratterizzati in modo più preciso. Alcuni studi hanno trovato associazioni correlate – soprattutto nelle fasi iniziali della malattia – con la cognizione nella SM [16,17], suggerendo che la degenerazione assonale precoce delle fibre della rete intercorticale contribuisce al deterioramento cognitivo.
Ciò solleva la questione, effettivamente rilevante e decisiva, del perché i disturbi cognitivi si manifestano nella SM. La qualità dell’efficienza funzionale dei processi cognitivi non dipende principalmente dall’integrità delle singole aree della corteccia, ma piuttosto dalla corretta interazione di una rete complessa. Questo porta alla tesi che i cambiamenti cognitivi sono il risultato di un complesso disturbo di rete. Le prime indicazioni che il MS sta sperimentando un malfunzionamento della rete provengono dalle indagini sulla Rete in modalità predefinita (DMN). Questa rete è coerente in tutti gli individui sani e coinvolge il cingolo posteriore, il precuneo, la corteccia prefrontale mediale e la corteccia parietale inferiore. Questa rete è attivata al massimo quando una persona è in uno stato di riposo rilassato e non è impegnata in alcuna attività cognitiva. La disattivazione massima si verifica non appena il cervello passa all’attivazione cognitiva. Quindi, c’è un cambiamento frequente tra attivazione e disattivazione, per potersi adattare in modo ottimale alle condizioni esterne. Nei pazienti con SM con decorso progressivo, è stato riscontrato che questo DMN è alterato [18] e che questi cambiamenti, che interessano principalmente le parti frontali della rete, sembrano essere strettamente correlati ai deficit cognitivi osservati. Nei pazienti con un decorso recidivante, i risultati non sono così chiari. In uno studio che si è concentrato principalmente sulla velocità di elaborazione delle informazioni, i pazienti hanno mostrato cambiamenti di connettività nelle reti motorie e visive, ma non nella DMN. Al contrario, Cruz-Gomez e colleghi [19], che hanno preso in considerazione diversi domini cognitivi nei pazienti recidivanti-remittenti, hanno riportato anche cambiamenti nel DMN. Si può quindi concludere dai risultati di cui sopra che i cambiamenti di rete sono correlati ai cambiamenti cognitivi, ma i risultati dipendono fortemente dal criterio cognitivo scelto, da quando un paziente viene classificato come cognitivamente compromesso.
Diagnostica dei disturbi cognitivi
Una diagnosi affidabile dei deficit cognitivi è urgentemente raccomandata in considerazione degli alti tassi di prevalenza e della forte influenza negativa su diverse aree della vita dei pazienti. Le diagnosi neuropsicologiche vengono effettuate utilizzando procedure di test standardizzate e normate, con le quali è possibile mappare in modo affidabile le prestazioni cognitive. Tuttavia, un esame neuropsicologico completo richiede molto tempo, è costoso e può essere effettuato solo da professionisti qualificati. Poiché questi prerequisiti di solito non sono presenti nella routine clinica, sono stati sviluppati vari metodi di screening che consentono di oggettivare in modo efficiente in termini di tempo e di costi i principali deficit cognitivi rilevanti nella SM nella routine clinica.
A tal fine, e per garantire uno standard internazionale, nel 2012 un gruppo di esperti ha raccomandato l’implementazione del Brief International Cognitive Assessment for Multiple Sclerosis (BICAMS) [20]. La BICAMS rappresenta un tentativo di consenso per omogeneizzare la registrazione dei deficit cognitivi nella SM in tutto il mondo e quindi consentire un confronto internazionale. Grazie alle loro buone proprietà psicometriche, le seguenti tre procedure di test sono raccomandate in BICAMS: SDMT, CVLT-II e BVMT-R. Per il CVLT-II e il BVMT-R, si è deciso di includere solo le prove di apprendimento.
Ciò significa che per il CVLT-II devono essere completate le prime cinque sessioni di apprendimento e per il BVMT-R tre sessioni di apprendimento. Il tempo totale di implementazione di BICAMS è di 15 minuti. Per gli utenti che non possono prendere questo impegno di tempo, si raccomanda di effettuare almeno l’SDMT regolarmente (almeno una volta all’anno).
SDMT: nel Symbol Digit Modalities Test (SDMT [21]), ai pazienti vengono presentati nove simboli con l’assegnazione corrispondente dei numeri da 1 a 9. Il compito consiste nell’assegnare il numero corretto al rispettivo simbolo entro 90 secondi e nel dirlo ad alta voce all’esaminatore. Il modello con le assegnazioni corrette rimane visibile ai pazienti per tutta la durata della somministrazione del test. Questo test misura la velocità di elaborazione delle informazioni e la memoria di lavoro. L’SDMT ha dimostrato di essere un test sensibile, affidabile e pratico per l’uso clinico quotidiano. A causa dei problemi sopra menzionati che i pazienti hanno con il PASAT, si può ipotizzare che l’SDMT sostituirà sempre più il PASAT in termini di frequenza di utilizzo.
CVLT-II/VLMT: il California Verbal Learning Test-II (CVLT-II [22]) e il Verbal Learning and Memory Test (VLMT [23]) sono entrambe procedure che possono essere utilizzate per testare la memoria verbale a breve e a lungo termine e la capacità di apprendimento verbale. Nel CVLT-II, vengono lette ai pazienti 16 parole , quattro delle quali appartengono a una categoria sovraordinata (ad esempio, vestiti, verdure). Ai pazienti viene chiesto di memorizzare il maggior numero possibile di parole e di ripeterle subito dopo la presentazione. Ci sono cinque serie di ripetizioni. Questo è seguito da un secondo elenco di apprendimento che serve come compito di interferenza. In seguito, ai pazienti viene chiesto di ripetere liberamente l’elenco di parole che hanno imparato per prime. Dopo circa 30 minuti, viene effettuato un richiamo tardivo per verificare quanto sia stabile il richiamo delle parole del primo elenco di apprendimento nel tempo. Infine, c’è un test di riconoscimento in cui le parole dei due elenchi di apprendimento vengono presentate insieme a parole che non sono ancora state presentate. Il compito è di nuovo quello di riconoscere solo le parole dell’elenco appreso prima.
Il VLMT ha una struttura simile, tranne per il fatto che vengono presentate solo 15 parole e non ci sono categorie di parole di livello superiore. Nella validazione tedesca del BICAMS, viene utilizzato il VLMT perché questo strumento fornisce dati normativi molto buoni.
BVMT-R: il Brief Visual Memory Test-Revised (BVMT-R [24]) misura la memoria visuo-spaziale a breve e lungo termine e le prestazioni di riconoscimento. Ai pazienti viene presentato un foglio con sei forme geometriche per dieci secondi. Poi si chiede ai pazienti di disegnare queste forme e la loro localizzazione nel modo più accurato possibile su un foglio di carta bianco. Ci sono tre turni in totale, durante i quali i pazienti hanno dieci secondi ciascuno per memorizzare le sei forme e la loro localizzazione. Dopo 30 minuti, in questo test c’è anche un richiamo tardivo per verificare la memoria visuo-spaziale a lungo termine. In una fase finale, le prestazioni di riconoscimento dei pazienti vengono testate presentando le figure da memorizzare mescolate con nuove forme.
CAVE: al BICAMS si terranno solo le prove di apprendimento!
Terapia dei disturbi cognitivi
La domanda se una terapia per i disturbi cognitivi abbia senso o meno deve essere risolta in ogni singolo caso, dopo aver effettuato la diagnosi neuropsicologica. Purtroppo, attualmente non esiste un gold standard basato sulle prove.
Sostanze immunomodulanti: Le comuni sostanze immunomodulanti (interferoni e glatiramer acetato) offrono una certa protezione contro un ulteriore deterioramento delle prestazioni cognitive, perché smorzano la risposta infiammatoria. Tuttavia, un’efficacia specifica deve essere classificata come piuttosto moderata. Sono disponibili i dati di quattro studi che documentano un effetto favorevole sulle prestazioni cerebrali [25–28].
In sintesi, questi studi dimostrano che le terapie di base possono effettivamente influenzare le funzioni cognitive in modo positivo. Tuttavia, sembra esagerato attestare alla terapia di base un’efficacia specifica per la cognizione.
Approcci di trattamento sintomatico non farmacologico: Poiché le prove di efficacia delle terapie farmacologiche non sono finora convincenti, gli approcci terapeutici non farmacologici sono un’alternativa da considerare.
Attualmente esistono solo due studi randomizzati e controllati sull’efficacia dello sport e dell’esercizio fisico (training di esercizio) sulle prestazioni cognitive dei pazienti con SM, che sono giunti a una conclusione negativa [29,30]. Questo è in chiara contraddizione con i risultati positivi riscontrati negli studi gerontologici [31–33]. Tuttavia, esaminando gli studi trasversali su pazienti con SM con diversi livelli di disabilità, è stato riscontrato un effetto positivo dell’esercizio fisico sulle prestazioni cognitive [34].
Oltre all’esercizio fisico, la riabilitazione cognitiva offre una promettente alternativa di trattamento. Il concetto di fondo è che le prestazioni cognitive parziali vengono allenate attraverso la stimolazione cognitiva, al fine di stimolare percorsi di comunicazione alternativi nel cervello e quindi migliorare le prestazioni dei pazienti. In uno studio condotto da Penner e colleghi [35], i pazienti affetti da SM sono stati trattati con un allenamento computerizzato della memoria di lavoro “BrainStim” [36]. Dopo quattro settimane di allenamento intensivo e dopo otto settimane di allenamento, i pazienti sono stati in grado di migliorare significativamente le loro prestazioni [37]. Inoltre, i pazienti hanno migliorato la gravità dei loro sintomi di affaticamento dopo l’allenamento. In questo contesto, la riabilitazione cognitiva può essere intesa come un intervento il cui obiettivo primario è quello di apportare cambiamenti negli aspetti psicosociali (ad esempio, la motivazione, la fatica) e nei circuiti neuronali specifici.
Gli studi che hanno esaminato l’efficacia di un intervento cognitivo attraverso la risonanza magnetica funzionale (MRI) sono stati in grado di dimostrare che, dopo un addestramento di successo, si sono attivate ulteriori aree cerebrali direttamente correlate ai processi cognitivi esaminati [38–41].
Conclusione e sintesi
A causa della loro elevata prevalenza, i disturbi cognitivi non sono solo sintomi gravi nel contesto della SM, ma dovrebbero avere la stessa importanza della progressione EDSS, del tasso di ricaduta e dei cambiamenti della risonanza magnetica nella valutazione dell’attività e della progressione della malattia. Riconoscere, diagnosticare e caratterizzare chiaramente i disturbi cognitivi è un primo passo importante che non dovrebbe più mancare in nessuna valutazione neurologica. Dal punto di vista metodologico, sono disponibili ottime procedure di screening, efficienti in termini di tempo e di costi. L’SDMT può rilevare un deficit nelle aree cognitive centrali, la velocità di elaborazione delle informazioni e la memoria di lavoro, in cinque minuti. Dal punto di vista terapeutico, attualmente mancano buoni approcci farmacologici. Dal punto di vista non farmacologico, gli interventi cognitivi e sportivi sono modi interessanti e potenti per influenzare positivamente la riserva cognitiva.
Per molto tempo, i disturbi delle prestazioni cognitive nel contesto della SM hanno ricevuto poca attenzione. Tuttavia, se si chiede alle stesse persone colpite, diventa subito chiaro che il deterioramento delle prestazioni cognitive grava sui pazienti molto più dei sintomi fisici. Oggi è noto che quasi una persona su due con SM prima o poi lamenterà tali cambiamenti. Dal punto di vista scientifico, l’interesse per la cognizione è cambiato nella misura in cui viene accettata come endpoint essenziale negli studi di intervento, la sua estensione e la sua causa vengono indagate in dettaglio negli studi con le tecniche di imaging più recenti e vengono fatti tentativi terapeutici per ottenere un miglioramento per i pazienti attraverso approcci di riabilitazione cognitiva. Tuttavia, l’importanza della cognizione nella pratica clinica è cambiata poco finora. In questo caso, l’attenzione rimane sul tasso di recidiva, sulla progressione EDSS e sul numero di focolai arricchiti di gadolinio quando si tratta di documentare il decorso della malattia e l’attività patologica. La mancanza di tempo è spesso citata come motivo per non continuare a prestare un’attenzione significativa alla cognizione (oltre alla mancanza di strumenti di misurazione affidabili e sensibili e alla mancanza di una terapia disponibile). Ciò che rimane sono pazienti insicuri, la cui sofferenza è in costante aumento e che non di rado si sentono incompresi dai loro medici curanti.
Letteratura:
- Rao SM, et al: Neurology 1991; 41: 685-691.
- Benedict RH, et al: JINS 2006; 12(4): 549-558.
- Amato MP, et al: J Neurol 2006; 253(8): 1054-1059.
- Amato MP, et al: Arch Neurol 2001; 58: 1602-1606.
- Calabrese P, Penner IK: J Neurol 2007; 254: 18-21.
- Amato MP, et al: Arch Neurol 1995; 52: 168-172.
- Ruet A, et al: J Neurol 2013; 260: 776-784.
- Camp SJ, et al: Brain 1999; 122: 1341-1348.
- Fulton JC, et al: AJNR 1999; 20: 1951-1955.
- Rovaris M, et al: Neurology 1998; 50(6): 1601-1608.
- Pujol J, et al: NeuroImage 2001; 13: 68-75.
- Sperling RA, et al: Arch Neurol 2001; 58: 115-121.
- Benedict RH, Carone DA, Bakshi R: J Neuroimaging 2004; 14: 36S-45S.
- Tiemann L, et al: Mult Scler 2009; 15(10): 1164-1174.
- Deloire MS, et al: Neurology 2011; 76(13): 1161-1167.
- Deloire MSA, et al: JNNP 2005; 76: 519-526.
- Khalil M, et al: Mult Scler 2011; 17(2): 173-180.
- Rocca MA, et al: Neurology 2010; 74(16): 1252-1259.
- Cruz-Gomez AJ, et al: Mult Scler 2013 [Epub ahead of print].
- Smith A: Test delle modalità delle cifre simboliche. 1973.
- Delis DC, et al: Test di apprendimento verbale della California. 2000.
- Helmstaedter C, Lendt M, Lux S: VLMT – Test di apprendimento verbale e memoria. Manuale. 2001.
- Benedict RH: Brief Visuospatial Memory Test-Revised (BVMT-R). Lutz, FL: 1997.
- Langdon DW, et al: Mult Scler 2012; 18(6): 891-898.
- Fischer JS, et al: Ann Neurol 2000; 48: 885-892.
- Penner IK, et al: Mult Scler 2012; 18(10): 1466-1471.
- Patti F, et al: Mult Scler 2010; 16(1): 68-77.
- Ziemssen T, et al: J Neurol 2014 [Epub ahead of print].
- Oken BS, et al: Neurology 2004; 62(11): 2058-2064.
- Romberg A, Virtanen A, Ruutiainen J: J Neurol 2005; 252(7): 839-845.
- Colcombe S, Kramer AF: Psychol Sci 2003; 14(2): 125-130.
- Colcombe SJ, et al: Proc Natl Acad Sci U S A 2004; 101: 3316-3321.
- Jedrziewski MK, et al: Alzheimers Dement 2010; 6(6): 448-455.
- Prakash RS, et al: NeuroImage 2007; 34(3): 1238-1244.
- Penner IK, Kappos L: J Neurol Sci 2006; 245: 147-151.
- Penner IK, Kobel M, Opwis K: BrainStim. 2006; 17-18.
- Vogt A, et al: Restor Neurol Neurosc 2009; 27: 225-235.
- Chiaravalloti ND, et al: J Neurol 2012; 259(7): 1337-1346.
- Filippi M, et al: Radiology 2012; 262(3): 932-940.
- Penner IK, et al: J Physiol Paris 2006; 99: 455-462.
- Sastre-Garriga J, et al: Mult Scler 2011; 17(4): 457-467.
InFo NEUROLOGIA & PSICHIATRIA 2014; 12(6): 10-14