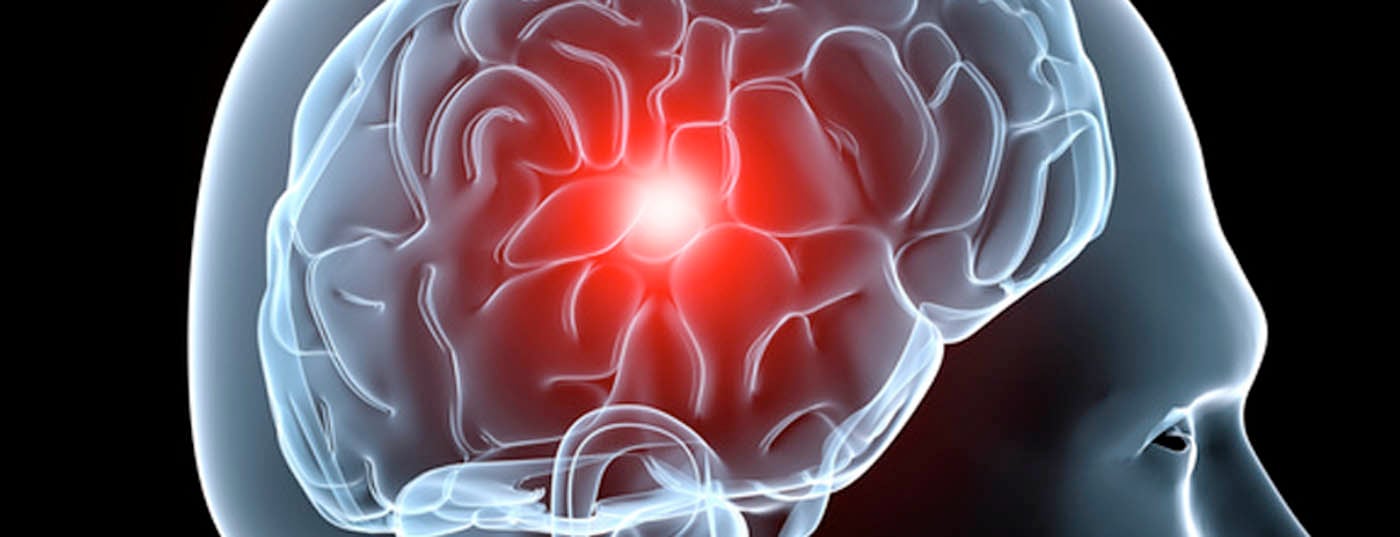L’ictus è una perdita spesso persistente della funzione del sistema nervoso centrale, dovuta a una carenza critica di sangue. Milioni di persone in tutto il mondo subiscono un ictus di questo tipo ogni anno, e migliaia muoiono di conseguenza o soffrono di disabilità permanenti. Una malattia rara ma importante da riconoscere è la malattia di Moyamoya (sin. sindrome di Moyamoya, angiopatia di Moyamoya). Questo spesso porta a ictus ed emorragie cerebrali ricorrenti nei bambini e negli adolescenti, ma anche negli adulti.
L’angiopatia di Moyamoya, chiamata anche “occlusione spontanea del circolo di Willisi”, è stata descritta per la prima volta da Takeuchi e Shimizu nel 1957 [1]. La caratteristica principale della malattia è un restringimento bilaterale e lentamente progressivo o addirittura l’occlusione delle grandi arterie della circolazione cerebrale anteriore vicino alla base del cranio, a partire dall’arteria carotide interna terminale. In risposta al conseguente stato di riduzione permanente del flusso sanguigno, si forma una rete vascolare anomala di collaterali, principalmente nei gangli della base e intorno ad essi. Nell’angiografia a sottrazione digitale (DSA), questa fragile rete vascolare assomiglia a una “nuvola di fumo alla deriva nell’aria”, o “moyamoya” in giapponese [2].
L’angiopatia di Moyamoya è stata a lungo considerata una malattia limitata al Giappone e all’Asia orientale. Non è stata riconosciuta in Nord America e in Europa fino alla fine degli anni ’60 [3] ed è stata registrata epidemiologicamente a partire dagli anni ’90 [4,5]. L’incidenza è di circa 0,3/100 000 in Giappone [6] e di circa 0,09/100 000 negli Stati Uniti. In Europa, sono stati registrati quasi duecento casi nell’ultima indagine sistematica, con una prevalenza notevolmente aumentata nei bambini e nei giovani adulti (picco di frequenza tra zero e nove anni; secondo picco tra 20-30 anni) [6]. Negli Stati Uniti e in Europa, circa il 50-70% dei pazienti con malattia di Moyamoya sono caucasici. Mentre la distribuzione dei sessi è 1:1 tra i bambini, due terzi degli adulti sono di sesso femminile. La stragrande maggioranza dei casi di moyamoya è di natura sporadica, e solo circa un caso su dieci ha probabilmente un’origine familiare [7].
Patologia
L’esatta eziologia e i percorsi biologici coinvolti non sono del tutto chiari, anche se si sospetta una componente genetica. Istologicamente, si osservano cambiamenti della parete del vaso con il tipico ispessimento fibrocellulare concentrico (ipertrofia) dell’intima, il raddoppio della lamina elastica interna e l’assottigliamento (atrofia) della media. Caratteristica è anche l’assenza di infiltrati infiammatori, come si riscontra tipicamente nelle malattie della parete arteriosa (ad esempio, arteriosclerosi o artrite).
Sintomatologia
I pazienti adulti affetti da moyamoya soffrono di episodi ischemici ricorrenti (TIA e ictus) nel 60% dei casi e di emorragia cerebrale nel 15-20%, in genere nell’area dei gangli della base. Le cefalee croniche refrattarie alla terapia possono essere presenti anche nel 70% dei casi. Caratteristiche sono inizialmente le ischemie ricorrenti spesso inspiegabili. Nei bambini e negli adolescenti, l’emorragia cerebrale è estremamente rara; predominano le ischemie cerebrali transitorie ripetute con deficit sensitivo-motorio. Nel decorso naturale, si stima che oltre il 60-70% dei pazienti subirà un ictus entro cinque anni. Dato questo alto tasso di morbilità nei pazienti non trattati, il work-up diagnostico più precoce possibile, seguito da un intervento preventivo per ripristinare un’emodinamica cerebrale equilibrata, è diventato lo standard di cura – almeno nel mondo occidentale [8,9].
Diagnostica
La diagnosi di angiopatia moyamoya si basa sulle linee guida modificate di Fukui [10,11]. Il work-up preoperatorio inizia sempre con un’anamnesi dettagliata e un esame neurologico approfondito. La risonanza magnetica (RM) e l’angiografia a risonanza magnetica (MRA) spesso consentono già una diagnosi provvisoria. Sono tipici i segni di ischemie multiple di età diverse. La MRA dimostra la stenosi o l’occlusione dell’arteria carotide interna vicino alla base del cranio e la neovascolarizzazione patologica nei gangli della base. Per ulteriori chiarimenti, viene eseguito un DSA a 6 vasi [2,12] per valutare la situazione vascolare e la tomografia a emissione di positroni (PET) o la tomografia computerizzata allo xeno (TC allo xeno) per determinare la capacità di riserva emodinamica.
Trattamento
L’obiettivo del trattamento è ripristinare un sufficiente apporto di sangue al cervello (rivascolarizzazione) [13,14]. Le tecniche chirurgiche consolidate si dividono fondamentalmente in interventi di bypass “diretti” e “indiretti”. Nel bypass diretto, un’arteria terminale della carotide esterna (ad esempio, l’arteria temporale superficiale) viene anastomizzata a un’arteria ricevente intracranica (ad esempio, l’arteria cerebrale media) mediante una tecnica microchirurgica (bypass EC-IC) (Fig. 1) [9,15]. Nella rivascolarizzazione indiretta, l’arteria del cuoio capelluto viene trapiantata insieme al muscolo temporale (encefalomioarteriosinangiosi) o senza il muscolo temporale (encefalarteriosinangiosi) sulla superficie cerebrale della metà poco perfusa del cervello [16,17]. Tutte le cosiddette tecniche di bypass indiretto stimolano la formazione di una nuova rete vascolare sulla superficie corticale e dovrebbero quindi contribuire a una certa integrazione dell’apporto di sangue cerebrale. Poiché la malattia si manifesta tipicamente in modo bilaterale, anche questo trattamento deve essere eseguito bilateralmente, di solito in due interventi. Il rischio di una complicazione neurologica con questa procedura in mani esperte è dell’1-2% [8]. Le tecniche endovascolari con angioplastica a palloncino e stenting non hanno mostrato successo nella malattia di Moyamoya.
Risultati del trattamento
È essenziale che la modalità e la tempistica del trattamento siano determinate in stretta collaborazione con un team interdisciplinare di esperti. Il campo della chirurgia dei bypass appartiene alla medicina altamente specializzata (HSM). Un’équipe di questo tipo è composta da un neurochirurgo specializzato – un neurochirurgo pediatrico nel caso dei bambini – un neurologo e un neuroradiologo esperto. Data la complessità delle procedure chirurgiche, questo intervento deve essere eseguito esclusivamente da un team con una comprovata esperienza nella neurochirurgia cerebrovascolare e nelle tecniche di bypass. Secondo la nostra esperienza e quella di altri centri internazionali, si possono prevedere risultati da molto buoni a eccellenti nella maggior parte dei casi, cioè una riduzione significativa del rischio di ictus (Fig. 2) [8,18].

Letteratura:
- Takeuchi K, Shimizu K: Ipoplasia delle arterie carotidi interne bilaterali. Brain & Nerve 1957; 9: 37-43.
- Suzuki J, Takaku A: Malattia cerebrovascolare “moyamoya”. La malattia mostra vasi anomali simili a reti nella base del cervello. Arch Neurol Mar 1969; 20(3): 288-299.
- Picard L, Lévesque M, Crouzet G: La sindrome “moyamoya”. J Neuroradiol 1974; 1: 47-54.
- Yonekawa Y, et al: La malattia di Moyamoya in Europa, stato passato e presente. Clin Neurol Neurosurg Oct 1997; 99(Suppl 2): 58-60.
- Yonekawa Y, Taub E: Malattia di Moyamoya. Stato 1998. Neurologist 1999; 5: 13-23.
- Suzuki J: La malattia di Moyamoya. Berlino: Springer 1983.
- Fukui M: Stato attuale dello studio sulla malattia di moyamoya in Giappone. Neurologia chirurgica febbraio 1997; 47(2): 138-143.
- Guzman R, et al: Esito clinico dopo 450 procedure di rivascolarizzazione per la malattia di Moyamoya. Articolo clinico. Journal of Neurosurgery Nov 2009; 111(5): 927-935.
- Guzman R, Steinberg GK: Tecniche di bypass diretto per il trattamento della malattia di moyamoya pediatrica. Neurosurgery Clinics of North America Jul 2010; 21(3): 565-573.
- Fukui M: Linee guida diagnostiche per l’occlusione spontanea del circolo di Willis (malattia di Moyamoya). Rapporto annuale 1995. Il Comitato di Ricerca sull’Occlusione Spontanea del Circolo di Willis (Malattia di Moyamoya) del Comitato per la Salute e il Benessere. Tokyo 1995: 162-163.
- Fukui M: Linee guida per la diagnosi e il trattamento dell’occlusione spontanea del circolo di Willis (malattia di moyamoya). Comitato di Ricerca sull’Occlusione Spontanea del Circolo di Willis (Malattia di Moyamoya) del Ministero della Salute e del Benessere, Giappone. Clin Neurol Neurosurg 1997; 99(Suppl 2): 238-240.
- Mugikura S, et al: Coinvolgimento predominante della circolazione anteriore e posteriore omolaterale nella malattia di Moyamoya. Stroke Jun 2002; 33(6): 1497-1500.
- Lee M, et al: Analisi del flusso sanguigno intraoperatorio delle procedure di rivascolarizzazione diretta nei pazienti con malattia di Moyamoya. Journal of cerebral blood flow and metabolism: official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism Gennaio 2011; 31(1): 262-274.
- Lee M, et al: Studi emodinamici quantitativi nella malattia di moyamoya: una revisione. Neurosurgical focus aprile 2009; 26(4): E5.
- Donaghy RM, Yasargil MG (eds.): Chirurgia microvascolare. Stoccarda: Thieme 1967.
- Matsushima T, et al: Un metodo di rivascolarizzazione indiretta nel trattamento chirurgico della malattia di Moyamoya – vari tipi di procedure indirette e una procedura indiretta multipla combinata. Neurol Med Chir (Tokyo) 1998; 38 Suppl: 297-302.
- Matsushima Y, et al: Un nuovo trattamento chirurgico della malattia di moyamoya nei bambini: un rapporto preliminare. Neurologia chirurgica aprile 1981; 15(4): 313-320.
- Veeravagu A, et al: La malattia di Moyamoya nei pazienti pediatrici: esiti degli interventi neurochirurgici. Neurosurgical focus 2008; 24(2): E16.
- Hallemeier CL, et al: Caratteristiche cliniche ed esito negli adulti nordamericani con fenomeno di moyamoya. Stroke 2006 Jun; 37(6): 1490-1496.
PRATICA GP 2015; 10(10): 8-9