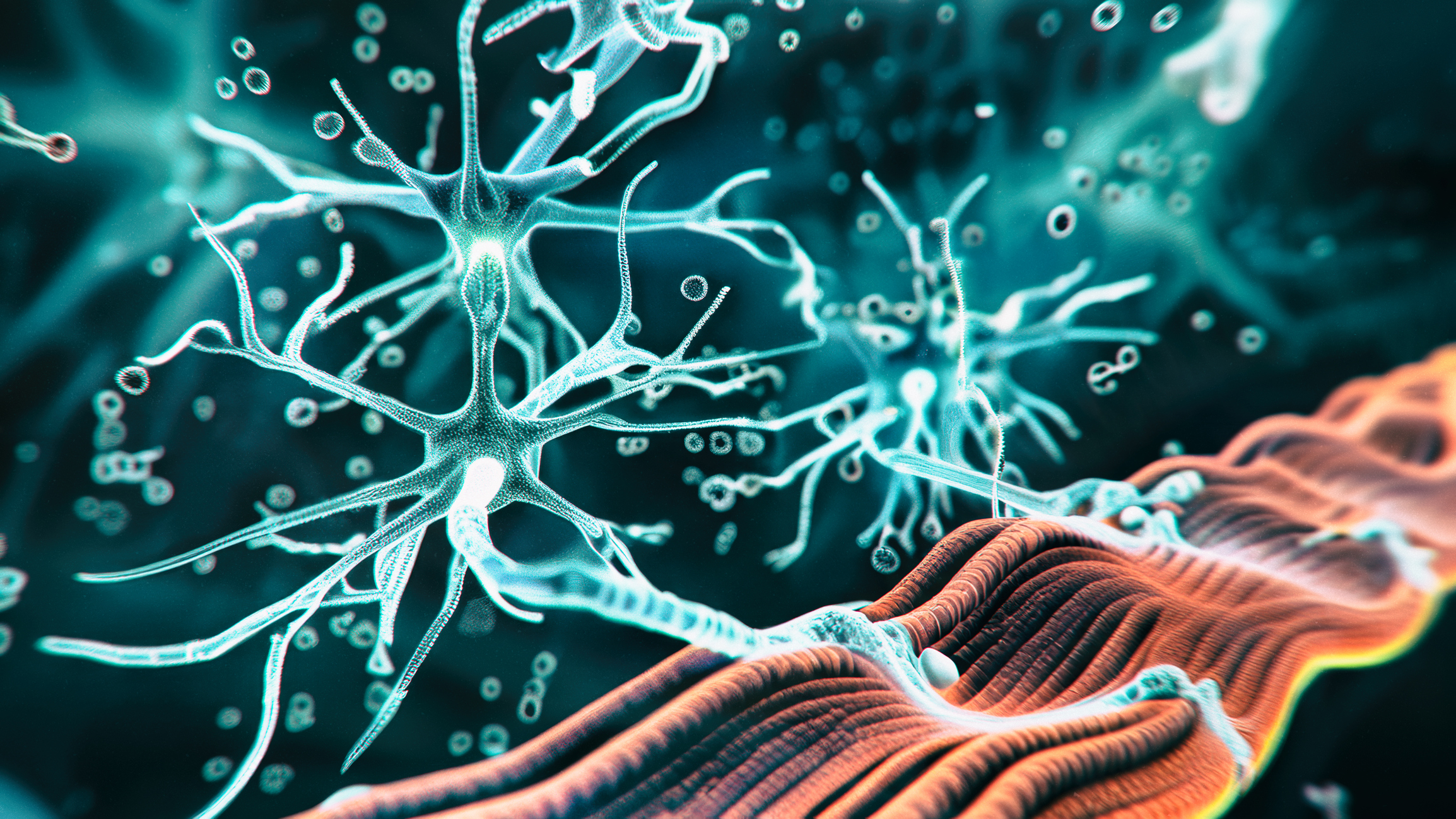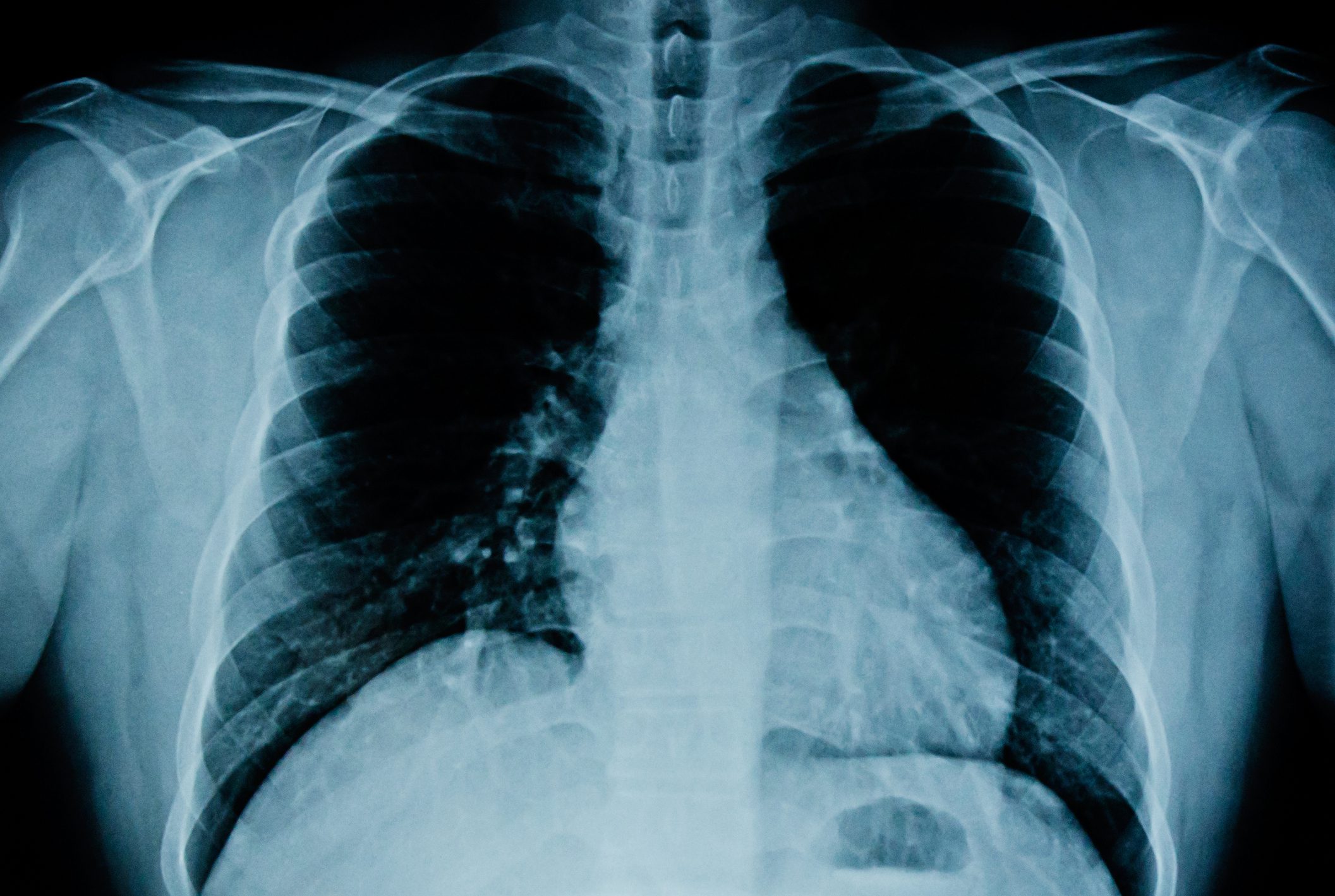Il cancro al seno può essere prevenuto nelle donne sane con i farmaci. Gli studi dimostrano l’efficacia. In alcuni Paesi, la terapia endocrina è approvata per questa indicazione. Tuttavia, l’accettazione della chemioprevenzione è generalmente bassa. C’è stata una notizia in merito alla Conferenza sul cancro al seno di San Gallo.
Il trattamento farmacologico preventivo delle donne sane che hanno un rischio elevato di tumori al seno, ad esempio a causa di una storia familiare, non è generalmente ben accettato – nonostante l’approvazione in alcuni Paesi e sebbene possa essere un’alternativa alle procedure altamente invasive della mastectomia bilaterale o dell’ooforectomia per alcune donne. Le sostanze in questione sono efficaci e relativamente sicure. Tuttavia, la disponibilità di molti pazienti ad alto rischio a tollerare gli effetti collaterali della chemioprofilassi è bassa nel lungo termine. Ciò può essere dovuto non da ultimo al fatto che mancano ancora prove chiare di un vantaggio di sopravvivenza. Tuttavia, le ragioni esatte del rifiuto rimangono poco chiare.
Il dottor Jack Cuzick ha riepilogato i progressi e le scoperte degli ultimi anni e ha mostrato quali sono le aree di applicazione ottimali per la prevenzione.
Gli inizi
Sono passati più di trent’anni da quando, nel 1985, è stata pubblicata la prima prova che il tamoxifene adiuvante svolge un ruolo cruciale non solo nel trattamento del cancro al seno, ma anche nella sua prevenzione [1]. Questa osservazione non è dovuta a una condizione specifica del cancro al seno: Se un seno ha già un tumore e viene trattato, è possibile osservare se anche il secondo seno, che è ancora sano, beneficia della terapia o sviluppa un tumore meno frequentemente in seguito. Il tamoxifene ha ridotto significativamente l’incidenza cumulativa del cancro al seno controlaterale da 10 a 3 casi. Questa osservazione è stata confermata da ulteriori studi, che hanno portato, tra l’altro, un gruppo intorno al Dr. Cuzick a proporre già nel 1986 che il cancro al seno non deve essere trattato solo terapeuticamente, ma anche preventivamente con farmaci (in modo simile alle malattie cardiovascolari).
Il tamoxifene è stato quindi il primo principio attivo ad essere studiato in questo contesto. Poco dopo la pubblicazione di cui sopra, sono seguiti lo studio Royal Marsden, lo studio NSABP-P1, uno studio italiano e infine lo studio IBIS-I (in cui il dottor Cuzick è stato coinvolto in modo decisivo) – tutti testano il tamoxifene alla dose di 20 mg/d in popolazioni a rischio aumentato. Inoltre, c’era un’ampia evidenza di studi che continuavano a studiare il tamoxifene nel contesto adiuvante e fornivano dati sul seno controlaterale.
Effetto preventivo per almeno 20 anni
L’oratore ha sottolineato in particolare lo studio IBIS-I. Hanno partecipato oltre 7000 pazienti ad alto rischio in pre e postmenopausa. Hanno ricevuto tamoxifene o placebo per una durata della terapia di cinque anni. Nel frattempo, la durata mediana del follow-up è di ben 16 anni (per molte donne addirittura 20 anni) – il cecità da parte degli sperimentatori e dei pazienti è stata mantenuta per la maggior parte di questo periodo [2]. I risultati sono impressionanti: 20 mg/d di tamoxifene per cinque anni hanno ridotto il rischio di cancro al seno del 28% dopo soli dieci anni. Il Number Needed to Treat (NNT) a quel tempo era di 59, il che significa che bisognava trattare 59 donne ad alto rischio nell’arco di cinque anni per proteggere una di loro dal cancro al seno entro i primi dieci anni. Se il gruppo è stato osservato per altri dieci anni – senza che le pazienti dovessero assumere nuovamente il tamoxifene – il beneficio preventivo della terapia endocrina è stato ancora più pronunciato. Nel complesso, si è verificata una riduzione dell’incidenza del tumore al seno dal 12,3% al 7,8%, corrispondente a un NNT di 22. Quindi, la terapia preventiva primaria per cinque anni protegge dal cancro al seno in un gruppo di 22 donne nei 20 anni successivi. La riduzione del rischio dopo il follow-up prolungato è stata del 29%. Nel carcinoma mammario invasivo positivo al recettore degli estrogeni, la percentuale era ancora più elevata, pari al 34% (tassi a lungo termine dell’8,3% contro il 4,9%, NNT=29). Questo è l’obiettivo principale della prevenzione. I casi invasivi negativi al recettore degli estrogeni non potevano essere prevenuti dal tamoxifene.
Inoltre, le curve divergono ulteriormente, quindi è possibile che l’effetto preventivo non sia limitato a 20 anni. Un’ulteriore estensione dello studio fornirà informazioni in merito.
A differenza di altri studi, l’IBIS-I consentiva una terapia ormonale sostitutiva (TOS) concomitante, se necessario, che si è rivelata svantaggiosa. Le donne in terapia ormonale sostitutiva hanno sperimentato un effetto significativamente minore della somministrazione di tamoxifene rispetto a quelle senza terapia ormonale sostitutiva.
I pazienti vivono anche più a lungo?
Ciò che non è stato ancora dimostrato nell’IBIS-I è un prolungamento della sopravvivenza specifica per il cancro al seno o un impatto significativo del tamoxifene sui tassi di mortalità specifica per il cancro al seno. Potrebbe essere semplicemente troppo presto per osservare un tale effetto, come sospettava il dottor Cuzick. La potenza statistica è attualmente ancora insufficiente, la maggior parte delle donne che si sono ammalate sono fortunatamente ancora vive. Pertanto, bisognerebbe attendere almeno altri dieci anni di follow-up per poter provare – o non provare – un effetto statisticamente rilevante. Dopo i primi dieci anni, si è registrato inizialmente un leggero aumento della mortalità con il tamoxifene, che tuttavia non è aumentato ulteriormente nel corso dell’osservazione, ma è diminuito nuovamente. Naturalmente, si è consapevoli dei potenziali effetti sullo sviluppo del carcinoma endometriale. Tuttavia, l’aumento della mortalità in quest’area non è stato significativo finora (5 contro 0 decessi). Non c’è stato alcun aumento della mortalità per tutte le cause.
In sintesi, il tamoxifene ha chiaramente un effetto preventivo sull’incidenza, ma c’è ancora incertezza sugli effetti sulla prognosi di sopravvivenza.
Ulteriori approcci di prevenzione
Dopo il tamoxifene, è stato testato se un altro modulatore selettivo del recettore degli estrogeni (SERM), ossia il raloxifene, potesse ottenere un effetto preventivo. Sono seguiti altri due grandi studi con lasofoxifene e arzoxifene. Nel trattamento adiuvante, sono stati approvati gli inibitori dell’aromatasi (letrozolo, anastrozolo, exemestane), che hanno fornito risultati promettenti anche nella prevenzione – e infine, agenti come FANS, bifonati, metformina e statine sono stati studiati con risultati (almeno finora) meno convincenti nel contesto preventivo.
SERM: lo studio MORE e la sua estensione, CORE, mostrano riduzioni drammatiche del rischio del 60% (raloxifene). Inoltre, c’è lo studio RUTH e infine lo studio STAR. Il relatore ha approfondito quest’ultimo aspetto. Con quasi 20.000 partecipanti, lo studio era molto ampio. Hanno confrontato direttamente il raloxifene 60 mg/d con il tamoxifene 20 mg/d – questo in pazienti ad alto rischio in postmenopausa per una durata della terapia di cinque anni. Mentre la valutazione iniziale [3] suggeriva l’equivalenza dei due approcci, dopo un follow-up prolungato di 81 mesi [4], il tamoxifene si è dimostrato più efficace del 24% rispetto al raloxifene in termini di prevenzione (p=0,01). Grazie alla migliore tolleranza (soprattutto per quanto riguarda l’endometrio), il raloxifene rimane un’opzione, ha detto il relatore. Tuttavia, i risultati sono piuttosto deludenti rispetto alle speranze suscitate da MORE/CORE. Con il lasofoxifene, è stato riscontrato un chiaro effetto nello studio PEARL a dosi più elevate, ma lo sviluppo nell’indicazione corrispondente non è attualmente perseguito. Tenendo conto dell’eterogeneità degli studi (obiettivi) citati, si può approssimativamente ipotizzare una riduzione del rischio nell’ordine del 30-40% dopo dieci anni. Si può prevedere una riduzione del rischio leggermente superiore per i tumori al seno invasivi positivi al recettore degli estrogeni.
Inibitori dell’aromatasi: anche in questo caso, le prime prove provengono dal contesto adiuvante. Due studi hanno anche analizzato la classe di farmaci nelle donne in postmenopausa senza cancro al seno ma ad alto rischio. Uno di questi, chiamato MAP3 [5], ha osservato una marcata riduzione del rischio del 65% con exemestane rispetto al placebo (p=0,002). Il periodo di osservazione è stato piuttosto breve, con una mediana di poco più di 30 mesi. Si è scoperto che dopo questo periodo (il follow-up era allora ovviamente limitato), è successo ancora di più.
Il secondo studio di quest’area si chiama IBIS-II [6]. In questo caso, l’anastrozolo (1 mg/d) è servito come agente sperimentale. È stato somministrato a 3864 donne in postmenopausa di età compresa tra i 40 e i 70 anni con un rischio elevato di cancro al seno (tra cui anamnesi familiare, atipia, carcinoma lobulare in situ [LCIS], alta densità mammaria) per cinque anni. La TOS non è stata consentita questa volta. I risultati sono stati paragonabili a quelli di MAP3. Nell’endpoint primario, l’incidenza complessiva del cancro al seno, è stata riscontrata una riduzione del rischio del 53% con l’inibitore dell’aromatasi dopo un follow-up mediano di cinque anni (p<0,0001) – una forte evidenza che l’anastrozolo è un buon agente preventivo, secondo il dottor Cuzick. Quando i tumori al seno invasivi positivi al recettore degli estrogeni sono stati considerati separatamente, la riduzione è stata maggiore, come nell’endpoint primario di MAP3, ossia il 58% (nei casi invasivi negativi al recettore degli estrogeni non c’è stato di nuovo un effetto significativo).

Rispetto ai precedenti studi adiuvanti, il tasso di fratture è stato inferiore e aumentato in modo non significativo rispetto al placebo (8,5% vs. 7,7%). Ciò era dovuto anche al fatto che le donne osteoporotiche assumevano bifosfonati e quelle con osteopenia si sottoponevano a regolari scansioni DXA. Gli eventi muscoloscheletrici, un problema noto in caso di terapia con inibitori dell’aromatasi, si sono verificati molto frequentemente, ossia nel 64% del gruppo di studio, ma anche nel 57,8% del gruppo di controllo (p=0,0001). In situazioni non controllate, spesso vengono attribuiti interamente agli inibitori dell’aromatasi, e gran parte di essi sono semplicemente legati a fattori non influenzabili come l’età, ha detto l’esperto. Naturalmente, se gli inibitori dell’aromatasi dovessero essere ampiamente utilizzati nella prevenzione, si dovrebbe pensare di accompagnare la terapia con l’esercizio fisico per prevenire tali eventi.
Panoramica 1 riassume i risultati più importanti della prevenzione del cancro al seno attraverso la terapia endocrina.
Fonte:15a Conferenza internazionale sul cancro al seno di San Gallo, 15-18 marzo 2017, Vienna.
Letteratura:
- Cuzick J, Baum M: Tamoxifene e cancro al seno controlaterale. Lancet 1985 Aug 3; 2(8449): 282.
- Cuzick J, et al: Tamoxifene per la prevenzione del cancro al seno: follow-up esteso a lungo termine dello studio di prevenzione del cancro al seno IBIS-I. Lancet Oncol 2015 Jan; 16(1): 67-75.
- Vogel VG, et al: Effetti del tamoxifene rispetto al raloxifene sul rischio di sviluppare un carcinoma mammario invasivo e altri esiti patologici: lo studio NSABP Study of Tamoxifen and Raloxifene (STAR) P-2. JAMA 2006 Jun 21; 295(23): 2727-2741.
- Vogel VG, et al: Aggiornamento del National Surgical Adjvant Breast and Bowel Project Study of Tamoxifen and Raloxifene (STAR) P-2 Trial: Preventing Breast Cancer. Cancer Prev Res (Phila) 2010 Jun; 3(6): 696-706.
- Goss PE, et al: Exemestane per la prevenzione del cancro al seno nelle donne in postmenopausa. N Engl J Med 2011 Jun 23; 364(25): 2381-2391.
- Cuzick J, et al: Anastrozolo per la prevenzione del cancro al seno nelle donne in postmenopausa ad alto rischio (IBIS-II): uno studio internazionale, in doppio cieco, randomizzato e controllato con placebo. Lancet 2014 Mar 22; 383(9922): 1041-1048.
InFo ONCOLOGIA & EMATOLOGIA 2017; 5(2): 23-26