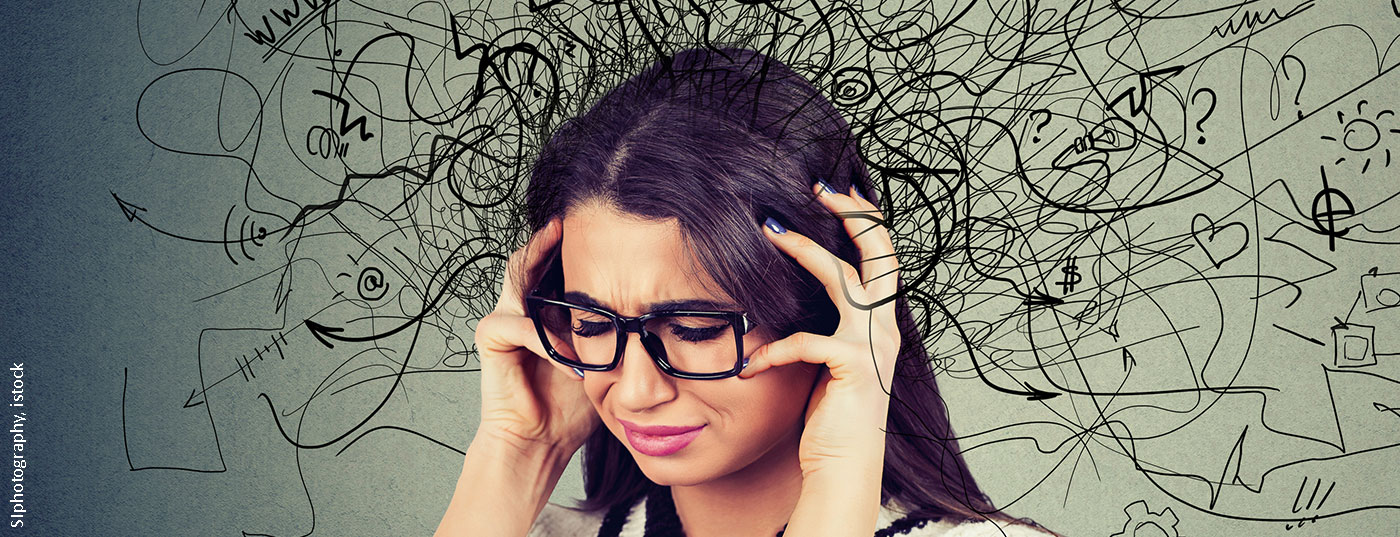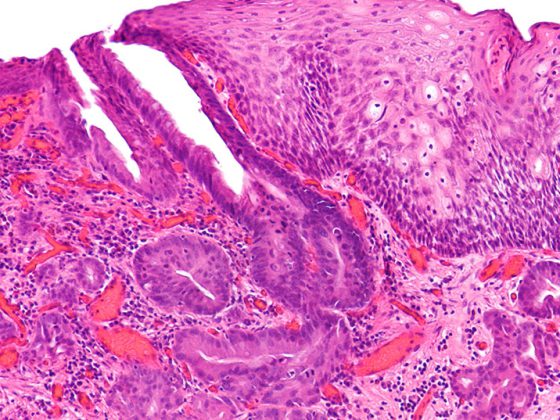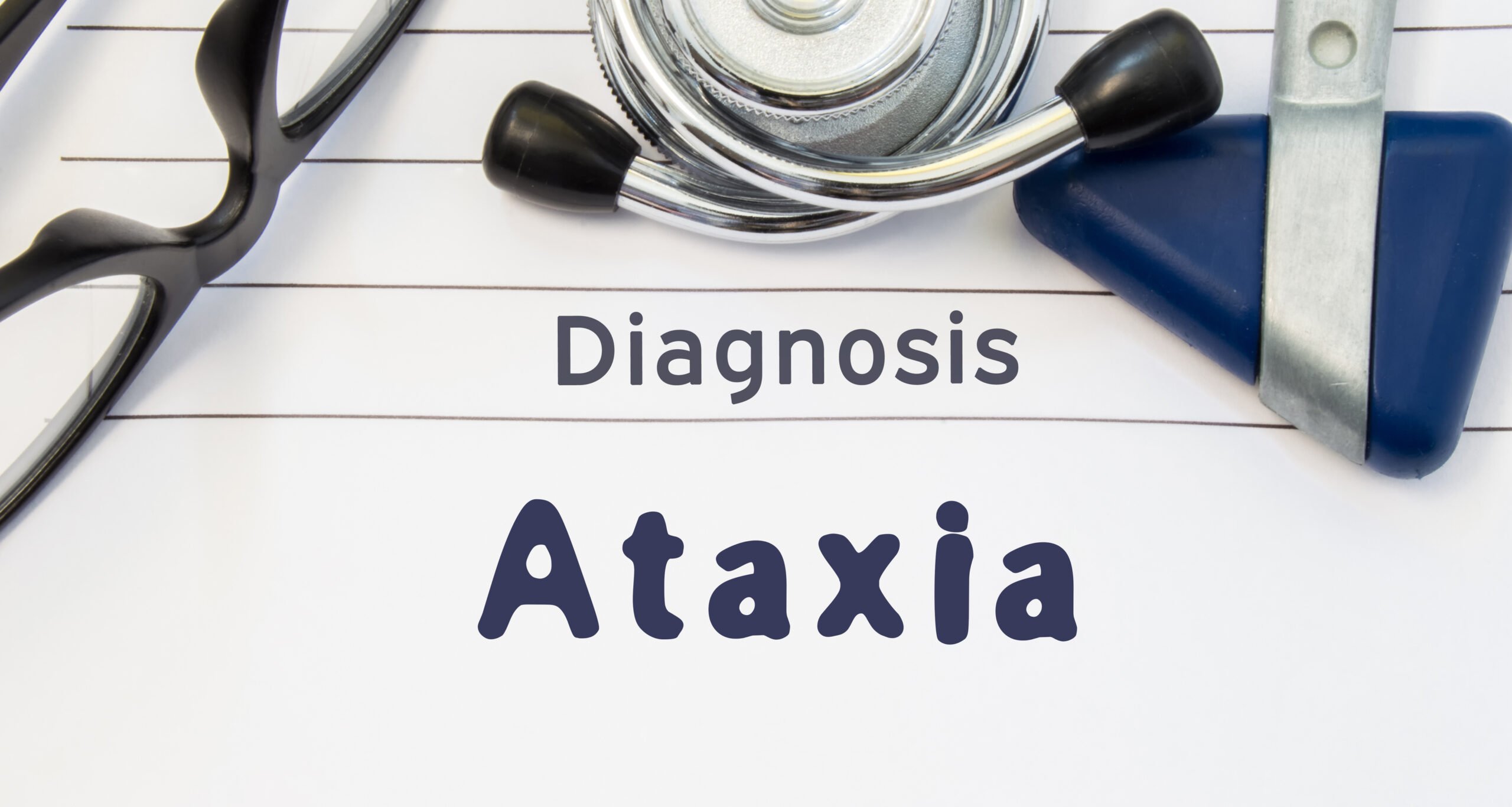L’ADHD può essere trattata bene. Esistono le migliori prove di efficacia per la terapia multimodale. Tuttavia, la diagnosi è spesso complicata da un’ampia variazione dei sintomi. Tra gli altri fattori, anche le fluttuazioni ormonali possono influenzare i sintomi e le strategie di coping.
Molti pazienti si rivolgono al proprio medico di famiglia o allo psichiatra con domande sulla chiarificazione o sulla terapia del disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD). L’ampia variazione dei sintomi rende spesso difficile la diagnosi. Inoltre, le fluttuazioni ormonali e le aspettative interculturali possono influenzare la gravità dei sintomi e il modo in cui i pazienti affrontano la malattia.
I generi differiscono anche per quanto riguarda il decorso della malattia, lo sviluppo di comorbidità e la terapia. Questo articolo intende fornire una panoramica delle caratteristiche speciali. Nell’articolo, per motivi di leggibilità, viene utilizzata solo la forma maschile.
Sintomi ed epidemiologia dell’ADHD
Il disturbo psichiatrico ADHD è uno dei disturbi dello sviluppo neurale. La diagnosi viene fatta quando un certo numero dei tre sintomi principali (iperattività, impulsività e deficit di attenzione), ma anche criteri secondari come le fluttuazioni emotive e le menomazioni nelle funzioni esecutive, possono essere dimostrati in una gravità rilevante per la vita quotidiana. Si ipotizza un modello di disturbo multi-causale con fattori epigenetici, prenatali e psicosociali. L’influenza dei trasportatori posteriori di dopamina molto attivi (soprattutto nella corteccia prefrontale e nel sistema limbico) e la conseguente carenza di dopamina nella fessura sinaptica sono stati ben studiati [1]. I tassi di prevalenza di poco meno del tre percento si riscontrano negli adulti in tutto il mondo, e la diagnosi è quattro volte più comune nei ragazzi [2].
Si presume che l’ADHD tenda a non essere individuata nelle ragazze, dal momento che gli attuali sistemi diagnostici (ICD-10) chiedono i sintomi più evidenti nei ragazzi (come l’iperattività), e che i sintomi si manifestano in modo diverso nelle ragazze o vengono smascherati solo più tardi. Per i bambini e gli adolescenti con ADHD, esistono alcune meta-analisi che hanno esaminato specificamente le differenze di genere [3]. Questi hanno dimostrato in modo coerente che le donne con ADHD avevano meno sintomi primari (iperattività, disattenzione e impulsività) e meno problemi esternalizzanti rispetto ai pazienti maschi. Inoltre, esiste un forte pregiudizio dei rater nella valutazione dell’ADHD nelle ragazze rispetto ai ragazzi. I medici sono più propensi a diagnosticare l’ADHD nei ragazzi, quindi è probabile che questo lasci molte donne affette da questa patologia senza diagnosi [4,5]. Questi fenomeni di differenza di genere vengono discussi anche in termini di possibili diagnosi errate, dato che solo il 6,6% delle ragazze, ma il 21,8% dei ragazzi, riceve una diagnosi falsamente positiva di ADHD a causa di errori nel giudizio diagnostico. Inoltre, le diagnosi falso-positive sono state fatte significativamente più spesso (16,7%) rispetto alle diagnosi falso-negative (7%) [6]. I sottogruppi con sintomi predominanti di disattenzione sono stati creati per la prima volta nel DSM-IV e un’indagine del DSM-IV ha rilevato un rapporto di genere più equilibrato con una prevalenza del 3,2% nelle femmine e del 5,4% nei maschi [7]. Nel caso di un disturbo dello sviluppo intellettivo in comorbilità, il punto di prevalenza aumenta significativamente, con una media del 12% [8]. È interessante notare che la distribuzione dei sessi è più o meno uguale [9]. Anche altre sindromi congenite sono associate con particolare frequenza all’ADHD, ad esempio la trisomia 21 (sindrome di Down, 34-44%). [10]Sindrome dell’X fragile (40-49%) [11]Sindrome di Williams (65%) [12]embriopatia da alcol (FASD, 51%) [13]Sindrome 22q12 (34%) [14] e distrofia muscolare di Duchenne [15]. L’ADHD si manifesta spesso nelle persone autistiche, una su due soddisfa anche i criteri diagnostici del DSM per l’ADHD [16]. Nel corso dello sviluppo, i sintomi possono scomparire completamente o parzialmente; si distingue tra rare remissioni complete, frequenti remissioni parziali e pochissimi decorsi persistenti senza una riduzione dell’espressione dei sintomi. La maggior parte degli adulti soffre di almeno alcuni dei sintomi nel corso della vita, che possono portare a effetti gravi in tutte le aree della vita. Soprattutto negli uomini, la prevalenza dell’ADHD diminuisce gradualmente nel corso della vita. Nelle donne, nei pazienti con comorbidità e nelle persone con un disturbo dello sviluppo intellettivo, i sintomi dell’ADHD persistono più frequentemente e più gravemente [17,18]. Anche le relazioni familiari difficili e le scarse abilità sociali riducono il tasso di remissione [19]. Il miglior predittore di remissione in età adulta sembra essere un QI elevato e un buon ambiente psicosociale [20].
In uno studio, Biederman distingue tra diagnosi attuali e diagnosi in vita. Mentre per quanto riguarda le diagnosi in vita, è stato riscontrato che gli uomini avevano più disturbi da uso di sostanze e disturbi dissociali di personalità, ma le donne avevano più disturbi di panico, è stata riscontrata solo una differenza per le diagnosi attuali. I maschi con ADHD presentano tassi più elevati di disturbi da uso di sostanze rispetto alle femmine con ADHD e, in alcuni casi, più disturbi comportamentali infantili in comorbilità [21].
In età adulta, di solito vengono diagnosticati disturbi o accentuazioni della personalità, abuso di sostanze, disturbi affettivi, disturbi d’ansia, disturbi del sonno e tic. Nell’infanzia, i disturbi del comportamento oppositivo, i disturbi dell’attaccamento, i disturbi da tic, i disturbi d’ansia e i disturbi affettivi sono i più comuni [22]. Nelle ragazze e nelle donne, la diagnosi di ADHD viene spesso fatta dopo l’insorgere di condizioni comorbide.
Uno studio longitudinale su donne affette da ADHD mostra una remissione solo nel 23% delle partecipanti dopo 11 anni. I disturbi della personalità, la depressione, il disturbo bipolare e i disturbi d’ansia hanno continuato ad aumentare durante l’intero periodo. Complessivamente, la maggior parte delle donne ha subito una significativa riduzione dell’istruzione e del lavoro [23]. Le donne con ADHD hanno una probabilità cinque volte maggiore di ricevere una diagnosi di depressione maggiore rispetto alle donne senza ADHD [24]. Ottonen ha dimostrato in un ampio studio che, nel complesso, le condizioni di comorbidità psichiatrica erano più comuni nelle donne con ADHD rispetto agli uomini. In un confronto di genere, è stato dimostrato che alcuni disturbi in comorbilità si verificano meno frequentemente nelle donne (dislessia, delinquenza, comportamento oppositivo) e altri più frequentemente (ansia, disturbi affettivi, disturbi alimentari, abuso di sostanze) [25]. Se questo sia dovuto più a fattori esterni o interni, non è ancora sufficientemente dimostrato. Si discute se la diagnosi e il trattamento precoci nei pazienti di sesso maschile riducano lo sviluppo di disturbi in comorbilità. Un’altra spiegazione potrebbe essere che le donne con forme lievi di ADHD non vengono individuate, mentre i casi gravi, che sono maggiormente correlati alle comorbidità, vengono diagnosticati più spesso nelle donne. Indipendentemente dal sesso, aumenta il rischio di morire prima e anche in modo non naturale; i pazienti con una diagnosi tardiva e quelli con malattie psichiatriche concomitanti sono particolarmente a rischio [26].
La considerazione di esaminare l’ADHD in modo specifico per il genere non è nuova; Nadau ha pubblicato il libro “A comprehensive guide to Attention Deficit Disorder in Adults” (Guida completa al Disturbo da Deficit di Attenzione negli Adulti) come editore nel 1995, che conteneva già un capitolo “Considerazioni speciali sulla sintomatologia nelle donne”, e ha anche sviluppato questionari speciali per le donne [27]. Tuttavia, il work-up diagnostico viene effettuato allo stesso modo per uomini e donne. Johanna Krause sottolinea nel libro “ADHD in età adulta” che quando le madri hanno figli con ADHD, è importante ricordare che anche le madri possono avere l’ADHD [28]. In uno studio controllato in doppio cieco con madri e bambini affetti, lo stile genitoriale delle madri trattate con metilfenidato è migliorato significativamente rispetto al gruppo placebo, erano più coerenti e meno inclini a punire fisicamente [29]. I pazienti apprezzano le raccomandazioni sulla letteratura specifica di genere [27,30,31]. I seguenti sintomi sembrano essere più specifici per le donne:
- La comparsa (o la visibilità) dei sintomi è più tardiva
- Autocolpevolizzazione, bassa autostima
- Aumento della tristezza/ansietà di fondo
- Risoluzione dei conflitti interni (sotto stress “implodere invece di esplodere”)
- Le difficoltà vengono negate; c’è il desiderio di non distinguersi.
- Tendenza a comportamenti orali sotto stress: succhiare il pollice, mangiarsi le unghie, mangiare troppo (a volte con vomito), fumare.
- Rinforzo serio durante la pubertà
- Esperienza di dolore più intensa, ipersensibilità agli stimoli.
- Blocco e ritiro ai requisiti
- Sindrome premestruale pronunciata
- Reazioni violente agli ormoni aggiunti
Diagnostica per le ragazze e le donne
Ci sono differenze nei criteri diagnostici dell’ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) e del DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), dove si trova una suddivisione in sottotipi. Si possono distinguere due sottotipi: Nel tipo combinato, le donne appaiono esteriormente eloquenti, sicure di sé, iper-sociali, molto impegnate e carismatiche, nonostante una vita caotica. Nel tipo disattento (questo è il tipo più comune nelle donne) sembrano piuttosto ritirati e socialmente isolati, appaiono timidi e si scoraggiano rapidamente. Sognare ad occhi aperti porta a procrastinare e a non cogliere le opportunità professionali. Dall’esterno, vengono percepiti come letargici e passivi, nonostante le buone intenzioni. Inoltre, più alto è il quoziente intellettivo, più difficile è riconoscere i sintomi, poiché una buona facciata maschera la causa sottostante e le donne che soffrono di ADHD sono maestre nell’imparare tattiche di evitamento e strategie di coping. In parte, questi pazienti sembrano ossessivi, meticolosi e sono cronicamente esausti, poiché tutta la loro energia è necessaria per affrontare la vita quotidiana. Questi pazienti spesso dichiarano di cercare di conformarsi a un modello di ruolo tradizionale e alle aspettative di ruolo ad esso associate. È noto che i sintomi dell’ADHD che sono considerati più tipici nei ragazzi (forte attività motoria, essere rumorosi, dare fastidio, agire in modo impulsivo) sono percepiti più rapidamente come inappropriati e dirompenti nelle ragazze e vengono strutturati e regolati prima dall’esterno. Questo è un altro motivo per cui spesso sono meno evidenti o si notano solo in seguito.
Nonostante i numerosi studi epigenetici, non è ancora stato trovato un biomarcatore per l’ADHD, quindi la diagnosi rimane puramente clinica [32]. Se si sospetta questa malattia, la diagnosi viene effettuata mediante un’intervista standardizzata con un’anamnesi dettagliata e anche un’anamnesi di altri (nel caso di pazienti minorenni anche con i genitori, se possibile), e un’indagine retrospettiva dei sintomi dall’infanzia in poi (Wender Utah Rating Scale, WURS-K) e l’esame di vecchi documenti (ad esempio, le pagelle) [33]. La Brown ADD Scale e la Conners’ Adult ADHD Rating Scale (CAARS) possono essere utilizzate come questionari [34,35]. Le analisi comportamentali e le prove di trattamento in prova con metilfenidato non sono prescritte, ma possono fornire preziosi indizi diagnostici in casi individuali. È anche possibile che l’uso di caratteristiche EEG (“classificatori diagnostici”) possa supportare il processo diagnostico [36]. I cataloghi dei sintomi creati appositamente per le donne (ad esempio, la ADHD Self-Rating Scale for Women di K. Nadeau e P. Quinn) si sono rivelati utili [27]. Sebbene non servano a stabilire una diagnosi secondo l’ICD o il DSM, possono essere facilmente distribuiti alle donne nell’ufficio del medico di famiglia, per determinare il grado di espressione dei sintomi tipici di . Spesso c’è un auto-riconoscimento sorpreso e l’affermazione “Pensavo che stessero scrivendo di me”.
Ormoni femminili e ADHD
Con l’inizio della pubertà (cambiamento ormonale), i sintomi si intensificano e in parte si modificano, poiché gli ormoni sessuali femminili estrogeni e progesterone interagiscono con i neurotrasmettitori dopamina e serotonina.
Le situazioni di cambiamento ormonale (menarca, ciclo mestruale, gravidanza, menopausa) sono un processo che consuma energia per ogni donna, che può essere accompagnato da una compromissione del benessere psicologico [37]. Le donne con ADHD sembrano mostrare fluttuazioni ormonali più forti o reagiscono in modo più sensibile, violento e problematico a queste fluttuazioni. Gli estrogeni e i progestinici hanno una forte influenza sull’attività neuronale del SNC, modulando la sintesi, il rilascio, il legame con i recettori e la ricaptazione dei neurotrasmettitori. Gli estrogeni hanno generalmente un effetto attivante sul SNC, mentre i progestinici hanno un effetto deprimente. Hanno un effetto positivo sull’umore e sul benessere, presumibilmente potenziando l’attività della serotonina e della dopamina. Di conseguenza, possono portare a cambiamenti nei sintomi dell’ADHD, ma anche negli effetti psicofarmacologici associati ai sistemi noradrenergico e dopaminergico. Le endorfine (che a loro volta sono stimolate dagli estrogeni), ad esempio, inibiscono il rilascio di noradrenalina e dopamina. Pertanto, un calo della concentrazione di estrogeni (premestruale, post-partum, menopausa) può portare a un aumento simile a un rimbalzo della dopamina e della noradrenalina e quindi a un aumento dell’eccitabilità e dell’irritabilità del SNC. La carenza di estrogeni può portare a un’alterazione dei sistemi colinergico, dopaminergico e serotoninergico e alla perdita di connessioni sinaptiche indipendentemente dall’ADHD. Questo può comportare una perdita di prestazioni cognitive. L’influenza degli estrogeni sul sistema dopaminergico si verifica principalmente nell’area dell’ipotalamo. Ci sono recettori di estrogeni nel sistema limbico che hanno una “funzione neuromodulatrice”. Modulano la sensibilità e il numero dei recettori della dopamina. Questo dimostra una stretta relazione con l’ipotesi della neuroprotezione, che è nota anche per altre malattie mentali. L’influenza ormonale si manifesta nelle diverse situazioni come segue [37]:
Menarca e ciclo:
- Un numero superiore alla media di ragazze e donne con ADHD presenta una sindrome premestruale grave e prolungata.
- Spesso si verificano forti cambiamenti ciclici nell’umore e nel benessere.
- C’è un rischio superiore alla media di attività sessuale precoce e di gravidanza precoce, oltre che di malattie sessualmente trasmissibili (STD).
- Inoltre, aumenta il rischio di cambiare, di avere relazioni insoddisfacenti e brevi o di subire violenza sessuale.
Pubertà e adolescenza: la maturazione prefrontale gioca un ruolo decisivo nella pubertà, ma anche nei sintomi dell’ADHD. Si verificano fluttuazioni e problemi ormonali
- in un’azione pianificata e lungimirante,
- nel riconoscere le conseguenze di una maggiore assunzione di rischi,
- nella percezione dei propri sentimenti e dei sentimenti degli altri,
- nel percepire le ricompense (cioè le ragazze adolescenti dovrebbero fare cose più pericolose per provare lo stesso brivido) con meno opportunità di rinvio della ricompensa.
Gravidanza, maternità:
- Spesso si verifica una riduzione dei sintomi dell’ADHD grazie all’aumento del livello di estrogeni o all’assenza di fluttuazioni ormonali cicliche.
- I cambiamenti ormonali post-partum e i gravi cambiamenti dovuti alla convivenza con un bambino con un aumento dei sintomi dell’ADHD.
- Inoltre: l’ADHD è solitamente ereditaria; un figlio che ha anche l’ADHD è un’altra sfida per la madre.
Menopausa: l’inizio della menopausa e la fine della fertilità.
- La diminuzione della produzione naturale di estrogeni aumenta i sintomi dell’ADHD, che spesso vengono inizialmente scambiati per sintomi della menopausa.
- Influenza negativa sulle funzioni cognitive.
Terapia per ragazze e donne
L’ADHD di solito può essere trattata bene con un approccio multimodale (farmaci, psicoeducazione, psicoterapia, ecc.). Nella linea guida S3, il trattamento dell’ADHD è differenziato in base alla gravità. In caso di gravità lieve, si dovrebbe offrire un trattamento principalmente psicosociale; in caso di gravità moderata, si dovrebbe offrire un intervento psicosociale e/o farmacologico intensificato dopo la psicoeducazione, a seconda delle condizioni di vita concrete; in caso di forma grave, la farmacoterapia è in primo piano [38,39]. Gli effetti dei vari farmaci per l’ADHD sono stati ben studiati sia nelle donne che negli uomini, nei bambini e negli adulti, e mostrano dimensioni di effetto elevate e buoni tassi di risposta.
Una revisione ha incluso 133 studi con un totale di 14.346 bambini e adolescenti e 10.296 adulti e ha esaminato l’efficacia e la sicurezza del trattamento di 12 settimane con anfetamine, atomoxetina, bupropione, clonidina, guanfacina, metilfenidato e modafinil l’uno contro l’altro o contro il placebo. Gli autori considerano il metilfenidato nei bambini e negli adolescenti e le anfetamine negli adulti come la terapia di scelta nel trattamento di prima linea dell’ADHD. Inoltre, i risultati dell’analisi di rete dimostrano che un attento monitoraggio del peso corporeo e delle variazioni della pressione sanguigna è importante con tutti i farmaci per il trattamento dell’ADHD [40].
Poiché nell’ADHD possono verificarsi forti fluttuazioni dipendenti dal ciclo e la sindrome premestruale, i pazienti devono essere informati su questo fenomeno e sulla possibilità di una terapia ormonale. Naturalmente, anche le donne senza ADHD possono beneficiare del supporto ormonale. In tutte le pazienti, sempre sotto la valutazione del rischio che include la somministrazione ormonale (ad esempio, per quanto riguarda l’aumento del rischio tromboembolico). Occorre prestare particolare attenzione alle possibili interazioni quando si combinano diversi farmaci (ad esempio, stimolanti ed estrogeni). Si consigliano preparazioni a lunga durata d’azione che mantengono i livelli ormonali il più possibile costanti. Gli ormoni assunti per via orale (“pillole anticoncezionali”) per la contraccezione possono essere assunti in modo continuativo dopo aver consultato il ginecologo, oppure si possono scegliere altri tipi di sostituzione, come gli anelli ormonali, le iniezioni depot o gli impianti ormonali. Da un lato, questo minimizza gli sbalzi d’umore e, dall’altro, le difficoltà cognitive rendono difficile per molti pazienti ricordarsi di prendere le compresse ogni giorno.
In generale, non ci sono quasi controindicazioni che impediscano di combinare i farmaci per l’ADHD e i preparati ormonali; per entrambi i preparati si raccomanda un controllo regolare dei parametri vitali e dei valori di laboratorio. In caso di riadattamento dei farmaci, occorre prestare particolare attenzione ai cambiamenti di umore. Nella maggior parte dei casi, si verifica una chiara stabilizzazione dell’umore; raramente, in singoli casi, si deve prendere in considerazione un preparato alternativo in caso di crollo dell’umore, anche se è più probabile che questo sia attribuito ai progestinici nei preparati combinati. I medici riferiscono che le donne con ADHD hanno maggiori probabilità di avere la forma più grave di disturbo disforico premestruale (PMDS), che comporta umore depresso, disperazione, labilità degli affetti, rabbia persistente, sensazione di essere sopraffatti, stanchezza e ansia. Durante queste fasi, le donne colpite trovano particolarmente difficile compensare i sintomi. È stato descritto che l’assunzione di preparati estrogenici può anche alleviare la sofferenza qui [30].
Se è incinta o sta allattando, è sconsigliata l’assunzione di farmaci ADHD per evitare di danneggiare l’embrione. Qui, la situazione dello studio è scarsa. In uno studio su 3082 madri, sono state identificate in totale undici donne che avevano assunto metilfenidato. Non sono state osservate anomalie in nessuno dei loro figli. Solo l’abuso di stimolanti (ad esempio, l’uso di metilfenidato per via endovenosa) ha dimostrato di rappresentare un rischio di malformazioni fetali. Un altro studio mostra un aumento del tasso di aborto spontaneo e, in parte, un abbassamento dell’indice Apgar postnatale [41,42].
Tuttavia, nonostante le numerose opzioni contraccettive, la gravidanza può verificarsi inosservata, soprattutto nei pazienti con ADHD, mentre il paziente sta ancora assumendo stimolanti. In questo caso, è necessario richiedere la consulenza di uno specialista, soprattutto se la terapia farmacologica deve essere continuata nei singoli casi.
Sommario
L’ADHD si manifesta quasi con la stessa frequenza nelle donne e negli uomini. Tuttavia, i sintomi possono presentarsi in modo diverso o diventare evidenti solo durante la pubertà. Inoltre, ci sono differenze nello sviluppo di malattie comorbide, per cui le donne a volte vengono diagnosticate meno frequentemente o solo più tardi. La diagnosi viene effettuata clinicamente secondo l’ICD o il DSM; i questionari aggiuntivi per le donne facilitano una diagnosi sensibile al genere. Gli ormoni sessuali femminili hanno un’influenza decisiva sui sintomi; in particolare, le fluttuazioni dei livelli ormonali e una maggiore reazione psicologica ad essi sembrano giocare un ruolo. È importante informare i pazienti e il loro ambiente al riguardo. Se si desidera una sostituzione ormonale, sia per la contraccezione, sia per la menopausa o per la stabilizzazione dell’umore, si devono prendere in considerazione i preparati che portano a livelli ormonali costanti (preparati a lungo termine) e si devono evitare le interruzioni dei farmaci con la “pillola anticoncezionale”. Durante la gravidanza, i sintomi dell’ADHD spesso si attenuano, per cui di solito si può fare a meno dei farmaci. È stata dimostrata un’influenza positiva degli ormoni (naturalmente presenti o sostituiti) sui sintomi dell’ADHD, ma anche sull’effetto dei farmaci per l’ADHD. È auspicabile un’educazione sessuale precoce, anche per quanto riguarda le malattie sessualmente trasmissibili (MST), la contraccezione e i centri di consulenza appropriati. Come medico, dovrebbe pensare a una valutazione e a una terapia per l’ADHD, soprattutto per le donne che cercano di presentarsi come ben adattate e “normali”, ma che lottano con un’ampia varietà di difficoltà nella vita, riferiscono reazioni eccessive alle fluttuazioni ormonali o hanno figli con un disturbo ADHD.
Messaggi da portare a casa
- Le donne ricevono una diagnosi meno frequente e più tardiva per quanto riguarda l’ADHD, e spesso si rivolgono al medico con problemi derivanti da una condizione di comorbilità.
- Anche le madri con figli affetti da ADHD dovrebbero essere prese in considerazione per un chiarimento, a causa dell’elevata componente genetica.
- A causa dei comportamenti sessuali a rischio, le gravidanze precoci e indesiderate e le malattie sessualmente trasmissibili sono più frequenti.
- Oltre alla sua effettiva indicazione (contraccezione, carenza ormonale), la terapia ormonale può anche portare a un miglioramento significativo dei sintomi dell’ADHD, poiché questi sono spesso intensificati dalle fluttuazioni ormonali.
- L’ADHD può essere trattata bene, la terapia dovrebbe essere multimodale, se possibile.
Letteratura:
- Thapar A, Cooper M: Disturbo da deficit di attenzione. Lancet 2016; 387: 1240-1250.
- Fayyad J, Sampson NA, Hwang I, et al: L’epidemiologia descrittiva dell’ADHD per adulti DSM -IV nelle indagini sulla salute mentale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Atten Defic Hyperact Disord 2017; 9: 47-56.
- Gaub M, Carlson CL: Differenze di genere nell’ADHD: una meta-analisi e una revisione critica. J Am Acad Child Adolescatry. 1997; 36: 1036-1045.
- Gershon J: Una revisione meta-analitica delle differenze di genere nell’ADHD. J Attent Disord. 2002; 5: 143-154
- Kessler RC, Adler L, Barkley R e altri. La prevalenza e le correlazioni dell’ADHD negli adulti negli Stati Uniti: risultati della National Comorbidity Survey Replication. A, J Psychiatry 2006; 163: 716-723.
- Bruchmüller K1, Margraf J, et al: L’ADHD è diagnosticato in conformità ai criteri diagnostici? Sovradiagnosi e influenza del sesso del cliente sulla diagnosi. J Consult Clin Psychol. 2012 Feb; 80(1): 128-138.
- Polanczyk G, de Lima MS, Horta BL, et al:. La prevalenza mondiale dell’ADHD: una revisione sistematica e un’analisi di metaregressione. Am J Psychiatry 2007; 164: 942-948.
- Faraone SV, Ghirardi L, Kuja-Halkola R, et al: La co-aggregazione familiare del Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività e della Disabilità Intellettiva: uno studio familiare basato su un registro. J Am Acad Child Adolescatry 2017; 56: 167-174.e1
- Pearson DA, Yaffee LS, Loveland KA, Lewis KR: Confronto dell’attenzione sostenuta e selettiva nei bambini con ritardo mentale con e senza disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Am J Ment Retard 1996; 100: 592-607.
- Naerland T, Bakke KA, et al: Differenze legate all’età e al sesso nei problemi emotivi e comportamentali e nelle caratteristiche autistiche nei bambini e negli adolescenti con sindrome di Down: uno studio basato su un’indagine su 674 individui. J Intellect Disabil Res 2017; 61(6): 594-603.
- Young S, Absoud M, Blackburn C, et al: Linee guida per l’identificazione e il trattamento dei soggetti con disturbo da deficit di attenzione/iperattività e disturbi dello spettro fetale alcolico associati, basate sul consenso degli esperti. BMC Psychiatry 2016; 16: 324.
- Leyfer OT, Woodruff-Borden J, Klein-Tasman BP, et al: Prevalenza di disturbi psichiatrici in bambini dai 4 ai 16 anni con la sindrome di Williams. Am J Med Genet B Neuropsychatr Genet 2006; 141B(6): 615-622.
- Landgren M, Svensson L, et al.: Esposizione prenatale all’alcol e disturbi del neurosviluppo nei bambini adottati dall’Europa orientale. Pediatria 2010; 125: 1178-1185.
- Niklasson L, Rasmussen P, Oskarsdottir S, Gillberg C: Autismo, ADHD, ritardo mentale e problemi comportamentali in 100 individui con sindrome da delezione 22q11. Res Dev Disabil 2009; 30(4): 763-773.
- Pane M, Lombardo ME, Alfieri P, et al: Disturbo da deficit di attenzione e iperattività e funzione cognitiva nella distrofia muscolare di Duchenne: correlazione fenotipo-genotipo. J Pediatr 2012; 161: 705-709.
- Sinzig J, Walter D, Doepfner M: Disturbo da deficit di attenzione/iperattività nei bambini e negli adolescenti con disturbo dello spettro autistico: sintomo o sindrome? J Atten Disord 2009; 13: 117-126
- Xenitidis K, Paliokosta E, Rose E, et al: Presentazione dei sintomi dell’ADHD e traiettoria negli adulti con disabilità intellettiva lieve e borderline. J Intellect Disabil Res 2010; 54: 668-677.
- Neece CL, Baker BL, et al: Disturbo da deficit di attenzione/iperattività nei bambini con e senza disabilità intellettiva: un esame nel tempo. J Intellect Disabil Res 2011; 55: 623-635.
- Pearson DA, Lachar D, et al: Modelli di adattamento e disadattamento comportamentale nel ritardo mentale: confronto tra bambini con e senza ADHD. Am J Ment Retard 2000; 105: 236-251
- Lambert NM, Hartsought CS, Sassone D, Sandoval J: Persistenza dei sintomi di iperattività dall’infanzia all’adolescenza ed esiti associati. Am J Orthopsychiatry 1987; 57: 22-32.
- Biederman J, Faraone SV, Monuteaux MC, et al: Effetti di genere sul disturbo da deficit di attenzione/iperattività negli adulti, rivisto. Biol Psychiatry. 2004; 55: 692-700.
- Jensen CM, et al: Disturbi mentali in comorbilità nei bambini e negli adolescenti con disturbo da deficit di attenzione/iperattività in un ampio studio nazionale. Atten Defic Hyperact Disord 2015; 7: 27-38.
- Biederman J, Petty CR, et al: Esiti psichiatrici adulti di ragazze con disturbo da deficit di attenzione e iperattività: follow-up di 11 anni in uno studio longitudinale caso-controllo. Am J Psychiat 2010c; 167: 409-417.
- Quin PO: Disturbo da deficit di attenzione/iperattività e le sue comorbidità nelle donne e nelle ragazze: un quadro in evoluzione. Curt Psychiatry Rep 2008; 10: 419-423.
- Ottonen, et al: Differenze di sesso nei modelli di comorbilità del Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività. J Child and Idol Psych 2018; Vol 58, Issue 4, 412-422.
- Sun S, Kuja-Halkola R, Faraone SV, et al: Associazione della comorbilità psichiatrica con il rischio di morte prematura tra i bambini e gli adulti con disturbo da deficit di attenzione/iperattività. JAMA Psychiatry. Pubblicato online il 07 agosto 2019. doi:10.1001/jamapsychiatry.2019.1944.
- Nadau K: Sono diverso? Ragazze e donne con ADHD. Juvemus-Selbstverlag, Koblenz 2001.
- Krause J, Krause KH: ADHD in età adulta. Schattauer-Verlag, Stoccarda-New York 2005, 113.
- Chronis-Tuscano A, Seymour KE, et al: Efficacia del sistema orale a rilascio osmotico (OROS) di metilfenidato per le madri con disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD): rapporto preliminare degli effetti sui sintomi dell’ADHD e sulla genitorialità. J Clin Psychiatry 2008; 69: 1938-1947.
- Solden S: “La Principessa del Caos”, Monaco, Forchheim: BH-AH 1999
- Ryffel-Rawak D: ADHD nelle donne – in balia dei sentimenti. Huber, Berna 2004, ISBN 3-456-84121-3.
- Walton E, Pingault JB, Cecil CA, et al: Profilazione epigenetica delle traiettorie dei sintomi dell’ADHD: uno studio prospettico su tutto il metiloma. Mol Psychiatry 2017; 22: 250-256.
- WURS, Ward MF, Wender PH, Reimherr FW: La scala di valutazione Wender Utah: un aiuto nella diagnosi retrospettiva del disturbo da deficit di attenzione infantile. Am J Psychiatry 1993; 150: 885-890.
- Brown TE. Brown Attention – Deficit Disorder Scales for Children and Adolescents (BrownADDScales). San Antonio, TX: Psychological Corp 2001.
- Christiansen H, Kis B, et al.: Convalida tedesca della Conners Adult ADHD Rating Scales (CAARS) 2: affidabilità, validità, sensibilità e specificità diagnostica. Eur Psychiatry 2011; 27: 321-328.
- Helgadóttir H, Gudmundsson ÓÓ, Baldursson G, et al: L’elettroencefalogramma come strumento clinico per la diagnosi e il monitoraggio del disturbo da deficit di attenzione e iperattività: uno studio trasversale. BMJ Open 2015; 5: e005500
- Ormoni sessuali e psiche: fondamenti, sintomatologia, malattie, terapia, Herbert Kuhl, Georg Thieme Verlag 2002.
- Banaschewski T (coordinatore della linea guida), Hohmann S, Millenet S, et al: Versione lunga della linea guida interdisciplinare basata sull’evidenza e sul consenso (S3) “Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) nell’infanzia, nell’adolescenza e nell’età adulta” 2018; numero di registro AWMF 028-045. www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/028-045l_S3_ADHS_2018-06.pdf Cortese S, Adamo
- N Del Giovane C, et al: Efficacia comparativa e tollerabilità dei farmaci per il disturbo da deficit di attenzione e iperattività nei bambini, negli adolescenti e negli adulti: una revisione sistematica e una meta-analisi di rete. Lancet Psychiatry 2018.
- Arnett A, Stein M: Affinare le scelte terapeutiche per l’ADHD. Lancet Psychiatry 2018; 30295-30299.
- Centro di farmacovigilanza e consulenza per la tossicologia embrionale. Metilfenidato. www.embryotox.de/methylphenidat.html (visitato il 14 ottobre 2019)
- Bro SP, Kjaersgaard MI, Parner ET e altri. Esiti avversi della gravidanza dopo l’esposizione a metilfenidato o atomoxetina durante la gravidanza. Epidemiologia clinica 2015; 7: 139-147.
HAUSARZT PRAXIS 2019; 14(12): xx-xx