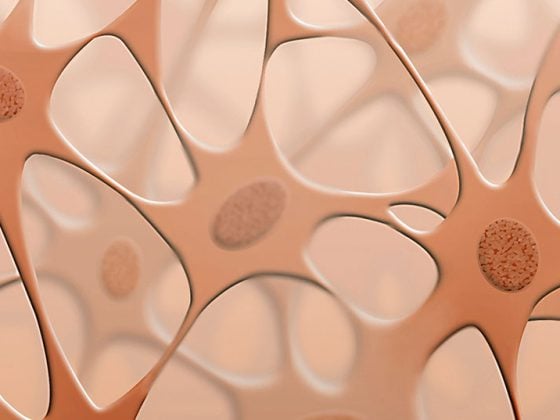Gli emangiomi infantili sono i tumori benigni più comuni nei bambini. Sono congenite o si sviluppano nelle prime settimane di vita. In caso di manifestazioni complicate e di minaccia di complicazioni funzionali, ulcerazione o minaccia di danni estetici permanenti, è indicato il trattamento.
Secondo la linea guida SK2, l’emangioma infantile è definito come un tumore vascolare proliferante simile al tessuto placentare nella sua struttura antigenica, per il quale l’ipossia tissutale locale o regionale è discussa come possibile fattore patogenetico [1]. Si trovano nell’1,1-2,6% di tutti i neonati maturi; nel primo anno di vita, la prevalenza è del 10-12% [2]. Ci sono lesioni precursori come teleangectasie circoscritte, macule anemiche, rossastre o bluastre o cambiamenti simili al nevo flammeo. Tuttavia, un classico emangioma infantile non appare mai come un tumore alla nascita [1]. Il rischio di sviluppare un emangioma aumenta con la diminuzione del peso alla nascita. Per ogni 500 g in meno di peso alla nascita, il rischio aumenta del 40% [3]. Per ragioni sconosciute, le ragazze sono colpite da tre a cinque volte più spesso dei ragazzi.
L’emangioma non sempre regredisce completamente.
L’emangioma infantile attraversa successivamente tre fasi:
- una crescita
- un arresto e
- una fase di regressione.
Nella fase di crescita, che di solito dura 6-9 mesi, prolifera a ritmi diversi con diffusione superficiale e soprattutto con crescita esofitica o endofitica-sottocutanea, spesso anche in combinazione. Successivamente, si raggiunge una fase di plateau, che può durare da settimane a mesi. La fase di regressione procede a ritmi diversi a seconda delle dimensioni e della localizzazione e di solito si completa intorno ai 9 anni [1].
Con i piccoli emangiomi cutanei, di solito non rimane nulla. Gli emangiomi più grandi sono spesso associati a teleangectasie, aree di pelle atrofica, cicatrici, cutis laxa, iper- o ipopigmentazione o una proliferazione fibro-lipomatosa del tessuto simile a una giogaia [1]. In loro, circa il 10% del volume dell’emangioma regredisce ogni anno a partire dal secondo anno di vita, per cui circa il 50% del volume del tumore rimane ancora all’età di cinque anni e circa il 10% all’età di nove anni.
La diagnosi differenziale supporta la considerazione della terapia
La diagnosi di solito può essere fatta anamnesticamente e clinicamente. Richiede di chiarire due questioni principali:
- C’è un emangioma infantile, un altro tumore vascolare o una malformazione vascolare?
- Se c’è un emangioma infantile: In quale fase si trova?
Gli emangiomi infantili devono essere distinti da un lato da altri tumori vascolari, ad esempio l’emangioendotelioma caposiforme (KHE) o il granulomapyogenicum, e dall’altro da malformazioni arteriose, venose, linfatiche o combinate del sistema vascolare [1]. Se la diagnosi non è chiara, può essere utile un esame ecografico con ecografia duplex e una biopsia per la determinazione di GLUT1.
Se sia indicato un approccio terapeutico attivo può essere deciso solo su base individuale. Negli emangiomi infantili non complicati con localizzazione non problematica e senza compromissione funzionale, non è necessaria alcuna terapia. Il trattamento farmacologico, invece, deve essere iniziato con urgenza nel caso di:
- complicazione funzionale pericolosa per la vita o minacciosa con localizzazione ed estensione appropriate (ad esempio, emangiomi periorifiziali o laringei).
- minacciata o già manifestata ulcerazione, soprattutto a causa della dolorosità.
- Minaccia di danni estetici permanenti anche dopo la guarigione dell’emangioma, ad esempio emangiomi di grandi dimensioni nella zona del viso.
Evitare i danni conseguenti
La terapia di prima scelta è solitamente una terapia di sistema con propranololo. Il meccanismo d’azione è spiegato dall’influenza sulle cellule endoteliali, sul tono vascolare, sull’angiogenesi e sull’apoptosi [4]. Grandi meta-analisi e studi randomizzati controllati hanno dimostrato un tasso di risposta del 98% [1]. Il propranololo viene somministrato in una dose di 2-3 mg/kg di peso corporeo. Idealmente, la terapia dovrebbe essere iniziata tra la quarta e la decima settimana di vita, poiché questo è il momento in cui la crescita dell’emangioma è più rapida. I danni irreversibili come l’atrofia cutanea, le cicatrici e l’eccesso di tessuto connettivo possono essere evitati nel miglior modo possibile. La terapia deve essere continuata fino al compimento del primo anno di età, per ridurre al minimo il rischio di una ricaduta dopo l’interruzione della terapia.
La prima dose viene somministrata sotto il monitoraggio della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca in un ambiente ambulatoriale o ospedaliero. Il principio attivo è solitamente ben tollerato. I possibili effetti indesiderati di solito scompaiono nel corso della terapia. Le controindicazioni alla terapia sistemica con propranololo includono bradicardia, ipotensione, blocco AV >di 2° grado, insufficienza cardiaca, ostruzione polmonare, tendenza all’ipoglicemia e feocromocitoma.
Letteratura:
- %C3%(ultima chiamata il 16.02.20)
- Bruckner AL, Frieden IJ: Emangiomi dell’infanzia. J Am Acad Dermatol 2003; 48(4): 477-493.
- Drolet BA, et al: Emangiomi infantili: un problema di salute emergente legato a un aumento del tasso di neonati con basso peso alla nascita. J Pediatr 2008; 153(5): 712-715.
- Rotter A, de Oliveira ZNP: Emangioma infantile: patogenesi e meccanismi d’azione del propranololo. J Dtsch Dermatol Ges 2017; 15(12): 1185-1190.
InFo ONcOLOGIA & EMATOLOGIA 2020; 8(1): 25
PRATICA DERMATOLOGICA 2020; 30(1): 28