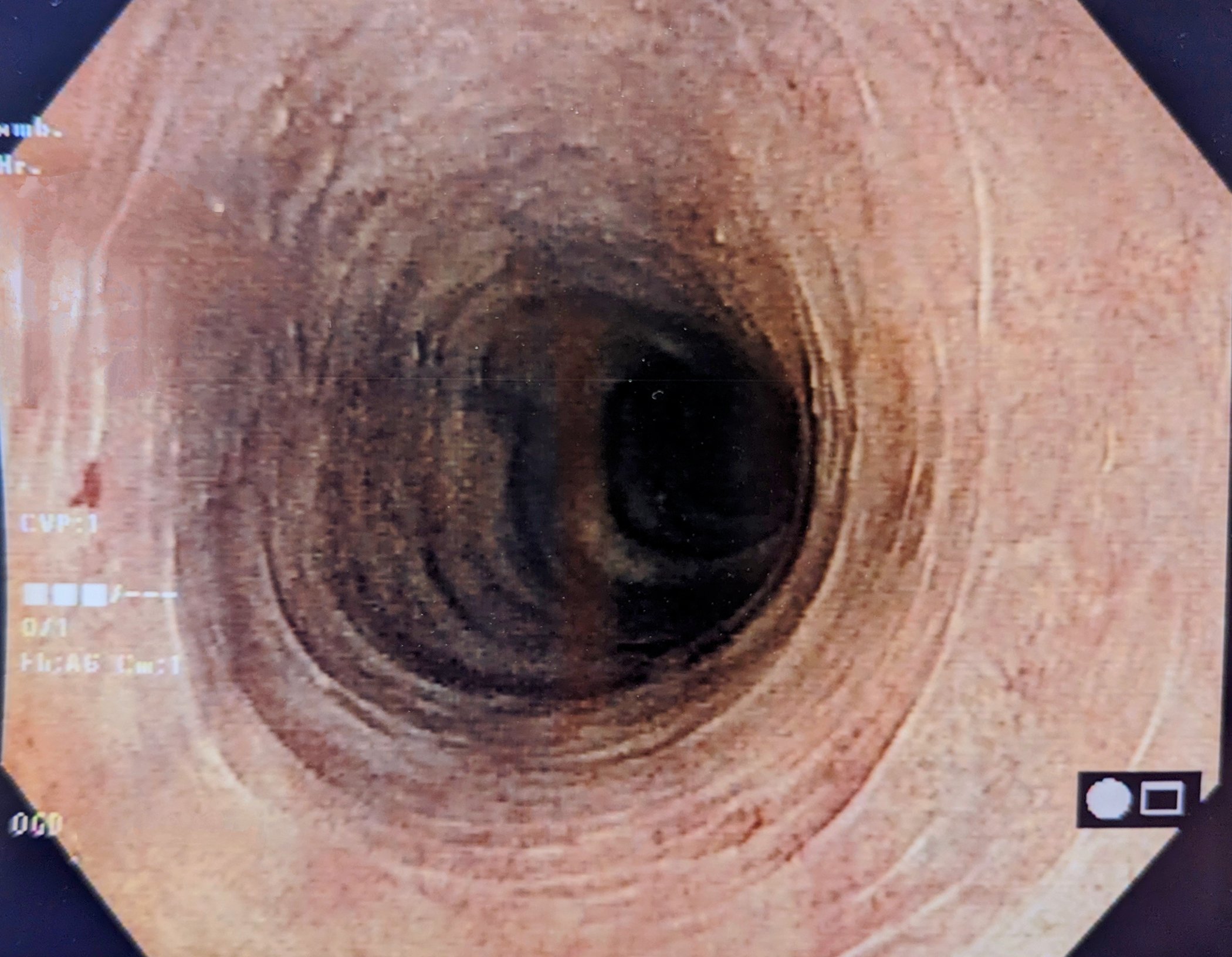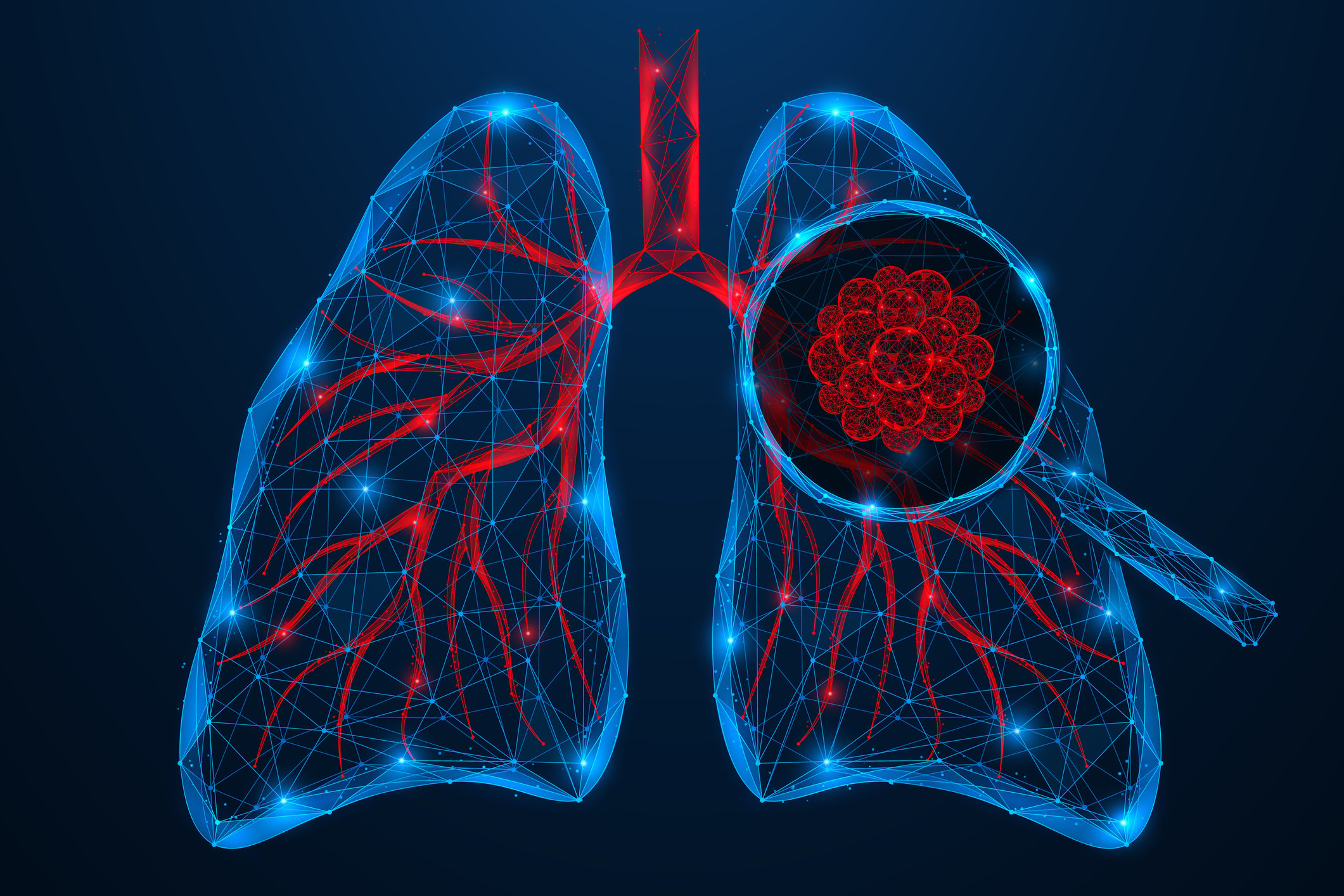Mani tremanti, muscoli rigidi, andatura instabile: sono i segni tipici della malattia di Parkinson. Finora trattabile solo in modo sintomatico, è in corso una ricerca intensiva su un approccio terapeutico individuale. Una cosa è chiara: più la fisiopatologia della malattia può essere affrontata individualmente, più promettente è il risultato. Ma ancora oggi, esiste un’ampia gamma di opzioni terapeutiche che possono almeno essere adattate ai sintomi.
Insieme alla demenza di Alzheimer e all’ictus, la malattia di Parkinson è una delle patologie più comuni del sistema nervoso in età avanzata. In Svizzera, sono più di 15.000 le persone colpite – e il numero è in aumento. Al momento della diagnosi, la maggior parte delle persone colpite ha più di 60 anni [1]. I sintomi principali sono l’ipocinesia, il rigore, il tremore e l’alterazione della stabilità posturale [1,2]. Tuttavia, la malattia si manifesta in modo molto diverso da persona a persona. Questo perché esiste una disfunzione sottostante multi-sistema e multi-neurotrasmettitore che caratterizza l’eterogeneità del fenotipo. Fondamentalmente, però, la sindrome di Parkinson può essere suddivisa in tre fasi: la fase iniziale, che di solito non comporta alcuna restrizione, la fase intermedia, in cui si manifestano i primi sintomi, e la fase tardiva. Oltre ai disturbi non motori, questo è principalmente associato a significative alterazioni motorie, come fluttuazioni, congelamento, ipercinesi e acinesia.
Dal sintomo alla causa
Oltre alle terapie di esercizio, sono disponibili interventi farmacologici per alleviare i sintomi. In primo luogo, vengono utilizzati la dopamina, gli agonisti della dopamina o gli inibitori delle MAO. Tuttavia, l’uso degli inibitori della COMT è possibile anche per le fluttuazioni motorie o le discinesie. Nella fase avanzata della malattia, potrebbe essere necessario ricorrere alla stimolazione cerebrale profonda o alle pompe di apomorfina o duodopa. Ora si pone la domanda in che misura un trattamento personalizzato sia già possibile in questo spettro terapeutico. Il Prof. Dr. med. Karla Maria Eggert, Marburg (D), ha dimostrato che in caso di manifestazioni lievi, la terapia iniziale dovrebbe essere con un inibitore MAO. Questo riduce la deplezione di dopamina striatale, ma spesso è efficace solo in misura limitata a causa del dosaggio fisso. Gli agonisti della dopamina sono utilizzati principalmente nei pazienti con un’età di insorgenza inferiore <70 anni e/o senza comorbilità rilevanti. Hanno una lunga emivita e vengono resi disponibili al cervello in modo uniforme e dipendente dalla dose. La levodopa ha un’emivita breve e non viene consegnata al cervello in modo uniforme, ma in modo pulsatile e dipendente dalla dose. Pertanto, viene somministrato principalmente ai pazienti anziani e a quelli con comorbilità rilevanti. Le complicazioni motorie, come le fluttuazioni, possono essere trattate con gli inibitori della COMT o con gli inibitori delle MAO, mentre per la discinesia si utilizzano sostanze antiglutamatergiche.
In futuro, tuttavia, la medicina personalizzata dovrà tenere molto più conto dei fattori patologici genetici, epigenetici e molecolari, afferma l’esperto. A tal fine, le entità patologiche non sono più definite solo a livello sindromico, ma anche a livello molecolare e patologico. Questo perché la variabilità genetica influenza l’efficacia e il profilo degli effetti collaterali dei farmaci. Su questa base, si possono sviluppare approcci di terapia causale.
Congresso: Congresso tedesco sulla malattia di Parkinson e i disturbi del movimento
Letteratura:
- www.parkinson.ch/parkinsonkrankheit/was-ist-parkinson (ultimo accesso 21.05.2021)
- www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/neurologie/erkrankungen/parkinson-syndrom/was-ist-das-parkinson-syndrom (ultimo accesso 21.05.2021)
InFo NEUROLOGY & PSYCHIATRY 2021; 19(3): 31 (pubblicato il 3.6.21, in anticipo sulla stampa).