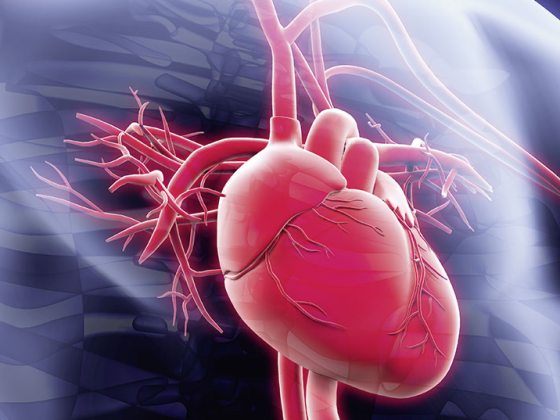Dal 1977, gli esperti internazionali si riuniscono ogni anno per scambiare le ultime informazioni sulla ricerca sul cancro al seno. L’obiettivo è quello di bilanciare la ricerca clinica, traslazionale e di base e di fornire un forum per l’interazione, la comunicazione e l’educazione di un’ampia gamma di ricercatori, operatori sanitari e persone con un interesse speciale per il cancro al seno. L’attenzione si concentra attualmente sugli approcci per un regime terapeutico mirato.
I risultati dello studio clinico prospettico di fase II ACOSOG Z11102 mostrano che nelle pazienti con tumori multipli nella stessa mammella, sottoposte a lumpectomia seguita da radioterapia, il tasso di recidiva locale è paragonabile a quello precedentemente osservato nelle pazienti con un singolo tumore [1]. Lo studio ha incluso donne di età superiore ai 40 anni che avevano due o tre siti di cancro al seno nello stesso seno, separati da tessuto mammario normale. Tutte le pazienti sono state sottoposte a mammografia e/o ecografia, e la maggior parte di esse è stata sottoposta anche a risonanza magnetica del seno. Quattordici delle pazienti partecipanti sono state sottoposte a mastectomia perché i margini rimanevano positivi e la terapia conservativa del seno non era possibile. Le altre pazienti sono state trattate con lumpectomia seguita da irradiazione del seno intero con boost di radiazioni in tutti i siti della lumpectomia. L’endpoint primario era la recidiva locale cinque anni dopo il completamento della radioterapia.
Dei 204 pazienti valutabili, sei hanno sviluppato una recidiva locale dopo un follow-up mediano di 66,4 mesi, corrispondente a un tasso di recidiva locale a cinque anni del 3,1%. Questo tasso è simile ai tassi di recidiva locale osservati in studi precedenti su pazienti con un singolo tumore al seno dopo la terapia conservativa del seno. Il tasso di recidiva locale è stato più alto nelle 15 pazienti che non si sono sottoposte alla risonanza magnetica al seno prima dell’intervento, rispetto alle 189 pazienti che l’hanno effettuata (22,6% contro 1,7%). È stato discusso che questo potrebbe essere dovuto al fatto che le pazienti che si sono sottoposte a risonanza magnetica al seno hanno individuato un maggior numero di focolai di malattia prima dell’intervento chirurgico, il che ha permesso una resezione più approfondita. Il rischio di recidiva locale non era correlato all’età della paziente, al numero di lesioni mammarie, alla biologia del tumore o alla stadiazione patologica. Nessuna delle pazienti ha avuto una recidiva regionale, ma quattro hanno avuto una recidiva a distanza, sei hanno avuto un cancro al seno nell’altra mammella e tre hanno avuto nuovi tumori primari al di fuori del seno.
L’interruzione della terapia endocrina in caso di desiderio di avere figli
Quali sono gli effetti dell’interruzione della terapia endocrina se le giovani pazienti con cancro al seno desiderano una gravidanza? Questa domanda è stata indagata nello studio POSITIVE [2]. Da dicembre 2014 a dicembre 2019, 518 donne di età pari o inferiore a 42 anni che desideravano una gravidanza hanno partecipato allo studio e hanno deciso di interrompere la terapia endocrina per circa due anni. Prima di interrompere il trattamento, le donne avevano completato da 18 a 30 mesi di terapia endocrina adiuvante. Un comitato di monitoraggio della sicurezza dei dati ha condotto tre analisi intermedie sulla sicurezza. Se si fossero verificate più di 46 recidive di cancro al seno nel periodo medio di follow-up di circa tre anni, lo studio avrebbe dovuto essere interrotto. Questa soglia non è stata raggiunta. Ad un follow-up mediano di 41 mesi, 44 partecipanti avevano subito una recidiva di cancro al seno. Il tasso di recidiva a tre anni è stato dell’8,9% – simile al tasso del 9,2% in una coorte di controllo esterna degli studi SOFT/TEXT che studiavano la terapia endocrina adiuvante nelle donne in premenopausa. Tuttavia, alle partecipanti allo studio è stato consigliato di riprendere la terapia endocrina dopo un tentativo o un successo di gravidanza. Ad oggi, il 76,3% ha ripreso la terapia. Questi dati sottolineano la necessità di incorporare l’assistenza alla salute riproduttiva incentrata sulla paziente nel trattamento e nel follow-up delle giovani donne con cancro al seno.
L’estradiolo favorisce le metastasi cerebrali
È stato ipotizzato che gli ormoni della premenopausa, come l’estradiolo (E2), possano promuovere le metastasi cerebrali avendo effetti sul microambiente cerebrale. È noto che l’ormone agisce sugli astrociti ER+ per secernere fattori di crescita che possono attivare le vie di segnalazione che promuovono il tumore nel carcinoma mammario triplo negativo (TNBC). Sia gli estrogeni cerebrali che quelli ovarici possono influenzare il microambiente del tumore cerebrale nelle donne più giovani. I modelli murini di TNBC mostrano che l’ovariectomia da sola o in combinazione con il letrozolo impedisce la colonizzazione del tumore cerebrale e il ripristino dei livelli di E2 in premenopausa promuove la colonizzazione del tumore cerebrale. Combinando diversi modelli murini che imitano l’attuale terapia standard per il TNBC, i ricercatori hanno potuto studiare come la deplezione dell’E2 da sola o in combinazione con l’irradiazione cerebrale possa influire sulla progressione delle metastasi cerebrali esistenti nel TNBC [3]. La soppressione dell’E2 in combinazione con l’irradiazione cerebrale ha dimostrato di ridurre la progressione delle metastasi cerebrali. La soppressione dell’E2 da sola non ha avuto alcun effetto.
La chemioterapia è ben considerata
La chemioterapia è spesso accompagnata da un deterioramento cognitivo associato al tumore. Nello studio RxPONDER, l’influenza della sola terapia endocrina rispetto alla chemio seguita dalla terapia endocrina è stata esaminata in modo più dettagliato [4]. Per questo, sono state incluse 5083 pazienti con tumori metastatici non remoti positivi al recettore ormonale (HR+), HER2-negativi (HER2-) e da uno a tre linfonodi interessati (LN+). I risultati mostrano che il deterioramento cognitivo era maggiore con la chemioterapia più la terapia endocrina rispetto alla sola terapia endocrina. In alcuni casi, queste menomazioni durano più di tre anni. Pertanto, è importante assicurarsi che la chemioterapia venga somministrata solo ai pazienti che ne trarranno realmente beneficio.
Sulla via di una terapia migliore
La comprensione di come e perché si accumulano le mutazioni somatiche è necessaria per fare luce sull’evoluzione del cancro. La replicazione del DNA durante ogni ciclo cellulare è un processo essenziale e altamente regolato che assicura la corretta replicazione dell’intero genoma. La tempistica della replicazione di DANN è stata indirettamente collegata all’acquisizione di mutazioni e all’instabilità del genoma. Tuttavia, l’entità e l’importanza dell’alterazione dei tempi di replicazione (ART) dalle cellule normali a quelle tumorali, e se questo processo influisca direttamente sull’acquisizione delle mutazioni durante lo sviluppo del cancro, non sono ancora stati esplorati. Pertanto, gli effetti dell’ART sono stati studiati analizzando i dati di 1271 genomi interi sequenziati di cancro al polmone e al seno, insieme ai dati di sequenziamento dei tempi di replica di diverse linee cellulari cancerose e normali [5]. È stato riscontrato che il 6-18% del genoma delle cellule tumorali è soggetto ad ART. Le regioni genomiche soggette a un passaggio dalla replicazione precoce a quella tardiva nelle cellule tumorali presentano un aumento del tasso di mutazione nei tumori e sono associate a firme di mutazione diverse rispetto alle regioni invariate con replicazione precoce. Di conseguenza, l’ART è un evento relativamente precoce durante lo sviluppo del cancro al seno. In sintesi, i cambiamenti nella tempistica della replicazione durante la trasformazione maligna sono diffusi e hanno un impatto significativo sul paesaggio genomico e trascrittomico durante l’evoluzione del tumore.
Screening del cancro al seno – l’influenza delle varianti patogene BRCA1/2
Il rischio di recidiva del tumore al seno omolaterale (IBTR) e la prognosi della chirurgia conservativa del seno (BCS) nei portatori della variante germinale patogena BRCA1/2 (BRCA1/2+) rimangono controversi. Pertanto, sono state studiate le differenze nell’IBTR e nella prognosi tra portatori e non portatori di BRCA1/2+ dopo la BCS nel cancro al seno [6]. Sono stati confrontati l’incidenza dell’IBTR e la prognosi, compresa la sopravvivenza globale (OS), la sopravvivenza specifica per il cancro al seno (BCSS) e la sopravvivenza senza recidiva a distanza (DRFS). L’analisi ha incluso 551 pazienti (587 seni con cancro), tra cui 30 portatori di BRCA1+ (32 seni) e 31 portatori di BRCA2+ (32 seni). Il tempo di follow-up mediano è stato di 5,8 anni. Tra i portatori, il tumore al seno aveva maggiori probabilità di essere negativo per il recettore degli estrogeni (56,2% per i portatori BRCA1+ e 15,6% per i portatori BRCA2+ rispetto al 22,0% per i non portatori), negativo per il recettore del progesterone (62,5% per i portatori BRCA1+ e 31,3% per i portatori BRCA2+ rispetto al 29,5%. 29,5%), nucleo di grado III (45,3% per le portatrici vs. 29,5% per le non portatrici) o un indice Ki-67 più alto (indice Ki-67 >20) (89,5% vs. 61,8%) rispetto alle non portatrici. Inoltre, i portatori sono stati sottoposti a chemioterapia più spesso dei non portatori (62,5% contro 42,4%). Lo stadio del cancro, le dimensioni del tumore, lo stato HER2, la presenza di invasione linfatica e il tasso di margini chirurgici positivi o stretti non differivano statisticamente tra i gruppi studiati.
Durante il follow-up, è stato riscontrato che nove seni di portatori di BRCA1/2+ (15,6%/12,5%) e 35 seni (6,7%) di non portatori hanno sviluppato IBTR. Quando sono state escluse le pazienti che non si sono sottoposte a radioterapia, il tasso di IBTR è rimasto significativamente più alto nelle portatrici di BRCA1/2+. Il tempo mediano all’IBTR è stato di 10,2 anni per i portatori (10,2 anni per BRCA1+ e 8,5 anni per BRCA2+) e di 3,5 anni per i non portatori. I portatori avevano maggiori probabilità rispetto ai non portatori di avere diversi sottotipi di tumori ricorrenti nel seno omolaterale (66,7% contro 19,4%), che si sono verificati in un quadrante diverso dal tumore primario (50,0% contro 27,3%). Non sono state osservate differenze significative in OS, BCSS o DRFS.
Congresso: Simposio sul cancro al seno di San Antonio (SABCS)
Letteratura:
- Boughey JC, et al: Impatto della terapia di conservazione del seno sulla recidiva locale nelle pazienti con cancro al seno multiplo ipsilaterale – Risultati di ACOSOG Z11102 (Alleanza). GS4-01. 10.12.2022. SABCS 2022.
- Partrige A, et al: Esito della gravidanza e sicurezza dell’interruzione della terapia per le donne con carcinoma mammario responsivo al sistema endocrino: risultati primari dello studio POSITIVE (IBCSG 48-14 / BIG 8-13). GS4-09. 10.12.2022. SABCS 2022.
- Cittely D, et al: L’estradiolo reprime la risposta immunitaria antitumorale per promuovere la progressione delle metastasi cerebrali ER. GS5-07. 10.12.2022. SABCS 2022.
- Kang I, et al: Rx per il cancro al seno con linfonodo positivo e responsivo al sistema endocrino. GS1-04. 10.12.2022. SABCS 2022.
- Kanu N, et al: Implicazioni cliniche dell’eterogeneità tumorale della genomica delle cellule singole. 06.12.2022. SABCS 2022.
- Kondo S, Kumiko K, Misato S, et al.: Impatto delle varianti patogene BRCA1/2 sulla recidiva del tumore al seno omolaterale e sulla prognosi dopo la chirurgia conservativa del seno. P1-09-03. 06.12.2022. SABCS 2022.
InFo ONCOLOGIA & EMATOLOGIA 2023; 11(1): 28-29