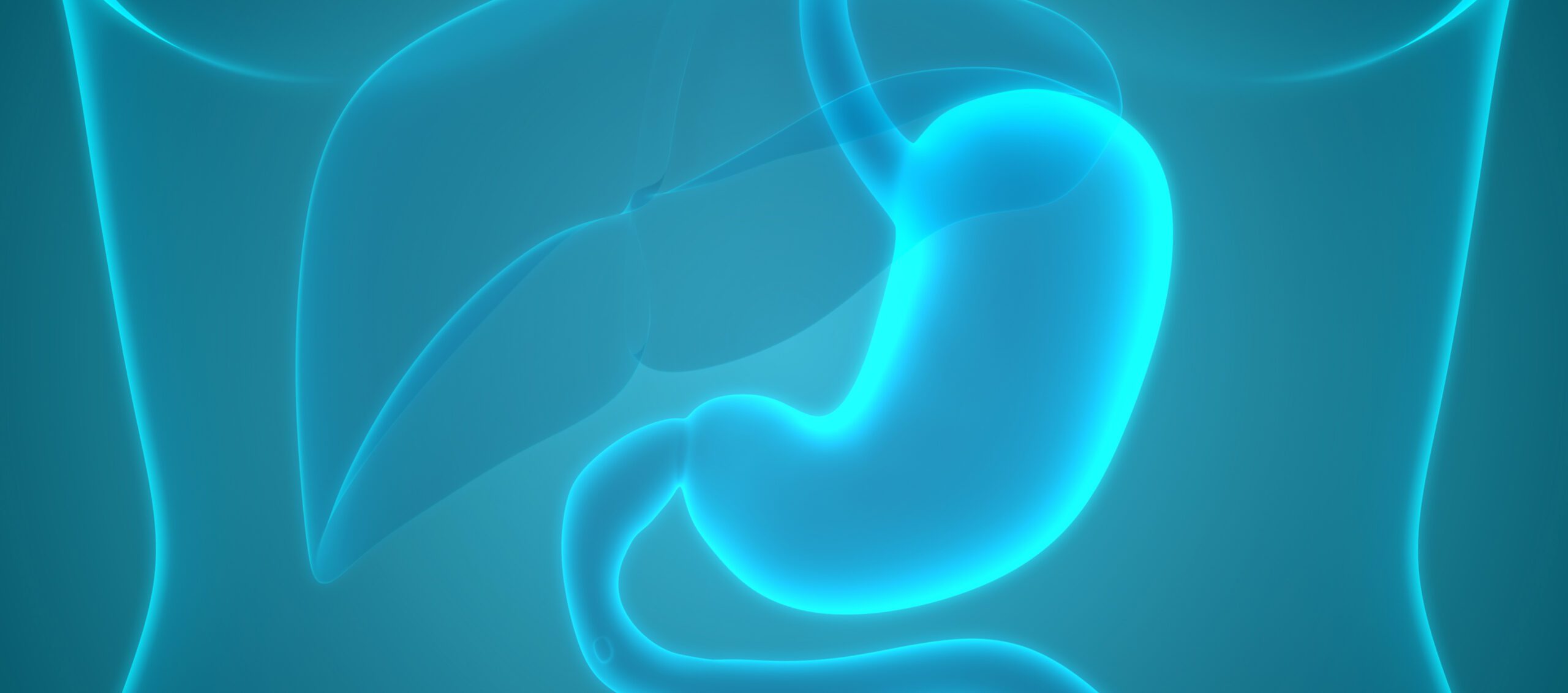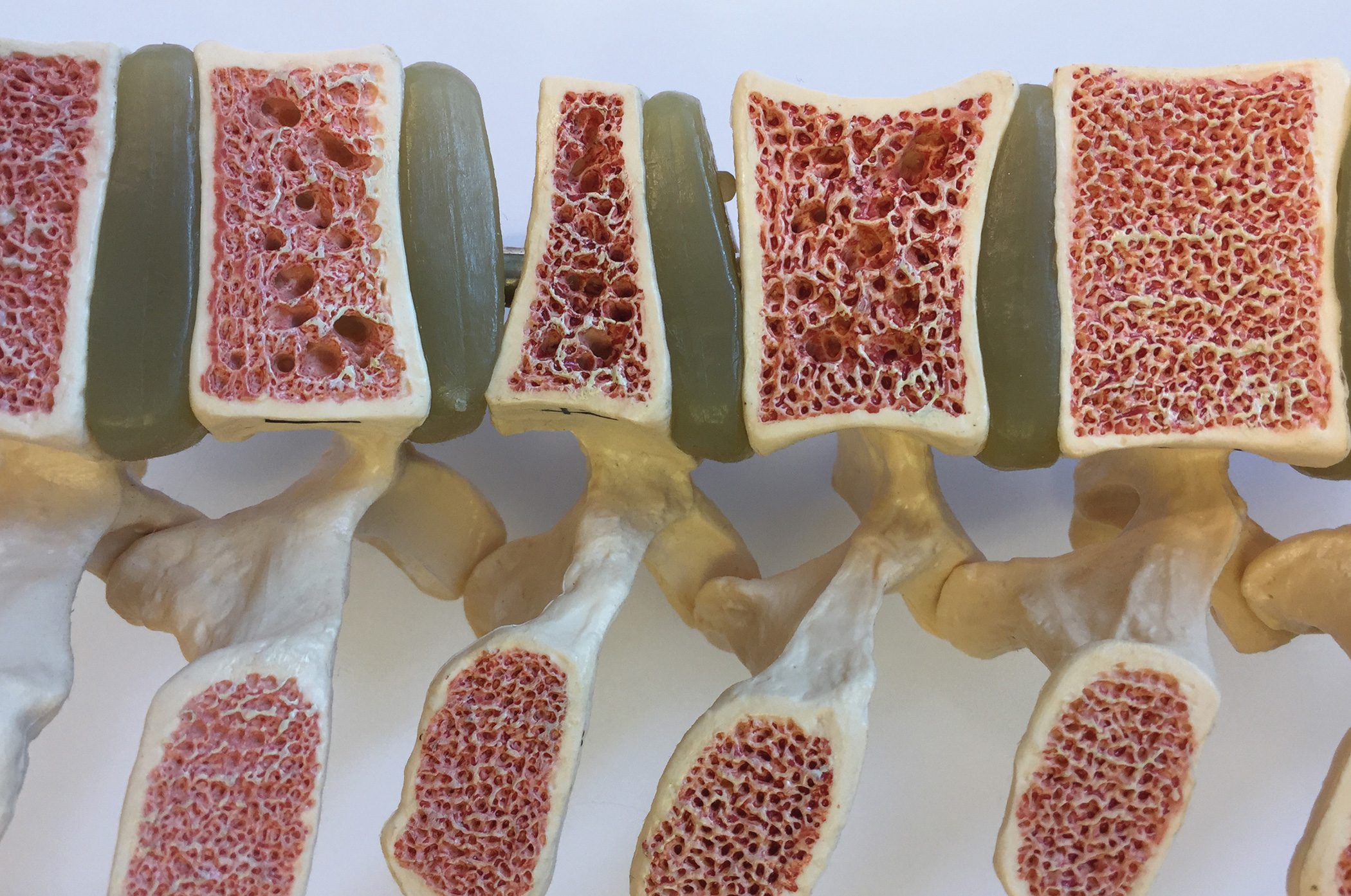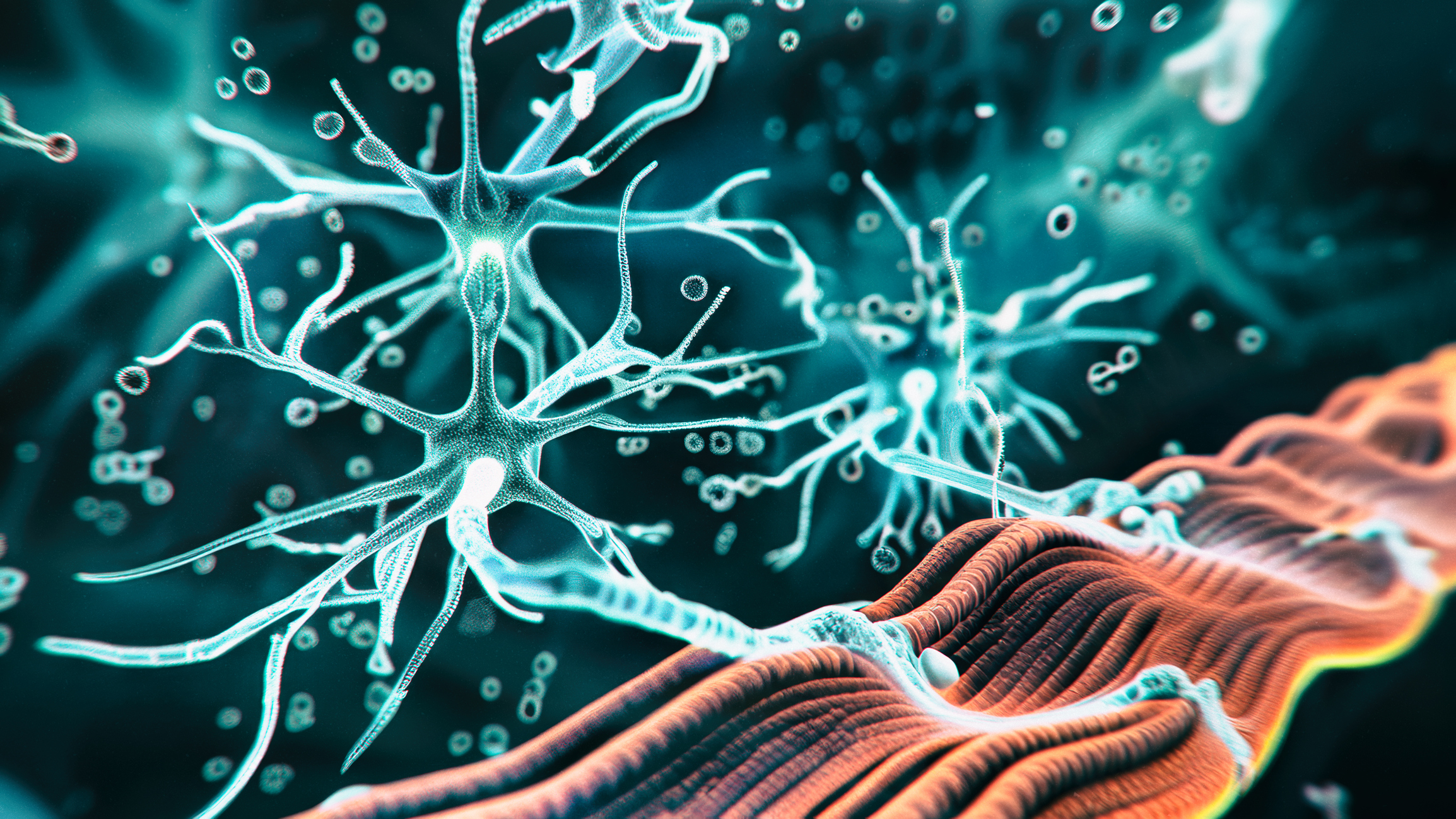Il tema principale del congresso era “Persone con epilessia – crisi epilettiche e non solo”. Oltre a simposi di alta qualità scientifica e all’avanguardia su argomenti attuali relativi alla diagnosi e al trattamento delle crisi e dell’epilessia, l’obiettivo era quindi quello di dare spazio a contributi incentrati sulle aree periferiche dell’epilettologia. Questo include, ad esempio, gli effetti cognitivi ed emotivi, ma anche gli aspetti della partecipazione all’istruzione, al lavoro e alla società.
Il lavoro precedente suggerisce che la disfunzione della barriera emato-encefalica può essere sia una causa che una conseguenza dell’attività epilettica. La disfunzione della barriera emato-encefalica è anche associata all’accumulo extravascolare di ferro. Uno studio ha quindi esaminato l’ipotesi se il ferro si accumuli a livello extravascolare nelle persone con epilessia focale e se questo possa essere rilevato utilizzando l’imaging pesato con suscettibilità (SWI) a campo ultraelevato (7T) [1]. A tale scopo, sono state incluse in modo prospettico 32 persone con epilessia focale. Inoltre, è stata inclusa una coorte sana come gruppo di controllo. Le immagini pesate in T1 (dimensione del voxel 0,6 mm) e SWI (dimensione del voxel 0,4 mm) sono state acquisite con la risonanza magnetica a 7 Tesla. L’elaborazione ha incluso la correzione del movimento, il denoising e la correzione del campo di polarizzazione. I valori di suscettibilità sono stati confrontati tra le coorti di controllo e di epilessia utilizzando un modello di regressione lineare con età e sesso come covariati.
Rispetto ai controlli, i soggetti con epilessia focale hanno mostrato una suscettibilità significativamente più alta nelle regioni corticali e sottocorticali. Gli individui con zona di origine delle crisi temporali hanno mostrato una suscettibilità più elevata in entrambi gli ippocampi, le amigdale e i nuclei caudati, nonché nel talamo e nel putamen dell’emisfero colpito e nelle regioni corticali, prevalentemente nell’emisfero colpito, rispetto ai controlli. Gli individui con zona di origine delle crisi extratemporali hanno mostrato una suscettibilità significativamente più alta nelle regioni di entrambe le cortecce, così come nei gangli basali di entrambi gli emisferi.
Biomarcatori che utilizzano l’analisi della frequenza cardiaca
Le crisi epilettiche sono un tipo di crisi clinicamente rilevante che finora ha ricevuto poca attenzione scientifica e non è elencato nell’attuale classificazione ILAE. Sono definite come crisi la cui unica caratteristica semiologica è un risveglio dal sonno. L’attività ictale non viene rilevata con sufficiente sensibilità dalle registrazioni EEG superficiali, per cui questo tipo di crisi può apparire erroneamente come risvegli fisiologici. Gli EEG intracranici e superficiali simultanei offrono quindi un’opportunità unica per studiare i meccanismi neurofisiologici dei risvegli epilettici e potrebbero consentire lo sviluppo di un metodo di rilevamento quantitativo basato su biomarcatori per contesti clinici non invasivi. L’obiettivo di uno studio è stato quello di identificare i biomarcatori per i risvegli epilettici e fisiologici basati sull’analisi della frequenza cardiaca [2].
Sono state eseguite registrazioni video EEG intracraniche e superficiali simultanee con elettrocardiografia (ECG) e i risvegli epilettici sono stati analizzati in modo specifico per il paziente. I risvegli fisiologici sono stati abbinati alla data e alla fase del sonno. Sono stati sviluppati algoritmi di rilevamento di R-spike per misurare la frequenza cardiaca. I confronti quantitativi sono stati applicati in finestre temporali definite di 50 secondi prima (pre) e dopo (post) il risveglio per i risvegli epilettici e fisiologici.
In 190 notti, sono stati analizzati 135 risvegli epilettici in 20 pazienti con epilessie focali. Nel 63,7% dei risvegli epilettici, non è stato possibile rilevare alcun modello ictale dall’EEG di superficie. L’analisi della frequenza cardiaca è stata eseguita in 13 pazienti con 83 risvegli epilettici e 81 risvegli fisiologici. Sia i risvegli epilettici che quelli fisiologici hanno mostrato un aumento della frequenza cardiaca tra le finestre temporali pre e post. La latenza tra l’eccitazione e il picco della frequenza cardiaca era significativamente diversa tra le eccitazioni epilettiche e fisiologiche.
È stata dimostrata la chiara necessità di un biomarcatore non invasivo, in quanto quasi due terzi dei risvegli epilettici non erano rilevabili dagli EEG di superficie. I risvegli epilettici e fisiologici portano a un aumento della frequenza cardiaca, ma mostrano relazioni temporali diverse: I risvegli fisiologici mostrano una modulazione mediamente più tardiva ma coerente della frequenza cardiaca, in contrasto con i risvegli epilettici con cambiamenti mediamente più precoci ma eterogenei. La variabilità dei cambiamenti della frequenza cardiaca durante i risvegli epilettici riflette la diversità delle crisi epilettiche. La diversità delle dinamiche della frequenza cardiaca suggerisce la possibilità di sviluppare un biomarcatore che aiuti a migliorare il rilevamento e la diagnosi di questo sottile tipo di crisi epilettica.
Diagnostica genetica per i neonati
Le crisi epilettiche neonatali (frequenza stimata: 2,29 casi/1000 nati vivi LG) sono definite dal momento in cui si verificano: nei neonati maturi (1,10 casi/1000 LG) nelle prime quattro settimane post partum, nei neonati prematuri (14,28 casi/1000 LG) nelle prime 44 settimane di età gestazionale. Lo spettro dell’eziologia comprende principalmente cause strutturali, vascolari, epilettiche, metaboliche e genetiche. Per quanto riguarda le cause genetiche, è particolarmente rilevante la questione di quando è utile una diagnosi corrispondente dopo che sono state escluse altre cause. Uno studio ha analizzato più da vicino questo aspetto [3]. [57,9%] [42,8%] [57,9%] [42,8%]In uno studio retrospettivo trasversale, 19 neonati (maschi: n=11 , femmine: n=8 ; neonati maturi: n=11 , neonati prematuri: n=8 ) con crisi neonatali sono stati inclusi in un’analisi di tre centri (centro perinatale di livello 1 in due siti) con n=12 154 neonati nati (compresi 174 neonati prematuri <1500 g di peso alla nascita) negli anni 2022-2023. La diagnosi genetica è stata eseguita nel 15% dei neonati. Oltre alle spiegazioni fisiopatologiche note per le crisi epilettiche intorno alla nascita, giocano un ruolo anche le cause genetiche, la cui diagnosi precoce ha un significato terapeutico e prognostico. I test genetici dovrebbero quindi essere eseguiti precocemente, se nessuna chiara connessione fisiopatologica sembra sufficiente a spiegare i sintomi. Soprattutto nel caso di dismorfie/malformazioni e di encefalopatie epilettiche, un chiarimento eziologico precoce può portare a un ulteriore trattamento e, se necessario, a una modifica degli obiettivi terapeutici. Nel complesso, l’indicazione per la diagnostica genetica dovrebbe essere data con generosità, anche nel caso di spiegazioni fisiopatologicamente significative come l’ictus neonatale, a causa delle mutazioni sempre più rilevanti in termini di conseguenze terapeutiche.
Crisi funzionali o epilessia?
La diagnosi differenziale delle crisi epilettiche e funzionali (EA o FA) rimane un compito complesso per gli epilettologi. Sono stati sviluppati alcuni nuovi interessanti strumenti di screening per accelerare la diagnosi corretta e il trattamento appropriato [4]. In sintesi, la sensibilità degli strumenti è del 74%-95% (n=8), la specificità è del %–86% (n=8), l’accuratezza è compresa tra %–87% (n=6) e i valori AUC sono compresi tra 0,74-0,97 (n=6). In termini di criteri statistici, la migliore performance è stata quella del calcolatore di rischio DDESVSFS, che sembra essere fattibile nella pratica clinica con otto voci ed è disponibile gratuitamente. Dal punto di vista metodologico, sarebbero utili delle convalide statistiche rigorose di tutti questi strumenti ancora nuovi, nell’ambito di progetti di ricerca indipendenti. Per valutare ulteriormente la riproducibilità e la generalizzabilità, sarebbero di particolare interesse i dati provenienti da diversi contesti clinici. Con una base di prove più ampia, alcuni degli strumenti descritti potrebbero dare un contributo prezioso alla diagnosi differenziale più efficiente delle EA e delle FA in futuro.
Crisi epilettica durante il ciclismo
Nell’ambito della transizione della mobilità, sempre più spostamenti vengono effettuati in bicicletta o in Pedelec (biciclette con pedalata assistita elettrica fino a 25 km/h), che hanno lo stesso status ai sensi del codice della strada. Pertanto, è necessario valutare il rischio di incidenti delle persone con epilessia (PWD) che utilizzano biciclette o pedelec [5]. A tale scopo, è stato determinato il rischio annuale generale di incidenti gravi/fatali in bicicletta e pedelec (rischio di base), differenziato per fascia d’età, sulla base del Rapporto sulla mobilità 2017, delle statistiche sugli incidenti del 2017 di DESTATIS e dei rapporti della Ricerca sugli incidenti degli assicuratori 2017 e 2022. Inoltre, il rischio specifico di epilessia per gli incidenti gravi e mortali è stato stimato utilizzando la metodologia sviluppata dalla Commissione Europea sulle Patenti di Guida per stimare il rischio di incidenti automobilistici (approccio COSY). È stato rilevato un rischio di base per gli incidenti gravi o mortali di bicicletta 1:3570; pedelec 1:2940; auto 1:1470. Il rischio di incidente per le biciclette e i Pedelec aumenta con l’età; i giovani ciclisti di Pedelec di età compresa tra i 18 e i 34 anni rappresentano un secondo gruppo a rischio. Il rischio di incidente aumenta in proporzione al tempo di viaggio giornaliero. Con l’uso regolare di un Pedelec e un COSY del 20%, il rischio si accumula in 5 anni da 1:570 a 1:110.
Il rischio di incidente per le persone con disabilità che hanno un COSY del 20% è simile per auto, biciclette e pedelec. Aumenta notevolmente se si prevede ≥1 sequestro all’anno. Il rischio è significativamente più alto per i pedelec rispetto alle biciclette. Ai pazienti con ≥1 attacco all’anno deve essere offerta una consulenza speciale in cui si evidenziano le differenze di rischio tra la guida della bicicletta e del Pedelec, tra il normale traffico di veicoli a motore, su strade con piste ciclabili e su piste ciclabili in aree ricreative, nonché gli ausili legali per la mobilità.
Comorbilità depressiva
Molti pazienti sperimentano una riduzione significativa della loro qualità di vita a causa dell’epilessia. Diversi fattori, come gli effetti collaterali dei farmaci, l’elevata frequenza delle crisi, la stigmatizzazione e le malattie psichiatriche sono stati identificati come cause di questo fenomeno. I sintomi di depressione sono presenti in circa il 10% della popolazione generale tedesca nei test di screening, e i pazienti epilettici hanno un rischio da 3 a 5 volte superiore di sviluppare la depressione. Una coorte trasversale di pazienti con epilessia è stata esaminata per la presenza di sintomi di depressione e la caratterizzazione del trattamento con soppressori di crisi stabilizzanti dell’umore, antidepressivi e neurolettici, nonché l’accesso al trattamento neurologico e psichiatrico [6].
Sono stati analizzati 471 adulti con epilessia e un’età media di 40 anni (58,4% donne). Un punteggio HADS-D di ≥8 è stato riscontrato nel 34%, indicando la presenza di sintomi depressivi. Di questi pazienti, solo il 13,8% aveva ricevuto un trattamento psichiatrico o psicoterapeutico, mentre circa due terzi (68,8%) avevano ricevuto un trattamento neurologico nei tre mesi precedenti. La terapia soppressiva delle crisi stabilizzatrici dell’umore con carbamazepina, lamotrigina o valproato è stata utilizzata nel 51,3% dei pazienti con sintomi di depressione e non differiva dalla frequenza (56,3%) di utilizzo della terapia soppressiva delle crisi stabilizzatrici dell’umore nei pazienti senza sintomi di depressione. Dei pazienti con sintomi di depressione, il 15% ha ricevuto una terapia antidepressiva e il 5% una terapia neurolettica.
Congresso: Conferenza annuale della Società tedesca di epilettologia (DGfE)
Letteratura:
- Heldt NR, et al: L’imaging ad altissimo campo pesato con suscettibilità nell’epilessia focale indica un accumulo di ferro corticale e sottocorticale. Abstract FV01. 62° Riunione annuale della Società tedesca di epilettologia (DGfE), 12-15 giugno 2024, Offenburg.
- Fisel L, et al: Risvegli epilettici – analisi della frequenza cardiaca per il rilevamento di biomarcatori negli EEG intracranici e superficiali simultanei. Abstract FV05. 62esima Riunione Annuale della Società Tedesca di Epilettologia (DGfE), 12-15 giugno 2024, Offenburg.
- Krampe-Heni F, et al.: Diagnostica genetica nelle crisi epilettiche neonatali. Abstract FV14. 62° Meeting annuale della Società tedesca di epilettologia (DGfE), 12-15 giugno 2024, Offenburg.
- Rosenkötter U, et al: Epilessia o crisi funzionali? Un confronto sistematico dei più recenti strumenti di screening per supportare la diagnosi differenziale. Abstract FV19. 62esima Riunione Annuale della Società Tedesca di Epilettologia (DGfE), 12-15 giugno 2024, Offenburg.
- Thorbecke R, et al: Rischio di incidenti legati a crisi epilettiche in persone con epilessia che vanno in bicicletta o in Pedelec – implicazioni per la consulenza. Abstract eP71. 62esima Riunione Annuale della Società Tedesca di Epilettologia (DGfE), 12-15 giugno 2024, Offenburg.
- Hock S, et al: Frequenza dei sintomi depressivi (HADS-D) negli adulti con epilessia e trattamento con soppressori delle crisi, antidepressivi e neurolettici stabilizzanti dell’umore e accesso al trattamento neurologico e psichiatrico. Abstract eP62. 62° Riunione annuale della Società tedesca di epilettologia (DGfE), 12-15 giugno 2024, Offenburg.
InFo NEUROLOGIA & PSICHIATRIA 2024; 22(4): 24-25 (pubblicato il 26.8.24, prima della stampa)