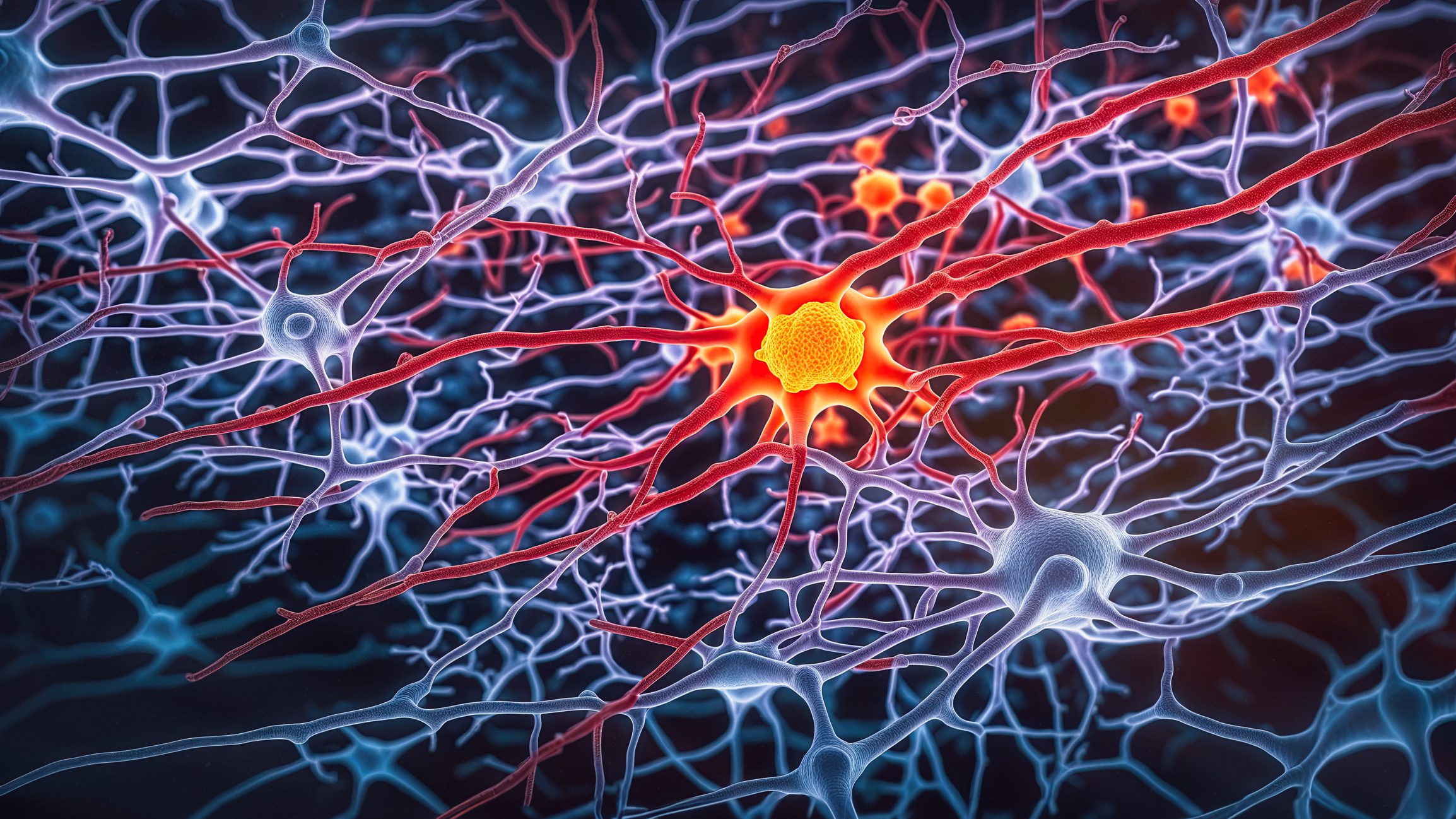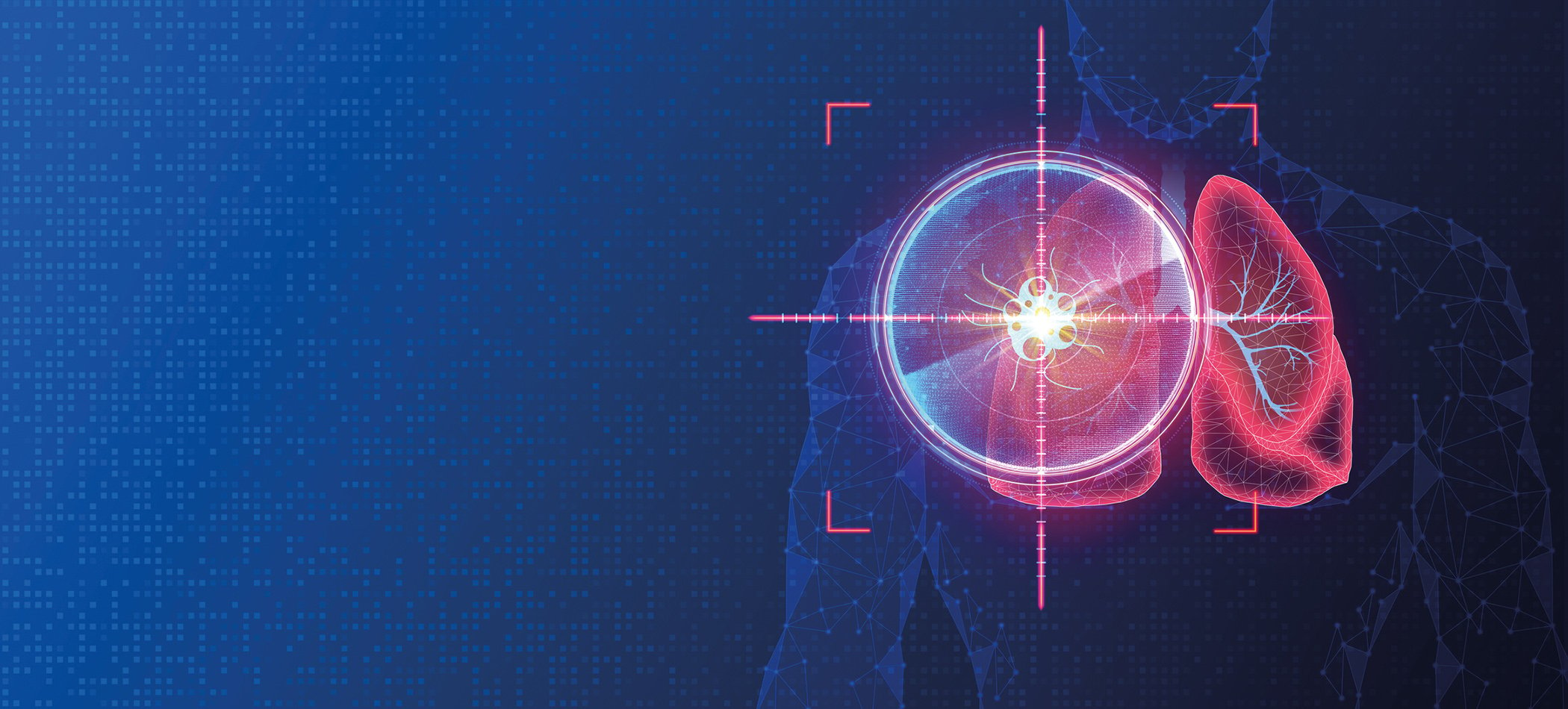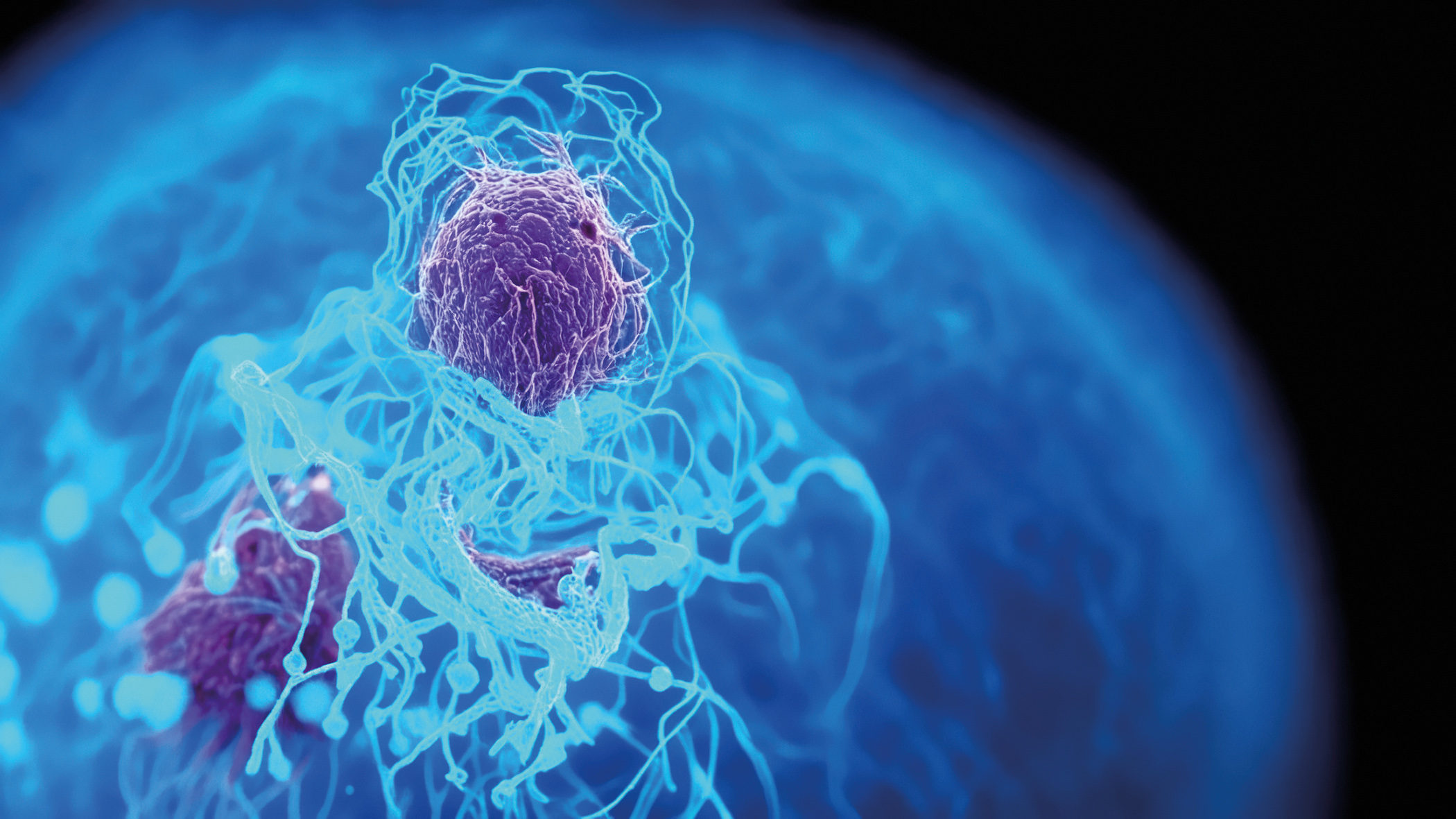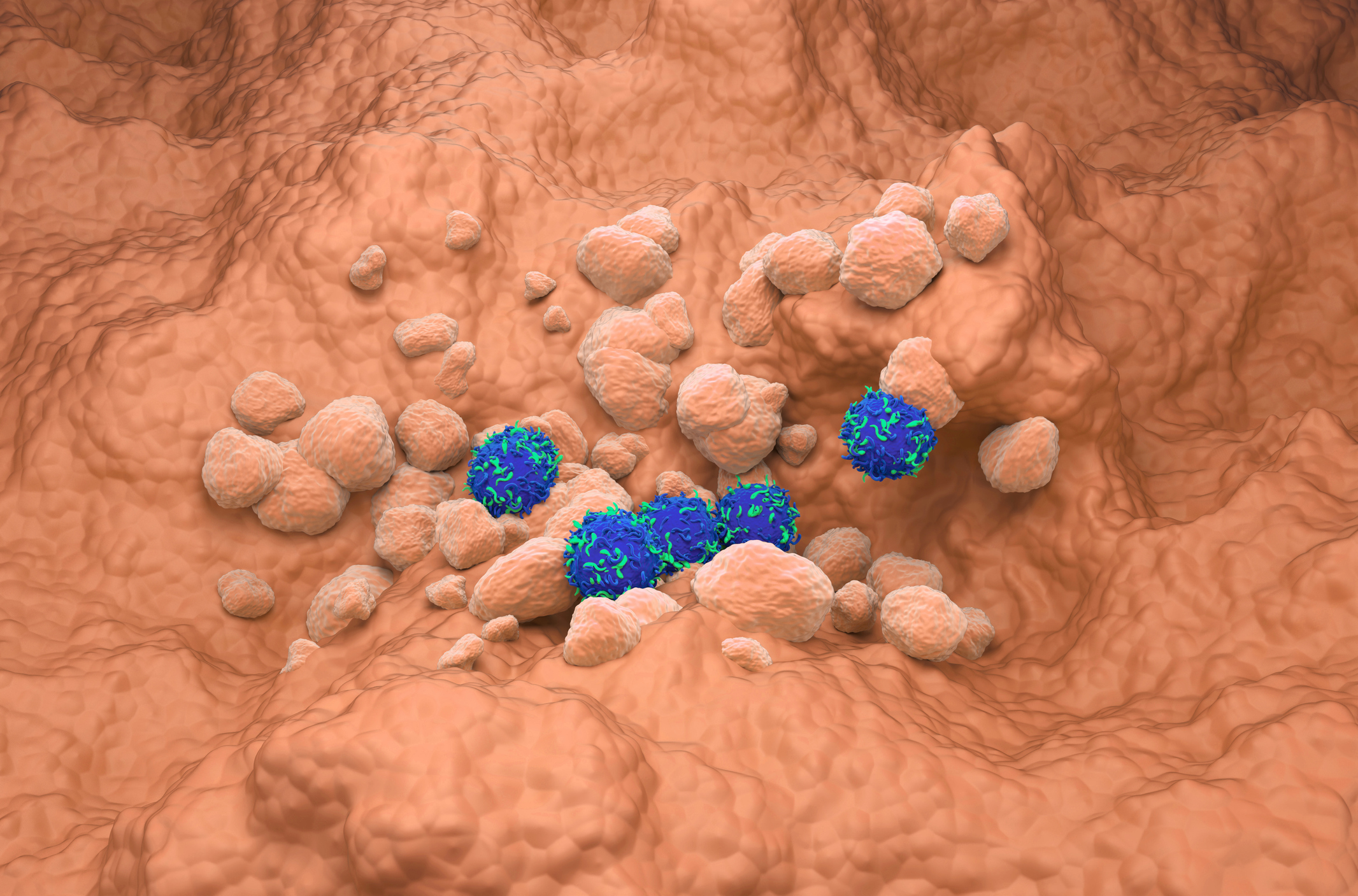I linfomi primari cutanei sono un gruppo eterogeneo di neoplasie linfoproliferative a cellule T o B. I linfomi cutanei sono una delle forme rare di cancro della pelle. L’ispezione clinica ha un ruolo importante nella diagnosi. Il sospetto diagnostico è spesso confermato dai successivi esami istologici e immunoistochimici. Le opzioni di trattamento dipendono, tra l’altro, dallo stadio della malattia tumorale. Soprattutto nel campo dei linfomi cutanei a cellule T, sono state sviluppate nuove interessanti strategie terapeutiche.
La valutazione della presentazione clinica è di grande importanza nella diagnosi del linfoma cutaneo [1]. Oltre all’ispezione dell’intero tegumento, l’esame clinico iniziale deve includere la palpazione di tutte le stazioni linfonodali. Se una manifestazione cutanea non corrisponde al quadro clinico classico, potrebbe trattarsi di un coinvolgimento cutaneo secondario di un linfoma extracutaneo. Si tratta di un’importante distinzione diagnostica differenziale, ha spiegato il Prof. Reinhard Dummer, MD, vice capo del Dipartimento di Medicina. Direttore della Clinica di Dermatologia e Responsabile del Centro Tumori della Pelle, Ospedale Universitario di Zurigo [2]. I linfomi cutanei appartengono al gruppo dei cosiddetti linfomi non-Hodgkin extranodali. I linfomi cutanei primari si manifestano inizialmente nella pelle e non mostrano alcun coinvolgimento di altri organi al momento della diagnosi, mentre nei linfomi cutanei secondari i sintomi cutanei sono manifestazioni di linfomi primari nodali disseminati o di leucemie [1]. I linfomi cutanei primari si dividono in linfomi cutanei a cellule B (CBCL) e linfomi a cellule T (CTCL), oltre a forme più rare, in base alle caratteristiche cliniche e patoistologiche [1]. Le prime sono di gran lunga le più comuni [1]. Quali fattori causino lo sviluppo di mutazioni rilevanti per il tumore non è ancora stato chiarito.
CBCL – l’occhio esperto dello specialista e l’istologia sono centrali
Per i medici esperti, è possibile fare una diagnosi provvisoria del tipo di linfoma a cellule B presente in base alle dimensioni e alla distribuzione delle lesioni, spiega il Prof. Dummer [2]. La maggior parte dei linfomi cutanei primari a cellule B (CBCL) corrisponde a uno dei seguenti sottotipi:
Linfoma della zona marginale: caratteristico sono molte piccole placche e noduli eritematosi isolati o multipli, senza ulcerazione, con un diametro massimo di circa 2 – 3 cm [2,3]. Le estremità e il tronco sono più comunemente colpiti.
Linfoma primario cutaneo del centro germinale (linfoma follicolare a cellule B): lesioni solitarie o raggruppate, da blu-rosso a rosso-marrone, tipicamente più grandi (>3 cm), nodulari, a volte simili a placche [4]. In genere, viene colpita l’attaccatura dei capelli o la parte superiore del tronco. Le lesioni agli arti inferiori hanno una prognosi meno favorevole.
Linfoma diffuso a grandi cellule B: placche eritemato-livido multiple in rapida espansione o noduli tumorali che confluiscono in focolai più grandi e si ulcerano nel corso del decorso [4]. Le pazienti di sesso femminile di età superiore ai 70 anni sono più frequentemente colpite.
Un esame istologico supplementare può spesso confermare il sospetto diagnostico. A tal fine, si consiglia una biopsia con punch. Oltre all’esame immunoistochimico, si possono effettuare ulteriori accertamenti (ad esempio, una sonografia linfonodale) per assicurarsi che non si tratti di una manifestazione secondaria di un linfoma extranodulare. Una “analisi delle singole cellule” dei linfomi cutanei a cellule B mostra che la percentuale di cellule B clonali è inferiore al 10%, soprattutto nei linfomi della zona marginale. Questa è una spiegazione del fatto che la biologia molecolare è piuttosto inaffidabile nei linfomi cutanei e perché il test di clonalità è negativo nella metà dei casi, ha detto il relatore. I CBCL senza altre manifestazioni hanno una prognosi molto più favorevole rispetto ai linfomi a cellule B nodali. In molti casi, la terapia locale è sufficiente. C’è anche la possibilità di una rimozione chirurgica o di una radioterapia. In singoli casi, la terapia con interferone può portare alla remissione completa. Secondo la linea guida, la polichemioterapia è indicata solo per le manifestazioni extracutanee [1].

CTCL – ci sono alcuni approcci terapeutici innovativi
I linfomi primari cutanei a cellule T (CTCL) sono un gruppo eterogeneo di linfomi che insorgono nella pelle e non mostrano segni di malattia extracutanea al momento della diagnosi. I sottotipi di CTCL presentano una varietà di caratteristiche cliniche, istologiche e molecolari e possono avere un decorso indolente o molto aggressivo [5]. Si distingue essenzialmente tra micosi fungoide (Fig. 1), sindrome di Sézary, linfomi CD30+ ed entità rare. La diagnosi si basa sull’integrazione dei risultati clinici e patologici. Per la stadiazione del CTCL si utilizza la classificazione TNM secondo Olsen (Tab. 1) [8].

Nel campo della ricerca traslazionale e dello sviluppo di nuove terapie farmacologiche, sono successe molte cose nel recente passato, tra cui l’approvazione sul mercato delle terapie a base di anticorpi mogamulizumab e brentuximab (Fig. 2) [8]. Le chemochine sono note per essere citochine chemiotattiche coinvolte nell’imprinting delle cellule T naïve e nella funzione delle cellule T regolatorie, tra le altre cose [6]. Come è ormai noto, i linfociti che si dirigono verso la pelle esprimono alcuni recettori per le chemochine. Il recettore delle chemochine C-C di tipo 4 (CCR4) è frequentemente espresso sulle cellule tumorali del linfoma cutaneo a cellule T. Mogamulizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato che si lega al CCR4 e quindi distrugge le cellule T degenerate. Mentre i trattamenti come il metotrexato riducono sia i linfociti normali che quelli tumorali, l’anticorpo mogamulizumab riduce selettivamente le cellule clonali. “Con questa riduzione delle cellule clonali, i linfociti sani hanno di nuovo più spazio e possiamo quindi aiutare il sistema immunitario di questi pazienti a migliorare di nuovo”, ha detto il relatore. Il mogamulizumab (Poteligeo®) è approvato in Svizzera per il trattamento di pazienti adulti con micosi fungoide recidivata o refrattaria o sindrome di Sézary, con efficacia insufficiente di almeno una precedente terapia sistemica [7]. “L’altro nuovo farmaco ora molto utilizzato è il brentuximab”, riferisce il Prof. Dummer [2]. Si tratta di un anticorpo che trasporta una tossina che attacca l’antigene CD30 sulle cellule T maligne e uccide questa popolazione cellulare. In Svizzera, il brentuximab (Adcetris®) è indicato per i pazienti adulti con linfoma cutaneo a cellule T CD30+ che mostrano una progressione con la terapia sistemica o che non sono adatti ad altre terapie sistemiche [7]. Anche i pazienti con micosi fungoide convenzionale, caratterizzata da una bassa espressione di CD30, possono essere trattati con successo, spiega il relatore.

Neoplasia blastica delle cellule dendritiche plasmacitoidi (BPDCN)
La BPDCN è una neoplasia ematologica molto rara e di solito aggressiva dei precursori immaturi delle cellule dendritiche plasmacitoidi con carattere mieloide e linfoide [3]. Le lesioni cutanee singolari o multiloculari, spesso contusiformi, sono la manifestazione iniziale più comune. Il Prof. Dummer descrive il caso di un paziente che ha avuto una diagnosi clinica sospetta, confermata dall’istologia/biopsia e dall’immunofenotipizzazione (CD4, CD56, CD123, TCL-1) [2]. L’aspetto rossastro-livido è molto caratteristico della BPDCN. “Sembra un’emorragia”, aggiunge il relatore [2]. A seconda dell’età, delle comorbidità, delle condizioni generali e delle preferenze del paziente, nonché della disponibilità di una donazione di cellule staminali allogeniche, viene eseguito un trattamento intensivo di induzione seguito da un trapianto di cellule staminali potenzialmente curativo o da una terapia meno intensiva orientata ai sintomi con intento non curativo [3]. Una nuova opzione di terapia farmacologica è stata approvata nell’UE dal novembre 2020. Tagraxofusp può essere utilizzato come monoterapia per il trattamento di prima linea dei pazienti adulti con BPDCN. Consiste in una proteina di fusione tronca della tossina difterica (DT) legata all’interleuchina-3 (IL-3) umana ricombinante per colpire le cellule che esprimono il CD123. Tagraxofusp inibisce in modo irreversibile la sintesi proteica delle cellule bersaglio, inattivando il fattore di allungamento, portando all’apoptosi [1]. Questa opzione terapeutica non è attualmente approvata in Svizzera.
Congresso: Settimana di formazione avanzata in dermatologia e venereologia pratica
Letteratura:
- Dippel E, et al: S2k-Guidelines – Linfomi cutanei (ICD10 C82 – C86): Aggiornamento 2021. J Dtsch Dermatol Ges 2022; 20(4): 537-554.
- “Aggiornamento della diagnosi e della terapia dei tumori rari e dei linfomi cutanei”, Prof. Dr. med. Reinhard Dummer, 28esima Settimana di formazione avanzata di Dermatologia e Venereologia pratica, 12.-16.07.2022.
- Onkopedia, www.onkopedia.com/de, (ultimo accesso 16.09.2022)
- Heinzerling L, et al: Linfomi cutanei. In: Terapia tumorale basata su farmaci in dermato-oncologia. 2014; Springer: Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-24837-5_3
- Dummer R, et al.: Linfoma cutaneo a cellule T. Nat Rev Dis Primers 2021; 7(1): 61.
- Huck BR, Kçtzner L, Urbahns K: Piccole molecole, grande tempo: terapie di combinazione immuno-oncologiche con piccole molecole. Angew Chem 2018; 130: 4499-4516.
- Informazioni sui farmaci, www.swissmedicinfo.ch, (ultimo accesso 16.09.2022)
- Pujol RM, Gallardo F: Linfomi cutanei – Parte I: Micosi Fungoide, Sindrome di Sézary e disordini linfoproliferativi cutanei CD30+. Actas Dermosifiliogr 2021; 112(1): 14-23.
- Olsen E, et al: Revisioni della stadiazione e della classificazione della micosi fungoide e della sindrome di Sezary: una proposta della Società Internazionale per i Linfomi Cutanei (ISCL) e della task force sul linfoma cutaneo dell’Organizzazione Europea per la Ricerca e il Trattamento del Cancro (EORTC). Sangue 2007; 110: 1713-1722.
PRATICA DERMATOLOGICA 2022; 32(5): 30-31
InFo ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA 2022; 10(5): 32-33